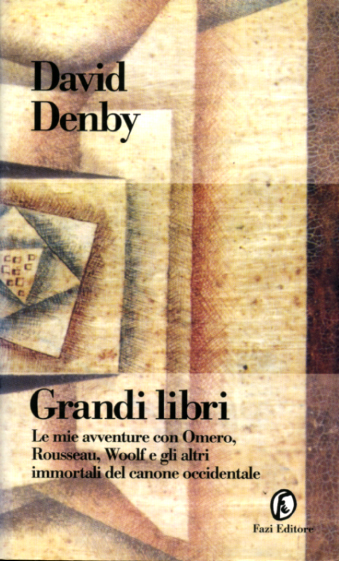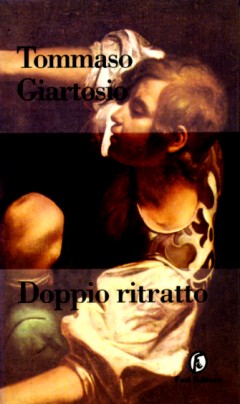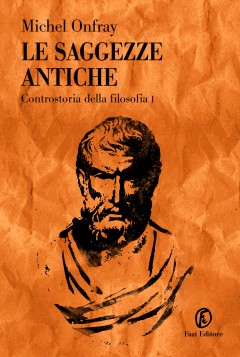David Denby
Grandi libri
Le mie avventure con Omero, Rousseau, Woolf e gli altri immortali del canone occidentale
Traduzione di Lucia Olivieri
A 48 anni, il critico cinematografico David Denby, alla ricerca della propria identità perduta nella nebbia delle immagini mediatiche, ritorna all’università e frequenta due corsi sui classici della letteratura e della filosofia dell’Occidente. Un’avventura che nasce dal desiderio di partecipare all’assillante dibattito tra la sinistra e la destra accademica sui cosiddetti corsi del canone occidentale. Denby ci conduce così in un viaggio, ora suggestivo, ora commovente, attraverso un’ampia collezione di grandi libri. Riscopre e s’innamora di Omero, di Platone, dei tragici greci e di Virgilio, dell’Antico e del Nuovo Testamento, di sant’Agostino, Boccaccio, Shakespeare, Jane Austen? Marx, Nietzsche e Virginia Woolf, e ricrea con vivida efficacia l’atmosfera delle lezioni, i metodi d’insegnamento di un gruppo di docenti brillanti e dotati, e le difficoltà degli studenti, cresciuti nel mondo dei mass media e spesso spaventati dalla complessità dei testi. Il risultato è un’opera straordinaria che fonde autobiografia, giornalismo, introspezione e critica letteraria (da “dilettante dei libri” come si definisce lo stesso autore). Grandi libri è una riflessione sull’America degli anni Novanta attraverso gli occhi di un uomo che ne vive in prima persona le contraddizioni, le debolezze e i punti di forza, uno sguardo sul presente attraverso la lente d’ingrandimento dello studio del passato, ma anche la storia di un “viaggio ricco di insidie” alla scoperta di se stesso: leggendo i capolavori del passato Denby ritrova il proprio passato e la propria identità, sfuggendo così al rumore e alla nebbiosa e vacua palude dell’universo dei mass media.
Stufo di tutto, il cinecritico ritrovò così la meraviglia
“Una brillante avventura della mente”, cosi parla Joyce Oates sul “New York Times Book Review” delle centinaia di pagine che affollano “Grandi libri” di David Denby, tradotto tempestivamente da Lucia Olivieri per l’editore romano Fazi. Noi ci sentiremmo di dire soltanto che è un gran libro davvero, scritto da un critico cinematografico americano della rivista “New York”, 48 anni, sposato con la scrittrice Cathleen Shine (diventata celebre con “Lettera d’amore”), per ritrovare nientemeno che le proprie radici culturali contro l’imperante strapotere della società mediatizzata. Denby porta con sé il disagio della civiltà fine-Novecento e si ingegna a compiere il miracolo di una rilettura sistematica del “canone occidentale” (dalla Bibbia a Virginia Woolf) attraverso un originale grimaldello: frequentare i corsi di Lettere classiche e di Civiltà contemporanea presso la Columbia University studente tra gli studenti, a trent’anni di distanza dalla sua prima esperienza nello stesso ateneo. ANDROPAUSA PSICOLOGICA Denby – lo dice lui stesso nel corso di una narrazione che sta splendidamente tra cronaca, il saggio, l’introspezione e l’autobiografia – è al culmine di un’andropausa psicologica, causata dallo stress della sua professione di “film-voyeur”. In più è allarmato dal pauroso appiattimento, mentale e morale, cui i nuovi ventenni sono costretti e dai tentativi di affossare la cultura classica nelle università americane, in procinto di disfarsi degli ultimi scampoli di un’Europa ritenuta troppo vecchia. Contro gli Stati Uniti degli anni Novanta e contro la propria identità ridotta ad uno sfilacciato “patchwork”, David Denby invia le corazzate del suo formidabile esercito culturale: dalla Bibbia a Omero, da Agostino a Dante, Da Hobbes a Shakespeare… fino a Virginia Woolf. ”Cosi a quarantotto anni mi trovai davanti agli scaffali della libreria della Columbia tra la 115° Strada e Broadway… Eccoli i libri dei corsi di Lettere e di civiltà: due grossi volumi di Omero, le eleganti e sobrie edizioni di Eschilo di Hobbes… Mi entusiasmava l’idea che forse sarebbero stati difficili”. DA ADOTTARE NELLE SCUOLE Giorno dopo giorno, lezione dopo lezione, testo dopo testo, Denby ritrova lo smalto dei suoi anni giovanili svezzatisi nel frattempo al fuoco della vita. Ritrova la capacità di ragionare, la felicità di sentire, l’ebbrezza di intuire. La sua intelligenza vivida e brillante misura passato e presente, chiarisce enigmi, prospetta collegamenti, rivela a se stesso e agli altri verità inconfutabili. Denby, da consigliare anche alle scuole italiane nell’era dell’autonomia. Anch’esse potrebbero rispondere alla domanda “Perché i classici?” alla maniera del nostro blasonato critico cinematografico che alla fine del suo lungo viaggio afferma; “rileggendoli, non mi sorprese tanto il mio amore per il classici dell’Occidente, quanto la loro vera natura: essi non sono una composta armata conquistatrice, ama piuttosto un regno di belve indomabili in lotta l’una con l’altra e con il lettore. Gli studenti ne ricevono una coraggiosa educazione morale e fortificanti abitudini intellettuali, quali lo scetticismo e l’autocritica. La pretesa celebrazione “egemonica” dell’Occidente si rivela una continua contestazione (e insieme esaltazione) dell’Occidente stesso”.
– 05/06/2000
I classici occidentali salvati da Danby
Come recuperare il piacere della lettura
Qualche critico lo ha definito un libro traumatico e “sovversivo”, che andrebbe bandito dalle aule universitarie. Si tratta di “Grandi libri” di David Danby, che reca come sottotitolo “Le mie avventure con Omero, Rousseau, Woolf e gli altri immortali del canone occidentale”, edito da Fazi (pp. 650). La ragione? Ha il potere di trasmettere con modi accattivanti un male pericoloso e contagioso: il piacere della lettura, consentendo di ritrovare un rapporto diretto e personale con le opere letterarie, lontano da ogni funzione di mediazione decretata da apparati istituzionali e codici critici, da accesi interpretativi che spesso sono solo fini e se stessi. Un invito, quello di riscoprire e rinsaldare il vincolo o il “piacere” della lettura, che viene manifestato da più parti; e in maniera ferma e sommessa anche da un altro interessante volume appena pubblicato, “Come si legge un libro (e perché)” del grande critico Harold Bloom (Rizzoli, pp. 376), in cui l’appassionata difesa del “canone occidentale” serve a ribadire la centralità della nostra tradizione contro le invadenze del multi-culturalismo che sta devastando gli studi nelle università americane. E questo è un altro punto in comune che il libro di Bloom ha con quello di Denby, che pur si muove da altre esigenze e finisce con il mettere sotto accusa l’ossessione del “politically correct” che assilla la cultura d’oltre oceano. Non solo: il pericolo di cui ci avverte con solerte partecipazione Denby è anche un altro: il piacere della lettura sta scomparendo inesorabilmente a discapito della civiltà delle immagini, modificando radicalmente la nostra ottica di percezione delle cose e il nostro modo di espressione. Ma partiamo dall’inizio. David Denby è un quarantottenne brillante critico cinematografico del “New York” ed editor del “New Yorker”, marito della celebre scrittrice Cathleen Schine, l’autrice del fortunato “lettere d’amore”. Nel 1991 Denby attraversa una crisi d’identità culturale e si accorge che da molti anni non legge più libri, catturato com’è dal cinema, dalla tv, dalla lettura dei quotidiani, dall’assillante rincorsa delle “news”. Decide quindi, spinto anche dalla moglie, di reiscriversi all’università la Columbia, e di frequentare i corsi di “Literature Civilization”, durante i quali legge, o rilegge, i grandi classici della letteratura occidentale. “Grandi libri” è un resoconto appassionante, spesso divertito e suggestivo, scritto da un piglio di narratore di razza, di questa avventura su cui aleggia il dibattito sempre più vivo intorno al “canone occidentale” e alla sua funzione, al suo presunto “razzismo”, volto a mettere in discussione i testi della nostra letteratura con l’accusa di avere asservito il potere e di essere portatori di uno spirito imperialistico. Sempre in nome del tanto sbandierato “politically correct” che divide la cultura accademica americana di destra e di sinistra, senza nessuna esclusione di colpi, e in virtù di quelle ragioni delle tante minoranze che hanno assunto negli ultimi anni sempre più peso e consistenza. Allora Omero imperialista, istigatore della violenza? Dante Alighieri sadico e intollerante? Virgilio servo del potere? e che dire di Conrad? E degli altri autori presi in esame, da Montaigne a Shakespeare, da Virginia Woolf alla Bibbia, da Nietzsche a Sant’Agostino, esposti a ogni possibile critica da parte di femministe, negri, radicali, in modo da forgiare lo spirito critico degli studenti e di sviluppare la loro capacità di analisi? Denby naturalmente, non condivide gli entusiasmi dei suoi giovani compagni di corso, né tantomeno le partecipate direttive dei docenti. Prende ovviamente, spesso con sottile ironia, le distanze, convinto com’è che “ si possano ripudiare le ingiustizie del passato senza respingere i capolavori che ne sono scaturiti”; anzi, proprio questi capolavori costituiscono ancora oggi la base di ogni riflessione. Non sono né corretti né scorretti, semmai pieni di contraddizioni, e perciò contraddittori e esaltano sempre il dibattito, in confronto, la riflessione. Forzare gli schemi ideologici e interpretativi significa snaturarli e privarli del loro spirito originario, di quello spirito che i veri classici conservano per sempre, rimanendo sempre vivi e attuali, secondo la nota definizione di Italo Calvino. Certo, in qualche pagina affiora in Denby la condivisione di certi assunti critici, di certe forzature interpretative; confessa di essere “scioccato” dai massacri dell’Iliade, di essere “sconcertato” dalla “Commedia” dantesca per via della sua “arroganza”. Ma è forse una lettura troppo “contenutistica” di questi testi, mentre invece la riscoperta di questi classici esalta il suo piacere della lettura, che ci illustra con un misto di autobiografismo, cronaca giornalistica, critica letteraria, narrativa, trasmettendoci di continuo emozioni e impressioni. Pagine che riflettono la paura di aver perduto il piacere di assaporare la lettura e che in questa avventura Denby ritrova, insieme alla propria identità.
– 04/01/2000
Un anno di canone occidentale
“Se Platone avesse potuto conoscere il cinema, sarebbe morto di terrore”, ha scritto Mario Andrea Rigoni nel suo bel libro di aforismi, “Variazioni sull’impossibile” (Rizzoli, 1993): una frase che m’è tornata in mente più di una volta mentre leggevo “Grandi libri” di David Denby – ovvero (come recita l’accattivante sottotitolo) “le mie avventure con Omero, Rousseau, Woolf e gli altri immortali del canone occidentale” (Platone e relativo mito “protofilmico” della caverna incluso, naturalmente… ). David Denby è infatti l’influente critico cinematografico del “New Yorker”, che l’anno scorso ha fatto notizia anche da noi per la sua stroncatura di “La vita è bella” di Benigni già in odore di Oscar, e per quella azzeccatissima battuta sull’orgia in “Eyes Wide Shut” – senz’altro “la più pomposa nella storia del cinema, forse anche nella storia della orge vere; però son quindici-venti giorni che non vado a una, quindi non ci giurerei” – che più d’un nostro giornale ha subito ripreso. Insomma, Denby è uno di quei rari “cinéphiles” consapevoli che fra l’orgia… “pardon”, la vita reale, e quella sullo schermo una qualche piccola differenza c’è! E questo forse anche grazie alla recente rilettura della “Repubblica” platonica, uno dei testi in programma nei due corsi di Lettere e Civiltà che il nostro critico cinematografico, a quarantott’anni suonati, ha deciso di frequentare alla Columbia University, preparando gli esami come una matricola qualsiasi. “Grandi libri” è il racconto di quest’anno inconsueto all’università, vissuto con ironia ma anche molto entusiasmo, da un americano intelligente, laico, metropolitano e, ovviamente, ebreo, per uscire dalla “palude mediatica” e liberarsi senza psicoanalisi “dell’assillo che mi tormentava, e cioè l’impressione di non sapere più dove finisce Woody Allen e dove comincio io”. Istituti alla Columbia negli anni Trenta, ma adottati anche da altre università statunitensi, e attualmente oggetto di aspre polemiche, i corsi di Lettere e Civiltà sono una grande maratona in cui uno studentello, senza alcuna preparazione classica, in pochi mesi si legge i capisaldi della cultura occidentale: dall’Ulisse di Omero a quello di Joyce, diciamo.. non fosse che son sempre in programma anche l’ “Iliade” e quell’odissea in miniatura che è “Gita al faro” della Woolf. Si tratta del famoso, o famigerato, “canone occidentale” a favore del quale, qualche anno fa, ha spezzato una lancia anche Harold Bloom (anzi, una saetta, essendo Bloom lo Zeus dell’accademia statunitense), intervenendo nell’animato, ma spesso anche pretestuoso dibattito su cosa e quale sia un testo “canonico” nell’ America multietnica – un aspetto non secondario di quella che Robert Hughes, nel vivace pamphlet “La cultura del piagnisteo” (Adelphi,1994), ha chiamato, “la saga del politicamente corretto”. O, se si preferisce, la spinosa e forse impossibile soluzione accademico-istituzionale alla classica domanda – “Cos’è il classico?” – cui, fra gli altri, nel Novecento hanno risposto T.S. Eliot e Franck Kermode, Italo Calvino e più recentemente e imprevedibilmente Giuseppe Pontiggia (“I contemporanei del futuro”, Mondadori, 1998; cfr. “L’indice”, 1999, n.27. “Si parva licet”, però, “Grandi libri” assomiglia soprattutto a quell’altra, davvero sublime carrellata sulla cultura occidentale che è “Mimesis” di Auerbach: un capitolo (o due o mezzo) per ogni autore, da Omero a Saffo, da Platone ad Aristotele, dai tragici a Virgilio, dalla Bibbia ad Agostino a Macchiavelli, Hobbes e Locke, da Dante e Boccaccio a Hume e Kant, a Montaigne (“il santo patrono dei dilettanti, il genio di chi di genialità è privo… Devo fermarmi qui, trarre esempio e ispirazione da lui”), a Rousseau, Shakespeare, Hegel, Jane Austen, Marx e Mill, Nietzsche, Simone de Beauvoir, Conrad, Virginia Woolf (la cronologia, si vede, non è sempre rispettata, che il corso di Lettere e quello di Civiltà, cioè di filosofia, hanno ciascuno i loro tempi che s’intrecciano). Denby non ha ciascuna pretesa di originalità, non vuol contribuire col proprio “apporto critico”, e, anche se spesso le sue intuizioni sono brillanti (leggendo la Austen, nei cui romanzi ‘il gioco dell’accoppiamento assume aspetti e sfumature che Boccaccio ignorava”, si scopre che “la vita inganna le persone intelligenti ancor più di quelle stupide”), è soprattutto lo stile così scorrevole, la piana felicità dell’espressione, a renderle preziose. In quanto cronaca e, in parte, presa di posizione in una polemica politico-accademica molto americana, “Grandi libri” interesserà forse solo la minoranza di lettori italiani (comunque Denby, sia detto, sostiene una concezione “umanistica” del “canone”: ad esempio, difendendo “Cuore di tenebra” dall’attacco “postcoloniale” di Chinua Achebe, o preferendo il discorso della Beauvoir alle teorie femministe più aggiornate e pugnaci). Molto più “esportabile” (doverosamente esportabile) è invece il libro come apologia del piacere della “lettura”, che è cosa ben diversa dallo “studio”: un’attività – quella di leggere – che pochi studenti e ancora meno professori nostrani sanno praticare, e quindi trasmettere e insegnare. e poi c’è il libro come autobiografia o confessione, “avventura” dello spirito, ma anche racconto molto pragmatico di come si possano conciliare, o scontrare, i ritmi della lettura con quelli della vita quotidiana, professionale o familiare – per inciso, la moglie Cathy, che spunta più di una volta, è Cathleen Schine, l’autrice della “lettera d’amore (Adelphi, 1996). Anche sotto questo aspetto, “grandi libri” è assai poco “europeo”, un testo inclassificabile, mezzo saggio mezza autobiografia, nient’affatto supponente ma anche infinitamente ambizioso, o meglio “self-reliant”, cioè fondato su quella “fiducia in sé” che è il cardine del pensiero di Emerson, il Montaigne americano: per cui alla lunga probabilmente il modello profondo di questo resoconto di un anno all’università non è tanto “Mimesis” di Auerbach, quanto, a sorpresa, quel mai citato classico americano, “Walden”, dove il pupillo di Emerson, H.D. Thoreau, raccontava i suoi “due anni e tre mesi nel bosco”. Infine, naturalmente, “Grandi libri” è un bel “campus novel”, più divertente di tanti romanzi accademici “veri”: perché l’università – anche se non ci si mette il ministro Zecchino, anche se si tratta del miglior college americano, con i professori e gli studenti più motivati -, l’università è sempre un po’ la parodia di se stessa.
– 04/01/2000
Canone vs curriculum
I mutamenti in corso nella scuola rispecchiano, come sempre, i mutamenti che riguardano un’idea di sapere, il concetto e la forza impositiva di una tradizione; se il sapere scientifico è oggi investito dalla dicotomia apertasi tra scienza e tecnologia con le loro diverse finalità (riferite o alla conoscenza o all’efficacia), anche le “humanae litterae” vengono rimesse in discussione: i contenuti dell’humanitas o della Bildung o dell’educazione del gentiluomo – galantuomo prima aristocratico e poi borghese – vengono intaccati nel principio primo, la perennità, il valore sovratemporale e storico in nome di nuovi saperi o bisogni di sapere dell’uomo contemporaneo o postmoderno (che quindi vuole liquidare i contenuti della modernità che prende vita dall’età umanistica o per lo meno è insofferente di ogni “aura” più o meno sacrale ad essi attribuita). Tradotto altrimenti, si capisce che a fronte degli sconvolgimenti della scuola come dell’università debba emergere il confronto sui “saperi essenziali” e con sempre maggiore insistenza si senta accennare (accennare, appunto, più che discutere) al cosiddetto “problema del canone”: un problema esploso anzitutto in ambito anglosassone e specialmente nordamericano, ma anticipato già alla fine degli anni Sessanta da Jauss e dalla sua cerchia universitaria, quella di Costanza, anche se nata su un sostrato profondamente diverso. Per Jauss si trattava anzitutto di contrapporre ad una visione storicistica tradizionale, basata su una successione di indiscusse opere “canoniche”, lo studio del processo storico-ricezionale che ponesse al centro la figura del lettore come mediatore della comprensione del testo. Oltreatlantico, l’atto più clamoroso nell’affermazione polemica fu comunque la rivolta studentesca nell’università californiana di Stanford, nel 1987, contro una lista unica ed obbligatoria di classici da studiare. In Italia, il problema ha avuto una sua variazione autoctona a ridosso dell’introduzione della suola media dell’obbligo con l’infinita discussione sulle valenze formative del latino; è riesploso e ridosso della decisione ministeriale di focalizzare l’attenzione sullo studio del Novecento che quindi espunge o sacrifica altri studi e letture (con l’annosa questione del posto da riservare alla “Commedia” di Dante). La traduzione del libro di H. Bloom (“Il canone occidentale” Bompiani ,1996), dei saggi di G. Steiner (“Nessuna passione spenta” Garzanti,1997) sono evidentemente un segnale che un dibattito aperto oltreoceano più di un decennio prima si ripresenta attuale anche da noi e quindi i nessi che si stabiliscono tra la formazione e le trasmissione di una tradizione e la loro convalida nella postmodernità assumono nuova urgenza (al di là delle dipendenze “coloniali” dell’esportazione della discussione). Un capitolo particolare di questa urgenza è poi la congiuntura apocalittica di fine millennio che pone la domanda più o meno retorica sui “libri da salvare”. Una ricca e approfondita discussione del problema è peraltro disponibile nell’ ultimo numero ( a dispetto della data) di “Allegoria”, 29-30, maggio-dicembre 1998, rivista quadrimestrale diretta da Romano Luperini e pubblicata dall’editore Palumbo; una serie di interventi danno infatti conto della genesi e dello sviluppo storico della discussione e delle sue implicazioni non certo di poco conto su una società nazionale, in questo caso sula società italiana in quanto storicamente data, in quanto storicamente europea in quanto a confronto con i temi o i problemi dell’interazione etnica e culturale, che altrove – leggi gli Usa – Erano stati esattamente quelli che avevano suscitato il problema che oggi anche noi scopriamo attraverso le diaspore e le disintegrazioni sociali e politiche che approdano alle nostre coste. Implicazioni inoltre non certo secondarie per l’editoria, tanto per quella che concretamente si interroga su quali autori dovranno rimanere e quali saranno espunti dal canone pratico rappresentato ad esempio dalle antologie, quanto per gli editori di “classici” di ogni genere e specie. Nel quadro non è neppur fuori luogo l’ironia con cui Nicolò Pasero riassume il suo intervento: “E’ noto che la discussione recente sul problema del canone – soprattutto quella che, con risvolti marcatamente politico-culturali si svolge nel centro dell’Impero – presenta un dritto e un rovescio che sono complementari: nella forma, da un lato, dell’interrogativo apocalittico sul che cosa salvare della “nostra” cultura assediata dalla pressione dei barbari (così per Boom “cum suis”); e dall’altro lato, della pressante (e talvolta un po’ ricattatoria) richiesta delle culture minoritarie (per etnia, per “gender”, per gusti vari) di ottenere un posto il più possibile centrale alla tavola canonica. Fra le possibili soluzioni a questo dilemma (scartata quella di articolare le gerarchie culturali in un sistema di canoni concorrenti: e che vinca il migliore…) sembrerebbe ragionevole proporre di concedere a tutti un posticino a questa tavola: soluzione squisitamente consociativa che lascia anch’essa tutto come prima, posto che l’egemonia culturale discende do norma da quella strutturale (leggasi economico-politico-militare) e raramente viceversa (essendo meramente consolatori detti quali “Graecia capta cepit ferum victorem”). Si avrebbe di fatto una specie di Onu culturale, con la nota distribuzione dei poteri al suo interno”. Di fatto in tutto il mondo occidentale nei dipartimenti di letteratura si indebolisce la lettura dei classici, a vantaggio dei “cultural studies” dalle caratteristiche più varie ed eterogenee; ciò non impedisce, poi, che quel che è cacciato dalla porta rientri dalla finestra, come dimostra per esempio un’opera appena tradotta, “Grandi libri” di David Denby (Fazi editore) che di professione critico cinematografico per il “New York Times” a 48 anni decide di iscriversi presso la Columbia University al corso annuale di “Humanities”, un corso trasversale per gli studenti di tutte le facoltà e basato sulla lettura di classici della letteratura e della filosofia; un modo concreto di inserirsi nel dibattito sul problema del canone occidentale, ma anche di riferirsi a un problema di estrema importanza oggi e nel futuro prossimo: l’educazione permanente, i momenti di riflessione e formazione alternati all’esercizio della professione o anche all’aggiornamento professionale, condotti su opere di valore fondante o rivestite dell’aura del classico. Nessun canone è comunque mai fisso e stabile (a meno che sia canonico ed impositivo, ma questo avviene in campo religioso, nella canonizzazione dei libri biblici – contro gli apocrifi – come dei Paesi-auctores per eccellenza del pensiero cristiano, e comunque fino alla Riforma che modifica il quadro) perché le entrate e le uscite sono continue: basta pensare all’anticanone proposto da Contini nella rilettura della tradizione italiana e, per fare un caso editoriale, la proposta di Italo Calvino con la collana einaudiana delle Centopagine. La relatività di ogni canone (con l(inevitabile dialettica dentro/fuori) è indiscutibile e la registrazione del cambiamento si verifica tanto nell’analisi dei cataloghi editoriali quanto nei campioni offerti dalle antologie scolastiche. Lo sforzo onnicomprensivo (in cui l’insegnante finiva per scegliere il suo canone o la tradizione in cui si riconosceva) non è sostenibile per la diversa concezione dei curricula e dei programmi scanditi dalla modularità, una soluzione adottata in altri Paesi, per esempio in Gran Bretagna, è fornire all’insegnante una serie di “sillabi”, percorsi di opere e autori fissati a livello nazionale tra cui l’insegnante può scegliere. In questo caso la preponderanza assunta negli ultimi decenni dall’antologia – come avvio alla diretta lettura dei testi – ha posto in ombra il manuale; può essere un’affezione storicistica, ma in un quadro di scomposizione e ricomposizione delle dirette conoscenze della tradizione può tornare ad avere importanza la presenza del manuale, o la storia letteraria, concepita come strumento di raccordo e di informazione in cui collocare quanto si fa, pur sapendo che, come ha scritto Kermode già nel 1975, “il processo di secolarizzazione moltiplica le ipotesi di struttura del mondo” e quindi viene a cadere ogni pretesa di valori assoluti. L’importanza del manuale in questa prospettiva è sostenuta da Romano Luperini, situandola però correttamente in una dimensione di integrazione europea. “E all’allargamento dei confini nazionali si è indotti dalla mediazione che alla formazione del canone dispiegano i generi letterali, le cui forme attraversano con leggerezza ogni barriera di lingua. Se con la globalizzazione le ali di una farfalla che si libra in Giappone possono avere ripercussioni epocali in Europa, si può ancora dubitare che Calvino sia più prossimo a Queneau o a Heminguay che a Gadda o a Cassola, o che Montale abbia un grado di parentela maggiore con Eliot che con Ungaretti? La conquista di una latitudine europea deve però comportare un ridimensionamento anche drastico del canone italiano, almeno da Seicento in avanti. Una volta immesso Shakespeare ha ancora senso studiare il nostro Della Valle?” (A. Battistini, “Allegoria”, cit. p.55). In fondo, come europei siamo fortunati, la progressiva sedimentazione del canone come le sue trasformazioni sono avvenute all’interno di una stessa base continentale e di una stessa tradizione, pur con tutte le possibili varianti storicamente date. E’ anche vero che la legittimità della costruzione di una tassonomia multinazionale non deve opporsi in ogni caso alla centralità della lingua e della cultura in cui pure è bene inserire una dimensione comparativa e non nazionalista di processi e percorsi di opere e autori non nazionali; se la prospettiva europea peraltro funziona è nella facilità con cui si può ripercorrere le influenze, i crediti e i debiti reciproci. Magari con un po’ più di rispetto e di accoglienza per i canoni separati o apparentemente secondari semplicemente per questioni linguistiche, di appartenenza a lingue minoritarie o non dominanti (o veicolari nelle diverse epoche); da questo punto di vista è più corretta la logica distributiva del Premio Nobel che a volte suscita nel medio cittadino italiano la proverbiale domanda di don Abbondio: chi era costui?, soprattutto se i premiati sono autori nordici o slavi, ecc. Accettando per buona la plasticità storica dei canoni letterari come più in generale culturali, è vero che la definizione e la difesa perentoria del canone occidentale negli Usa deriva da ragioni squisitamente politiche: la nazione nasce accettando come propria la tradizione europea che, appunto, è europea e non nordamericana; quando però il paese si trova a dover accettare e trasformare in cittadini una comunità fluida e multietnica cambia il canne o il “contrasto sociale” che lo comprende. Questo contratto sociale – o scelta contrattuale di una tradizione per essere cittadini – non vale più negli stessi termini, come ha notato acutamente Bill Readings (“University in Ruins”, 1996): “Se si mette nel panorama in fondo il declino dello stato-nazione, riesce finalmente comprensibile il processo di sostituzione dell’Università di Cultura con l’Università di Eccellenza”, problemi politici che però si ripresentano anche da noi, non solo negli Usa, come nota R. Cesarini, quando la globalizzazione delle economie, il declino degli stati nazionali come poteri sovrani separati, la sostituzone nelle università dei finanziamenti statali con quelli delle grandi società multinazionali, la preferenza accordata alle ricerche applicate rispetto alla ricerca pura , l’invasione da parte di progetti di ricerca di alto profitto, le rapide trasformazioni nelle attività di studio e insegnamento prodotte dalle nuove tecnologie informatiche, l’ulteriore erosione del ruolo tradizionale svolto dalle scienze umane e in particolare dagli studi letterari rischiano di stravolgere completamente o definitivamente il quadro. Il problema dei curricula come dei nuovi saperi è dunque non solo culturale, ma squisitamente politico e basato su un’idea attuale di nazione come di cittadinanza; come obiettivo minimo si potrebbe però dare ai nuovi programmi la funzione di creare cittadini europei, per questa via si potrebbe recuperare, non in senso nazionalistico, ma di storicismo della lunga durata, anche in particolarità e la singolarità della tradizione italiana.
– 04/01/2000
Che si legge alla Columbia?
David Denby, critico cinematografico della rivista “New York”, è – per sua stessa ammissione – uomo affetto da deformazione professionale filmica. Quando non lavora, si occupa di tutto ciò di cui è prevedibile si occupi un giornalista di successo, marito e padre di famiglia residente a New York. Non in genere di persona, si potrebbe pensare, che torna a casa dall’ufficio o dal cinema scegliendo l’ “Iliade”, “Il contratto sociale” o “L’ideologia tedesca” per ricreazione del dopocena. Ma in qualche modo egli si è ritrovato a pensare che mancasse qualcosa nella sua vita intellettuale, e qualcosa di sbagliato vi fosse nel clima intellettuale della società in cui vive. Ricordava i giorni da studente alla Columbia dove nel 1961 aveva dovuto seguire due corsi istituzionali, Lettere Classiche e Civiltà Contemporanea, seminari che i giovani di allora avranno trovato senza dubbio noiosi o molto duri, ma che nessuno avrebbe mai pensato di definire politicamente oppressivi. Un giudizio divenuto luogo comune nel 1991. Vuoi per verificare tale giudizio, vuoi per il desiderio di scoprire che effetto potesse avere l’esperimento su un uomo “sistemato” e tuttavia incerto, Denby è tornato alla Columbia riscrivendosi a entrambi i corsi. Alla fine ha narrato la propria esperienza in questo “libro di avventure”. Il risultato irriterà probabilmente un buon numero di persone, soprattutto nella compagine accademica; difficile che le loro scontate reazioni comprendano quelle lodi che invece spettano a una cronaca insolitamente orientata, vivace e schietta come questa. Un paracinquantenne non può francamente sperare di passare inosservato in un’aula di matricole, né di simulare la meravigliosa innocenza letteraria e filosofica che contraddistingue la maggioranza dei diciottenni contemporanei, ed è lecito presumere che la semplice presenza di Denby, pur con tutta la discrezione possibile, abbia fatalmente modificato le condizioni che intendeva investigare. Ma perlomeno lo ha messo nel conto. Ha ascoltato senza sussiego i compagni di corso, trovandosi bene con alcuni di essi, e non ha mai scambiato l’ignoranza per stupidità. Corsi che cominciano con i due poemi omerici e hanno in programma la tragedia greca, Platone, Aristotele, Virgilio, la Bibbia, Agostino, Dante, Boccaccio, Macchiavelli, Montaigne, Shakespeare, Hobbes, Locke, Hume, Kant, Hegel, Austen, Marx, Mill, Nietzsche, Beauvoir e Woolf, per fare solo qualche nome, devono istituzionalmente tener conto dell’ignoranza degli studenti, ma i novizi non potranno che restarne atterriti. Riaffrontandoli a trent’anni di distanza, un ex studente come Denby sarà meno ignorante e intellettualmente più accorto. Ma ha saputo concepire il sospetto che dalle grandi opere vi fosse da ricavare più di quanto avesse pensato un tempo, e che sia stato un grave errore aver riservato loro scarsa attenzione dopo gli anni di università. Per rimediare era disposto a soffrire un po’. All’inizio è stata dura tenere il passo: concentrarsi sui testi in programma abbastanza a lungo da entrarvi in corrispondenza ha richiesto uno sforzo inusitato. dal tipo di attenzione adeguato ad articoli di rivista ha dovuto passare alle ben più gravi esigenze di Omero e Aristotele. Ma è riuscito a cavarsela; in caso contrario difficilmente il libro avrebbe visto luce. Lasciando da parte per un attimo il problema dell’ostilità politica a corsi di primo anno di questo tipo, è il caso di citarne alcuni difetti intrinseci. La massa di gravi letture imposte a studenti spesso non abituati a esercitazioni intellettuali molto meno ardue di questa è enorme, e tuttavia si pretende che essi ne penetrino ogni anfratto rendendone attivamente conto in classe. I ragazzi sono tenuti ad accettare il fatto che la lista di libri di studio sia in certo modo la migliore possibile, ma non c’è bisogno di essere iconoclasti per principio per porre in rilievo lacune arbitrarie, eccentricità, e oscillazioni nel criterio di scelta. Altro difetto evidente e difficilmente rimediabile è che tutte le opere straniere vengono studiate in traduzione. Denby riferisce che durante una lezione su Dante una studentessa sapeva leggere l’italiano ha letto a voce alta i primi versi dell’ “Inferno” in lingua originale. Un momento troppo perfetto”, scrive, e più o meno l’unico di tutto il corso di Lettere Classiche in cui l’uditorio, anch’esso in preda a una sorta di timore reverenziale, ha ascoltato il “suono” della poesia. Non ci si potrà aspettare che delle matricole conoscano la totalità o comunque un buon numero delle lingue (ebraico, greco, latino, francese, italiano, tedesco) che un tal suono gli consentirebbero di ascoltare più spesso, ma non sarebbe eccessivo pretendere che ognuno di essi sapesse leggerne almeno una (per avere un’idea di come “suona” Virgilio o chiunque altro), non fosse che per toccare con mano quanto va inevitabilmente perduto e distorto in traduzioni anche di buona fattura. E solo al momento di arrivare a Hobbes (primo autore anglografo in programma), nel corso di Civiltà Contemporanea, ci viene ricordato che anche la prosa, oltre alla mera formulazione di enunciati, può rientrare nel regno dei suoni. “Che scrittore sinistro e scostante! Eppure, così vincente e incisivo! La prosa di Hobbes ha una sua musicalità (spaventevole, tetra, severa) e io finii per apprezzarne lo stile metodicamente preciso, fatto di affermazioni spiacevoli, e l’incedere pesante e cadenzato, tipico del XVII secolo.” Non fa meraviglia che i docenti debbano parlare di poesia come se fosse prosa o semplice questione di temi e strutture, e della prosa come di un mero contenitore di asserzioni ben definite del tutto indipendenti dalla lingua in cui sono espresse. Un tal modo di procedere non significa affatto – per quanto Denby affermi il contrario – affrontare “gli strumenti dell’analisi letteraria””. Ma è sempre meglio di niente. In corsi di questo tipo praticamente tutto dipende dalle prestazioni del docente. Denby nasconde in uno pseudonimo l’identità degli studenti ma chiama i professori del seminario con il proprio nome, lodando in tal modo quasi senza riserve l’abilità e l’intraprendenza di queste persone straordinarie. Quali che siano le circostanze (diciamo, fare lezione presto una grigia mattina di dicembre), chi insegna non può permettersi di essere noioso; deve costantemente dare spettacolo. Facendo appello a tutte le proprie risorse di “showman o showwoman”, deve riuscire a risvegliare su quegli antichi testi stranieri l’interesse degli studenti assonnati. Per citare un esempio, Denby allude spesso, con tono perlopiù ammirato, alla tecnica di Edward Tayler, secentista di spicco ma, in cattedra, erudito e ingegnoso istrione pedagogico, le cui capacità didattiche gli sono valse numerosi premi. “Siete tutti come Telemaco, no?”, chiede agli studenti “arruffati e sonnolenti, oppure agitati e confusi”, cui tocca cavar fuori qualcosa dall’ “Odissea”. Che cosa vuol dire Tyler? Telemaco non sa veramente chi è, sono vent’anni che non vede il padre. Per quanto incapace di fare alcunché per risolvere la situazione, soffre le usurpazioni dei pretendenti della madre. Ma gradualmente avviene la sua maturazione, e quando alla fine ritrova Ulisse diventa un uomo forte e intraprendente, capisce chi è e assurge così alla sua identità vera. Tyler informa che Omero sta chiamando gli adolescenti “a una missione eroica”. E lo stesso Ulisse ha una lezione da impartire a loro: evitare la Calipso della regressione e dell’ozio. “Tutti voi siete nati per sguazzare nei guai… a meno che non preferiate rimanere sepolti nell’ombelico del mare”, dice il professore. E’ l’approccio morale, non dissimile da quello di un predicatore che stuzzichi i fedeli con qualche applicazione contemporanea del testo biblico. A volte il metodo passa alle blandizie, e il docente ricorda ai giovani il sostanziale pluralismo delle interpretazioni, che Ulisse è una figura aristocratica non meno che un bugiardo. Ma soprattutto egli mira all’ “aggiornamento” del testo antico, come quando, parlando dell’ “Iliade”, con innegabile brillantezza paragona Achille al giovane Marlon Brando. Il metodo tayleriano può anche comportare dei “trucchi”, e capita che Denby sia lì lì per deplorare il lato modaiolo e istrionesco del suo approccio, giustificato per altro dalla reazione positiva della classe e dalla sottostante serietà del docente, la cui bravura cresce con la caratura del testo trattato, e di cui risalta la vicinanza al nucleo del pensiero greco-ebraico-cristiano, come nella sua analisi del “logos” giovanneo. Questa serietà popolare è presente, sia pur con approcci differenti anche negli altri professori che, per tradizione o per istinto, sanno che non c’è altro modo di portare i grandi testi all’attenzione dei moderni “Teen agers”. Un modo di operare già noto come “adattamento”, e pare che lo stesso Dio vi abbia fatto ricorso accettando di farsi ritrarre nella Bibbia nelle vesti di una figura soggetta all’ira, all’invidia e così via. E’ probabile che una simile prospettiva faccia rabbrividire quei docenti che non hanno mai affrontato per un anno intero la disciplina imposta da queste lezioni “adattative””. enormi sono le energie richieste, numerosi gli interventi imprevedibili – alcuni sciocchi, altri ostili, ma altri ancora di grande acutezza – e costante la necessità di infondere energia in un uditorio riluttante, di aggiornarsi, di tenere sotto controllo dibattiti che possono portare ovunque e toccare i più radicali pregiudizi di alcuni studenti suscitando negli altri solo noia e sconcerto. Lo stesso Denby non dice di essersi infiammato del tutto, nei due corsi, e confessa anche un certo numero di assenze, ma l’entusiasmo che dimostra per la maggior parte del programma è decisamente toccante. egli capisce come mai il massacro dei proci e delle ancelle sia giudicato profondamente immorale dagli studenti, ma rifiuta di insorgere contro l’opera che comunica un enorme piacere semplicemente perché “è l’espressione di una cultura che ha provocato gravi sofferenze a metà della popolazione mondiale”. Osservazione, questa, quanto mai indicativa di un’attitudine generale per i problemi etici e politici dell’arte. Come Wallace Stevens, Denby vede nel “dulce” un requisito più fondamentale dell’ “utile”: Deve Dar Piacere. Il che non significa non poter aprire una controversia con Platone dissentendo da certi passi della “Repubblica”, o non poter leggere Macchiavelli come i primo dei filosofi che meriti l’appellativo di moderno, restando capace di cercare una spiegazione al “disorientamento che aveva colpito la società americana: la paura, la criminalità, le lotte di classe, le difficoltà che strangolavano i poveri e il consolidamento di una volontà politica ad essi contraria”. Ma il piacere estetico – ancor più dei piaceri del riconoscimento – di trovare adattamenti moderni resta il principale intento di Denby, nonché il suo miglior risultato. Anche qui egli si distingue giocoforza dalla maggioranza dei compagni di classe. Pur andando incontro a qualche difficoltà – la sofferenza nell’affrontare gli esami è stata praticamente analoga a quella degli altri studenti -, resta il fatto che l’impressione dominante è quella di un inaspettato, enorme piacere. Riuscire a leggere la “Filosofia della storia” di Hegel viene registrato come un trionfo personale, egli dichiara di essersi sentito “come un viaggiatore che abbia imparato la lingua di un paese esotico”. “Anche se la professione che svolgo”, scrive, “è l mio stile di vita frammentavano la mia capacità di attenzione, e mi facevano comparire giorno e notte davanti agli occhi un flusso continuo di immagini cinematografiche, stavo leggendo quel testo insolito e ponderoso. era incredibile, meraviglioso: c’ero riuscito”. Un piacere che va decisamente al di là dei fastidi causati dall’eurocentrismo hegeliano. Tra le altre fonti di delizia si annovera il “Decameron”, venuto al momento giusto considerato che la latitanza del settore erotico fino a quel punto del programma (se si accettua una fuggevole occhiata a Saffo) si era fatta sentire in modo imbarazzante. Boccaccio è lodato per la parità uomo/donna nel trattare del desiderio sessuale e, più in generale, per la sua celebrazione dell’Eros, edificatore e insieme distruttore di città. “Chiamai tutti i miei amici: dovevano leggere il “Decameron”. Dovevano leggere anche Kant, e capire che l’intero corso alla Columbia è la critica dell’imperativo categorico, poiché scegliere fra i vari doveri é più importante che preferire il dovere all’inclinazione. Un’altra ondata di gioia la porta il giovane Marx, poiché “leggere le opere migliori di Marx metteva alla prova le loro opinioni nei confronti della società in cui vivono e della loro stessa vita. Quelle opere non riguardano soltanto la nascita del capitalismo, esse parlano del mondo di oggi”. Al pari di Marx, anche John Stuart Mill, se lo si legge coscienziosamente, è ben lungi dall’essere l’ennesimo uomo bianco defunto. Se è vero che pone in rilievo l’assoluta necessità del dissenso, il diritto a una completa libertà di espressione, egli ci indica anche “le regole morali che dovrebbero controllare la nostra attività di esseri pensanti”. E da questo punto di vista Mill riassume perfettamente l’intento dei canonici criteri selettivi della Columbia: “I “grandi libri” non tramandano verità immorali, né un sistema coerente di idee, ma si inseriscono tutti in una tradizione che celebra il confronto con modalità conoscitiva essenziale”. E via con Nietzsche, davvero euforizzante dopo il dibattito su Mill. Tornando al corso più letterario, il piacere tocca nuovi vertici con Jane Austen (“Era chiaro che per quegli studenti dell’età dei mass media “Orgoglio e pregiudizio” era un libro complesso e remoto quanto l’ “Iliade”, e tuttavia recante in quel “Fino a questo momento, non ho mai conosciuto me stessa” di Elizabeth Bennet la summa logica del corso di Lettere Classiche). Al gran finale provvede “Gita al faro” di Virginia Woolf, un libro in cui “si respira l’intera tradizione della letteratura occidentale”. Ed è questo il piacere più grande, quello della complessità, e a un tale piacere bisogna educarsi. Il corso, pertanto, deve segnare il primo passo sulla disagevole strada che porta al godimento estetico e a una perfetta conoscenza di sé. Quello di Denby è un libro personale e digressivo. Veniamo a sapere che l’autore è stato rapinato mentre leggeva Hobbes – coincidenza opportuna, da un certo punto di vista. Vi sono poi sette “intermezzi” in cui chiacchiera degli amici, dei grattacapi quotidiani, e delle proprie opinioni. E’ visibilmente un ammiratore della sostanza, ma a essa come i suoi avversari accorda molta assennata considerazione. I corsi sono superficiali? Be’, diciamo invece che sui libri ci si deve soffermare troppo poco. Ma non c’è dubbio alcuno sulla loro utilità come viatico a una lettura corretta e alla riflessione su ciò che si è letto. La percezione del mero interesse, le qualità antagonistiche, e perfino la bellezza di questi libri impediranno, se va bene, tutte quelle ipocrisie su monumenti culturali e bianchi defunti. Denby è irritato dalla reazione di una studentessa invitata ad ascoltare un po’ di Mozart – e perché non la musica africana, di cui già conosceva tante cose, invece di questa imposizione dall’alto dei valori culturali dei bianchi? Forse per la preferenza per Mozart implica una scala assiologica che ne situa la musica più in alto di quella di Louis Armstrong o di Duke Ellington? Be’, sì, risponde Denby, ma il punto in questione era ancora una volta la bella complessità del piacere il offerta. Perché rifiutarlo? Perché non accogliere sia nero che bianco? E perché mai l’università dovrebbe sforzarsi di confermare le preferenze, presumibilmente premature, di una studentessa invece di darle la possibilità di nuovi diletti mettendola in contatto con ciò che ancora non conosce? E a ogni modo, perché mai la comprensione delle influenze formative sulla cultura americana dovrebbe risultare dannosa alle minoranze studentesche, anche se non hanno fatto altro che condannarle? Benché apertamente sprezzante delle vergognose parole d’ordine, del radicalismo domenicale ostentato da tanti giovani laureati con l’occhio ai posti di lavoro, rispettosi di un corpo docente sempre più ostile alla letteratura in sé e che preferisce rifugiarsi nella Teoria, Denby si muove con buona sensibilità in mezzo a queste tematiche multiculturali. Schietta, poi, oltre che ragionevole, a mio avviso, la sua posizione sul problema della canonicità dei testi. Egli nega a giusta ragione che si tratti di uno strumento del “linguaggio egemonico”. Al contrario, sostiene, è un concetto sovvertitore delle egemonie. Si sofferma sulle perturbazioni intellettuali che possono far seguito a una lettura seria di Marx o di Nietzsche, non contaminata da adattamenti teorici contemporanei. Soprattutto, i corsi alla Columbia non sono specifiche quantità di sapere iniettate agli studenti come un siero della verità, né una sorta di lavaggio del cervello inteso a inoculare nelle vittime una docile accettazione del “valori occidentali”. “era una lotta, un corpo a corpo con testi enigmatici e remoti, che sollecitava, che lo si volesse o no, a mettere alla prova la propria identità. al termine di tale esperienza l’unicità individuale di ogni studente sarebbe emersa dal magma delle sue composite identità. Ecco perché la vita degli studenti era in gioco quando essi leggevano Montaigne”. Potrà sembrare un modo un po’ melodrammatico di metterla, e indica chiaramente che Denby si riferisce a due facce dello studio di testi canonici senza distinguere chiaramente fra di esse. Una è che esso dà piacere in sommo grado; l’altra è che consente di pervenire la conoscenza di se stessi. Sulla soddisfazione che il destinatario ricava dal secondo beneficio non possono esservi dubbi; ma quanto al piacere, non si tratta di una ricompensa promessa all’oracolo delfico né tanto meno dal Professor Tyler, il quale avvisa spesso gli studenti di aspettarsi un viaggio irto di difficoltà, con molte cose da studiare, dentro e fuori dal letto, e vari momenti di scoraggiamento in entrambe le collocazioni. Conoscere se stessi e godersi la struttura dell’ultimo movimento della sinfonia Jupiter o la metafora della finestra di Virginia Woolf in “Gita al faro” hanno tutta l’aria di essere due tipi distinti di esperienza, per quanto si possa supporre che il primo dia in certa misura una mano al secondo. A non essere del tutto chiara nella posizione di Denby, tuttavia, è l’argomentazione della sua scelta risoluta per le ragioni estetiche a scapito di quelle etiche con un’insistenza vagamente pastorale sul valore terapeutico della letteratura quale coadiuvante alla conoscenza di se stessi. A suo avviso, gli studenti dovrebbero leggere “Orgoglio e pregiudizio” – opera per loro non meno remota di Omero – perché essi “hanno bisogno” del messaggio recato dal libro, “l’incessante lotta per la conoscenza e la difficile costruzione della propria identità”. Questa fusione di estetica ed elevazione morale non viene mai giustificata in modo esplicito. Inoltre, le ragioni che valgono per “Orgoglio e pregiudizio” saranno valide anche per molti altri romanzi, ma da sole non bastano a fare del romanzo della Austen quella tappa fondamentale che Denby giudica essere (in realtà perché il romanzo gli piace moltissimo). Nessun problema: anche il nostro autore, come la Columbia, crede nella mutevolezza dei canoni. Le opere vanno e vengono, e in certi casi è la nuova domanda a innescare gli avvicendamenti: il pluralismo delle culture, il femminismo, mutamenti generazionali e di stile nei criteri di valutazione. Tutto perfettamente giusto. Ma di canoni c’è comunque bisogno e, a meno che non siano sostenuti da una rigida autorità ecclesiastica, essi sono sempre soggetti a variare. A mantenere un libro sulla lista è l’apparato de commento; se di un libro nessuno vuol più parlare, la voce viene depennata per far posto ad un altro titolo di cui la critica ha codificato il pregio. E naturalmente il nuovo arrivato dovrà affrontare a sua volta la stessa minaccia di rigetto. Assurdo di recente a testo di studio presso la Columbia e “Il secondo sesso” di Simone de Beauvoir. Su questa scelta Denby si sofferma partendo dal resoconto di un convegno dell’organizzazione nota con il nome di Take Back The night (riprenditi la notte), in cui donne che hanno subito violenze sessuali raccontano le sofferenze patite in seguito. Per quanto favorevole all’inclusione della scrittrice francese nel programma ufficiale, l’autore si rivela assai poco felice nelle osservazioni su Take Back the Night, particolarmente riguardo agli stupri all’interno del campus universitario. “Quasi un terzo elle storie che riguardavano dei veri e propri stupri e potrebbero essere riassunte così: “Sono uscita con un ragazzo; sembrava carino, gentile, siamo andati nella sua stanza(o nella mia), abbiamo bevuto qualcosa e abbiamo ascoltato della musica. eravamo distesi sul letto, ci siamo baciati e accarezzati, ma poi io ho detto ancora no, e lui mi ha violentata”; La reazione di Denby a questo tipo di accusa ricorda tanto quella di Camille Paglia. si concede quindi una pausa di riflessione in cui ammette la possibilità che organizzazioni del genere, se pur di per sé palcoscenico di istrionici e autoinflitti tormenti, a suo avviso assurdi e forzati, riflettano una genuina e giustificata protesta generale contro gli abusi sessuali. A ogni modo, dopo lunga deliberazione, risolve che scopo autentico di Take Bach the Night “non era tanto di modificare il comportamento maschile quanto di politicizzare i rapporti fra i sessi e incoraggiare la solidarietà femminile”. La disamina di Simone de Beauvoir mette in rilievo la politicizzazione delle concezioni femministe del sesso (degli studenti, non dell’autrice in questione), la loro incapacità di comprendere che possono esistere differenze che vanno al di là delle odiose distinzioni patriarcali. Non si può fare a meno di avvertire che un tale moderatismo è destinato a incontrare una fredda accoglienza in certi ambienti, e che in tempi avventati ed eccessivi come i nostri, Denby, così cauto e misurato, lo esercita a suo rischio e pericolo. Non che esiti a parlar chiaro, come nel vigoroso attacco sferrato a Catherine MacKinnon e alla sua interpretazione della sessualità femminile come prodotto del “potere sociale maschile”. Alla fine concorda con un compagno di classe: “Non c’è modo di sfuggire al potere… ma esso non è fisso e immutabile. Può essere negoziato, cambiato, modificato, capovolto. Nel sesso il potere non è immutabile”. un garbo fuori moda quello di Denby, che peraltro sembra essere proprio così: una gran buona pasta d’uomo. Forse ne abbiamo avuti abbastanza di Robespierre e Defarge. La cosa migliore di questo libro alquanto verboso ma piacevole è il suo sano atteggiamento verso il corpus ufficiale dei testi. L’autore è deliziato dalla grandiosità e dall’intelligenza dei libri che si è offerto di leggere – dalla loro intransigenza, dalla loro contestabilità, dalla loro sorprendente energia. Non pretende ovviamente che tali qualità non possano essere appannaggio anche di altri libri, capaci di scuotere e modificare la mente di chiunque vi si applichi seriamente, si trovino o meno a condividere lo spazio con opere di qualunque altro campus. Non si può insegnare tutto a tutti. La Columbia ha stilato e continua a stilare (perché l’azione è all’insegna del cambiamento) una lista ) che altro è un corpus dei testi canonici?), e chiede ai propri docenti di usarne le voci per affilare e, se possibile, dilettare gli intellettuali delle sue matricole. Il libro di Denby costituisce un caloroso avallo di tale politica.
– 03/08/2000
Voglia di canone
Un omaggio al piacere della lettura
Che cosa accadrà quando, anche nelle università italiane, si riverserà una massa considerevole di studenti afroasiatici, quando chiederanno spiegazioni sullo studio dei classici dell’Occidente? Bisognerà continuare a studiare Omero e la Bibbia o sarà necessario passare al Corano? Per ora sono le scuole elementari e medie che trattengono i pargoli sbarcati fortunosamente sulle nostre coste italiche e per gli insegnanti universitari nostrani la discussione sul “canone occidentale”, che ha infuocato le università americane, sembra lontana da venire. Per chi volesse saperne di più è appena uscito un libro di un americano cinquantenne, critico cinematografico e marito di una scrittrice di successo che, per verificare a che punto è la questione, torna a sedere nelle aule della sua Columbia, molto vicina alla sua cara Manhattan. David Denby in “Grandi libri” ci informa subito che non è d’accordo né con la sinistra universitaria che bolla di maschilismo e di colonialismo le migliori opere della letteratura di tutti i tempi, né con i conservatori, che usano argomenti poco convincenti sul sacro fuoco cattolico dell’Occidente. Si sente un bianco, certamente, ma non un razzista, e amerebbe rileggere insieme agli studenti di oggi i classici, senza forzarli dentro uno schema ideologico che li snaturerebbe. Omero, Saffo, Sofocle, fino a Dante, a Boccaccio, a Shakespeare, alla Austen, a Conrad e la Woolf non sono politicamente né scorretti né corretti. Sono contraddittori e vitalissimi, se li esaltano ancora. A bene vedere è la condizione della donna che lo appassiona nella lettura. Si indigna quando legge che Aristotele non considera affatto il mondo femminile, così come si meraviglia dinanzi al desiderio scoppiettante nei personaggi femminili di Boccaccio. Torna a scandalizzarsi per l’inferno dantesco, per il suo curioso sadomasochismo cattolico, per la “morta gora”. Più della giustizia e della libertà sono i diritti della donne che hanno compiuto l’unica rivoluzione riuscita del Ventesimo secolo, a elettrizzarlo. dalle sue parole sembra che le università americane siano invase da torme do barbari che vogliono islamizzare e orientalizzare il sacro Occidente, senza rendersi conto, come pure una professoressa di sinistra gli ricorda, che il canone occidentale è di origine recente e che farebbe sorridere un suo collega inglese. Per suggerire alla sinistra universitaria di pentirsi per il modo rozzo e contenutistico di affrontare i classici, bastavano 20 pagine e non le 650 di “Grandi libri”. Il canone occidentale insomma è un pretesto. Quello che preme a Denby è la sopravvivenza della lettura, che vede minacciata dalla civiltà delle immagini. Se avesse letto “Venere nera” di Bernal avrebbe avuto un’arma critica ancora più forte contro i sostenitori conservatori del nocciolo duro dell’Occidente cristiano, anche perché in quel libro l’autore trova le influenze afroasiatiche proprio delle opere che sta leggendo. Per vie traverse però Denby, proprio per la sua passione di lettore, arriva lo stesso traguardo di Bernal. I classici hanno un’energia formidabile, frutto di innumerevoli innesti, che arriva fino a noi. Il piacere della lettura va difeso, propagandato, accanitamente suggerito a chi il piacere non lo conosce se non in versione pornografica. Così “Grandi libri” diventa un vero romanzo, l’avventura di un lettore che ha il terrore di non saper più leggere, di non ricordare più le sue amatissime letture di ragazzo, quelle che lo hanno formato. I protagonisti sono i ventenni che siedono vicino a lui nell’aula universitaria e che il professore stimola a un dibattito vivace e spregiudicato. Sono ragazzi multietnici che fanno domande imbarazzanti sugli eroi omerici, come sul femminismo, sull’idea stessa di libertà e di piacere; non proprio dello stesso tipo del Maschio bianco americano che li avrebbe colonizzati. La Bellezza è ancora universale? La Religione è una sola come quella di Dante e di Conrad? La sessualità occidentale è proprio identica a tutte le altre. Domande che mettono in crisi il nostro Denby e che sono sicuro che traumatizzeranno tutti quei bravi universitari italiani.
– 02/05/2000
David Denby
Grandi libri
Stanco di passare le giornate tra l’ennesimo film da vedere e l’ennesima recensione da scrivere, un po’ invidioso perché la moglie passava i pomeriggi a leggere con il gatto sulle ginocchia, il critico del “New Yorker” David Denby decise nel 1991 di prendersi un anno sabbatico. Sarebbe tornato alla Columbia, l’università in cui si era laureato trent’anni prima, per seguire qualche corso. Scelse quelli in cui si leggono i grandi libri della cultura occidentale: da Omero alla Bibbia, dai greci a Nietzsche, da Platone a Rousseau. Il ritorno a scuola avviene proprio nel momento in cui questi corsi (“Literature Humanities” e “Contemporary Civilization”, nel gergo universitario) sono messi sotto accusa. Istituzioni tipicamente americane, nate all’inizio del secolo, i due insegnamenti sono diventati bersaglio delle minoranze, la vittima sacrificale di quella che Robert Hughes ha chiamato “La cultura del piagnisteo”. L’accusa: privilegiare i testi scritti dai Dead White European Males (ovvero gli autori maschi, bianchi, europei e morti) a scapito delle altre culture. risultato: i gruppi organizzati di donne, neri, asiatici, latini lancia in resta contro un canone che imponeva di leggere Shakespeare, alias il più pericoloso rappresentante della letteratura imperialista. Conseguenza: una furiosa battaglia, tuttora in corso, per allargare il canone ai dimenticati, a quelli che non avevano una stanza tutta per sé, e magari invece di scrivere libri facevano i cantastorie, suonavano il tamburo, intagliavano i totem. “Grandi libri” è un diario di lettura, un’autobiografia, e insieme un confronto contro gli oppositori del canone. Denby si schiera a fianco di Harold Bloom, fiero paladino della tradizione e dei giudizi di valore. Gli autori contestati sono i più bravi, i sopravvissuti al tribunale del tempo (che è il più implacabile tra i critici). Le motivazioni per escluderli non hanno a che fare con la letteratura: i risarcimenti agli oppressi devono prendere altre strade. Tuttavia, qualche movimento tellurico è riuscito a far tremare il solido pantheon, se non altro perché i semestri sono brevi. Così dai programmi è sparito Lucrezio per far posto a Saffo, mentre Dostoevskij e l’osceno Rabelais sono stati rimpiazzati da Jane Austen e Virginia Woolf. La svolta avviene negli anni 80, quando la Columbia University si apre alle studentesse. I primi giorni Denby fa fatica a concentrarsi, abituato com’è a leggere soltanto i giornali. Ma non è l’unico ostacolo. L’“Iliade” lo concentra con la sua crudeltà, e con la spropositata ira di Achille. Per un breve tratto di strada l’allievo cinquantenne si trova d’accordo con gli studenti più giovani, alle prese con un poema che propone carneficine, mentre ormai non possiamo non dirci tolleranti e pacifisti. Poi l’abitudine alle letture pesanti e “lontane” attenua i toni. E qualche professore brillante fa il resto. Alla fine il critico in libera uscita si è riconciliato perfino con la Woolf. trent’anni prima, confessa, gli era sembrata antipatica, mentre ora riesce ad apprezzare le sfumature di “Gita al faro”. Lettore per divertimento, Denby si concede parecchie divagazioni. “Ida Denby è stata il re Lear della mia esistenza”, spiega, parlando della mamma ebraica. La lettura del “Leviatano” gli ricorda invece un’aggressione in metropolitana. Montaigne lo affascina per le sue manie, e Boccaccio per la sua rappresentazione dell’eros femminile. Il difficile è spiegarlo alle compagne di banco, che continuano a leggere il “decamerone” solo perché va portato all’esame. due righe (un po’ fuori tema, ma molto azzeccate) spiegano la differenza tra cinema e teatro. Al cinema un cespuglio è semplicemente un cespuglio, mentre a teatro è un cespuglio è sempre qualcos’altro, un simbolo o una metafora. Ecco perché che va volentieri al cinema di solito a teatro si annoia. E viceversa.
Raccontando le sue scoperte, l’autore, il marito di Cathleen Schine, evita la mediazione dei critici e parla delle sue emozioni di fronte ai classici proprio come davanti ai film che vede per la prima volta
Omero meglio di Schwarzenzgger e Dante è bigotto ma ammalia
Le avventure del cinematografico americano Denby con gli immortali del canone occidentale, da Saffo alla Woolf
A quarantotto anni David Denby, noto critico cinematografico americano, trovandosi sempre più incerto sui valori della cultura nella quale era stato allevato, ebbe l’idea di verificarli nel modo più elementare, vale a dire iscrivendosi per la seconda volta all’Università – la Columbia di New York, la stessa che aveva frequentato trent’anni prima – e seguire di nuovo, questa volta come uditore, i corsi introduttivi alla civiltà occidentale, facenti parte del curriculum di base. da noi a scuola i ragazzi leggono (“come”, è un altro discorso) i poemi omerici, Virgilio, Dante, “I promessi sposi”, ecc., ma negli Stati Uniti arrivano all’Università praticamente digiuni dei cosiddetti classici, e in un primo biennio ne vengono inzeppati, col vantaggio di accostarvisi in maniera un po’ più adulta, ma anche con lo svantaggio di portare a questo incontro pregiudizi che il fanciullo non ha avuto modo di sviluppare. Inoltre da una ventina d’anni in qua il canone stesso di questi classici è stato messo in discussione in nome del Politically Correct: sono emerse le femministe che contestano l’assenza di scrittrici, mentre neri, musulmani e orientali protestano contro il monopolio di coloro che con una sigla chiamano DWM, “Dead White Males”, maschi bianchi defunti; università minori qua e là hanno notoriamente abolito autori immortali come razzisti, imperialisti e simili, proponendo al loro posto qualcosa di più gradito ai loro clienti, che come si sa pagano profumatamente (nella terra della libertà l’istruzione superiore è per la stragrande maggioranza dei cittadini tutt’altro che gratuita); ma anche se Denby vede una matricola di pelle scura alzarsi a domandare perché dev’essere costretta ad ascoltare Mozart e non qualche rapper, la Columbia non ha seguito le nuove tendenze se non in piccola parte, e il canone degli Anni 90 non presenta variazioni clamorose rispetto a quello di quando Denby vi studiava. Così nel corso di un anno il nostro critico cinematografico pur continuando a esercitare il suo privilegiato mestiere ha modo di far lavorare il cervello leggendo a fondo, fra gli altri, opere di Omero, Saffo, dei tragici greci, di Platone, Aristotele, Virgilio, dell’Antico e Nuovo Testamento, e poi di Agostino, Machiavelli, Cartesio, Hobbes, Locke, Shakespeare, Montaigne, Goethe, Rousseau, Hume, Kant, Hegel, Marx, Stuart Mill, Nietzsche, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf. Sono in teoria riletture, ma onestamente Denby ammette trattarsi quasi sempre di letture fresche, in quanto le impressioni che deriva sono profondamente diverse da quelle che ricorda, oltretutto nebulosamente. Il suo grosso tomo è innanzitutto un resoconto di queste (ri)letture alla luce. Raccontando le sue scoperte, Denby evita il più possibile la mediazione dei critici, e parla delle proprie emozioni proprio come davanti ai film che vede per la prima volta. Così constata, mettiamo che Omero è straordinariamente violento e crudele, ma allo stesso tempo ben più vivace e divertente delle pellicole con Schwarzenegger; oppure come Hobbes con la sua disamina dell’egoismo come pulsione primaria dell’uomo può aiutarlo a capire la rapina di cui è stato vittima nella metropolitana. L’analisi del tragico confronto fra gioventù intollerante e vecchiaia dispotica contenuta in “Re Lear” riapre la dolorosa ferita del suo rapporto con la madre, potente e prepotente in gioventù e insopportabile in seguito; “gita al faro” (lo so, è stato ritradotto come “Al faro”: ma è uno sbaglio) gli si rivela come un prodigio di scavo nelle sensazioni e negli affetti umani, e non più come una frivola manifestazione di sensibilità femminile che gli era parso a diciott’anni. Denby confessa, anche, le proprie difficoltà a entrare nel complicato sistema di Kant, o nella complessa prosa di Hegel; non ha pazienza con Goethe, e riconosce che come profeta Marx è stato un disastro, pur raccomandando assai i suoi scritti giovanili. Ma nel corposo volume c’è di più che una cronaca di rinnovati trasporti, pur efficacemente comunicati, per certi grandi libri. Esponente di quanto c’è di meglio in certa intelligenza newyorchese talvolta presa in giro da Woody Allen – ebreo agnostico con moglie ebrea anche lei, intellettuale e adorata (è la romanziera Cathleen Schine), due figli e un grosso gatto, appartamento a Manhattan tappezzato di libri, idee liberali, Denby è automaticamente angosciato dalle minacce che sembrano addensarsi su quello che sente come il proprio retaggio umanistico, e seguendo l’insegnamento di Stuart Mill è disposto ad ascoltare con ogni attenzione coloro che le formulano. Anche i professori che tengono i seminari qui puntualmente descritti hanno un atteggiamento analogo, evitando di imporre alcunché agli studenti, che sono ignoranti ma intelligenti e causidici oltre che etnicamente diversissimi, e cercando piuttosto di portarli per vie traverse ad ammettere che leggere Platone non significa sposarne il punto di vista, ma semplicemente esplorare idee idee che hanno avuto importanza nella formazione del mondo in cui vivono. I dibattiti hanno talvolta aspetti ingenui che Denby non nega. L’Inferno di dante indigna tutti (quante torture, quanta intolleranza, quanta bigotteria!), ma poi quando una studentessa italiana legge ad alta voce il primo canto nella sua lingua i ragazzi e Denby stesso si rendono conto della musica della poesia, alla quale non avevano pensato: la letteratura dunque è anche stile, non solo idee. Progressivamente coinvolto nei dibattiti, Denby è stimolato a chiarire a se stesso i propri punti di vista, anche su aspetti della vita del campus. Assiste a “Take Back The Night” , marcia di protesta della studentesse, dopo la quale le ragazze confessano pubblicamente gli stupri subiti – e giustamente deplora il vittimismo di una ideologia che non incoraggia a reagire costruttivamente; ascolta Chinua Abebe e Edward Said su “Cuore di tenebra”, e perde la pazienza davanti alla faziosità della loro condanna di Conrad come razzista e colonialista. Nell’ansia di essere onesto con tutti eccede nelle autoanalisi e anche nelle ripetizioni, e parte del suo lavoro verrà accantonato da noi cinici europei come folkloristico. Nell’insieme però l’operazione catartica affascina, un viaggio dantesco dagli squartamenti dell’Iliade al monologo interiore della signora Ramsay che in tempo di bilanci millenaristici non dovrebbe lasciare indifferente nessuno.
– 02/03/2000
David Denby, “Grandi libri”
Critico cinematografico nonché editor del “New Yorker”, Denby ci regala in questo alluvionale e davvero appassionante libro un testo che è insieme autobiografia e meditazione letteraria su autori come Virgilio, Jane Austen, Marx, Nietzsche o Boccaccio. Una sorta di storia della cultura occidentale o se volete un canone raccontato con l’affabile semplicità di chi i libri li ha amati e li ama con l’ardore di un ragazzo.
In “Grandi libri” David Denby – critico cinematografico del “New York” – racconta la sua esperienza di “studente a contatto con le grandi opere della letteratura di tutti i tempi
Da Omero a De Beauvoir: I classici europei salvati da un americano
Attenzione: dietro il tono civile affabile, intimo, di civile conversazione e insieme di diario pubblico, questo di Denby è essenzialmente un libro “sovversivo”, la cui diffusione nelle aule universitarie andrebbe impedita con ogni mezzo! Trasmette infatti il contagiosissimo, destabilizzante piacere della lettura, il piacere di ritrovare un rapporto diretto, personale e cogente con le opere letterarie e filosofiche, contro la disgustosa palude mediatica in cui siamo immersi e l’eccesso di apparati istituzionali di mediazione. Ma parliamo dall’inizio. Nel 1991 David Denby, quasi cinquantenne, critico cinematografico del “New York”,sposato con due figli, marito della scrittrice Cathleen Shine, sta attraversando una crisi di identità culturale e spaesamento. Scopre improvvisamente di non leggere libri da molti anni, di vedere solo la tv, di essere ossessionato anzi dall’ascolto delle “news”, di giorno e di notte, e poi si sente frastornato da tutta la verbosa, aggressiva discussione intorno alla politically correct… A questo punto decide di reiscriversi all’università (Columbia) dove si legge (o rilegge) i capolavori dell’intera cultura occidentale, iscrivendosi ai corsi di “Literature Humanities” e di “Contemporary Civilization”. “Grandi libri” costituisce appunto il fedele resoconto di questa straordinaria esperienza di lettura e di dibattito seminariale in aula con una classe multietnica di studenti, di cui 4 soltanto su 22 sono maschi e bianchi (l’atmosfera dell’aula è ricostruita con magistrale sapienza narrativa). Si va da Omero fino a Woolf, in una carrellata vertiginosa, ma ad appassionarci non sono tanto le critiche “etniche” o femministe e quelle della cosiddetta “sinistra accademica” al presunto razzismo del canone occidentale (così accecate dai linguaggi stessi del potere da eliminare, in alleanza con l’ironia dei media, ogni incanto della lettura), quanto l’idea fondamentale che applicandosi senza pregiudizi e senza troppe nozioni alla lettura di un classico ne usciranno cose sorprendenti: i grandi libri, i classici occidentali influenzano la nostra anima, rimodellano la nostra identità, “ci indicano una possibilità di vita” aiutandoci a reagire, a diffidare della nostra autocommiserazione. Denby, che è il critico cinematografico, e perciò ci sottopone ogni tanto intriganti analogie (il narcisismo di Achille rivive in molti dei personaggi di Brando, la veemenza di Beauvoir ricorda l’intensità di Jeanne Moreau…), sottolinea anche una differenza tra le due arti negli effetti sui rispettivi fruitori: “i film offrono un ampio spettro di piaceri, ma non cambiano la vita degli spettatori. Nietzsche sì”. Di queste singolari avventure con “gli immortali autori del canone occidentale” (corca una trentina, e sarebbe vano rivelare l’arbitrarietà del percorso e le molte assenze ingiustificate), mi piace segnalare almeno gli incontri relativi a Omero (l’“Odissea” come black comedy), Dante (il suo sadismo esaspera gli studenti, ma poi la musicalità del canto li riconcilia) e Shakespeare (re Lear viene proiettato persuasivamente dall’autore nella propria madre). In questo minuzioso reportage di un “dilettante dei libri” Denby è guidato da un’etica del piacere unita ad una onestà di fondo e da una convinta aderenza alla prima reazione emotiva. Perché un libro “sovversivo”? Non perché ribalta gerarchie di valore acquisite ma per questo corpo a corpo anche drammatico con i “grandi libri”, che ne rivela spesso la verità a lungo tempo sepolta, una verità luminosita e ambigua, impegnativa e scandalosa. Il tocco di Denby, pur con qualche ruvido corto circuito (Rousseau che rivive in Ross perot!) riesce miracolosamente a rianimare la cultura europea, la sua capacità di minacciare il nostro autocompiacimento e la nostra pigrizia.