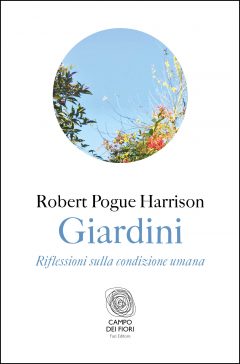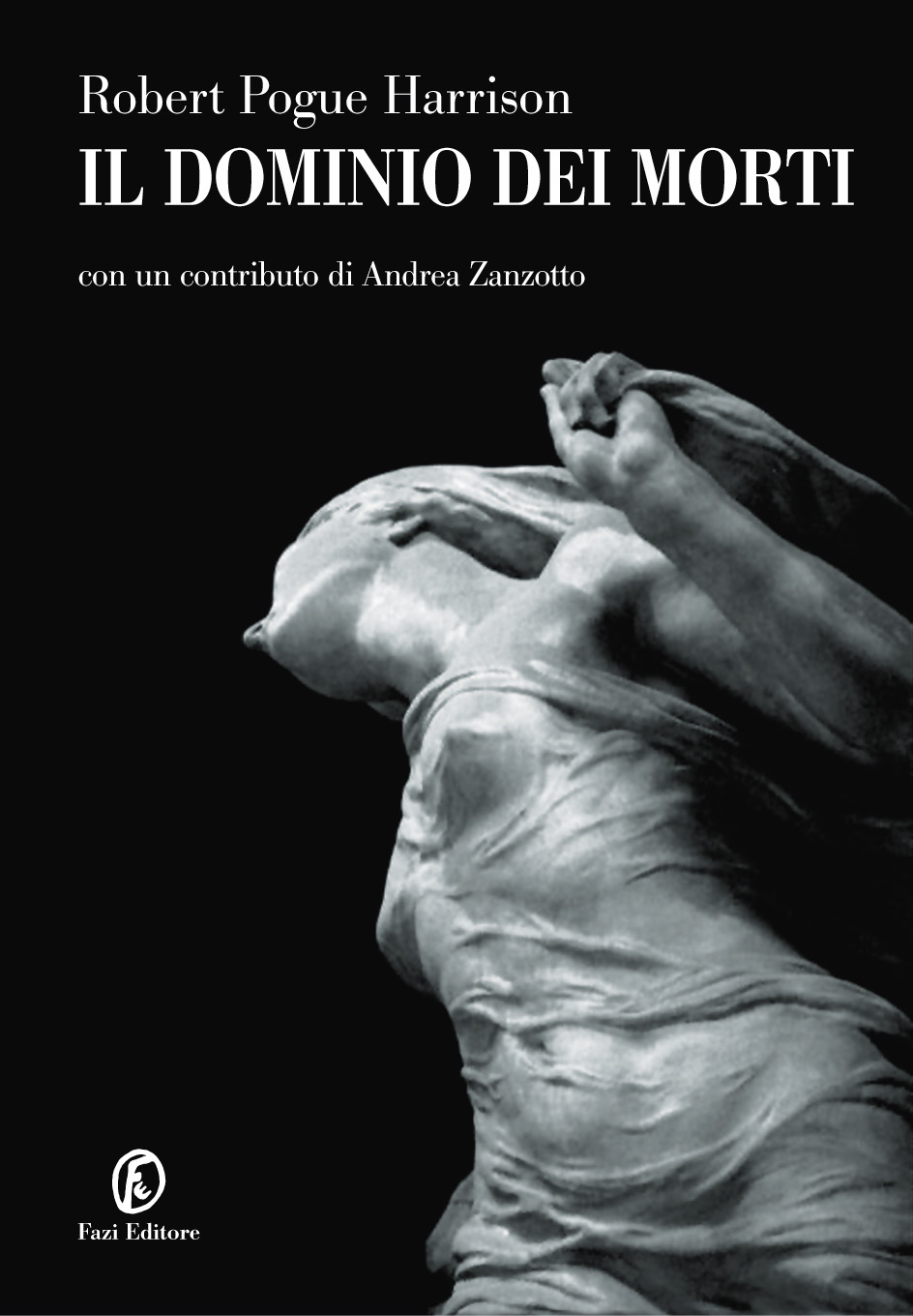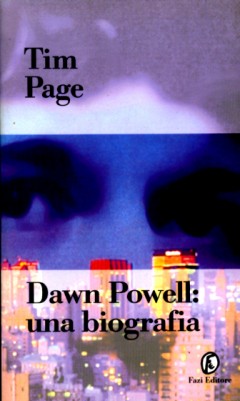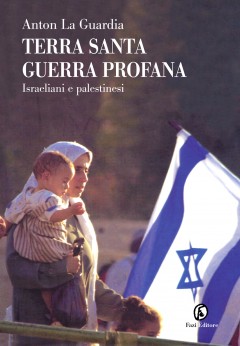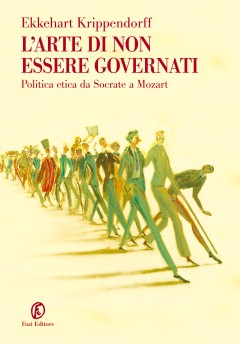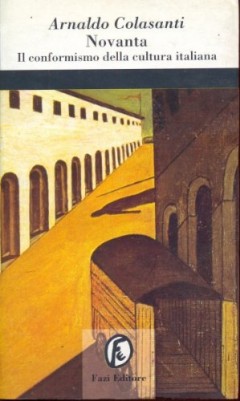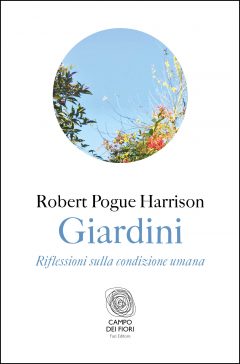
Robert Pogue Harrison
Il dominio dei morti
Traduzione di Pietro Meneghelli
Postfazione di Andrea Zanzotto
Uno straordinario esempio di filosofia letteraria che esplora le forme in cui si manifestano i rituali del dolore e del pianto.
Quali sono le relazioni dei vivi con i morti? Perché seppelliamo il corpo dei nostri morti? Cosa c’è in gioco quando costruiamo delle tombe? Il dominio dei morti di Robert Pogue Harrison considera l’importanza di tali domande per la civiltà occidentale, esplorando i moltissimi luoghi in cui i morti coabitano con il mondo dei vivi: i sepolcri, le immagini, la letteratura, l’architettura e le necropoli che li ospitano nella loro esistenza ultraterrena. Scritto in modo elegante, questo saggio dedica particolare attenzione alla pratica della sepoltura. Harrison sostiene che seppelliamo i morti per umanizzare il territorio in cui sviluppiamo il nostro presente e immaginiamo il futuro. Finché i morti sono tumulati nelle tombe e nei sepolcri, non abbandonano realmente il mondo, ma conservano una vita tra i vivi, anche se si tratta soltanto di uno spazio simbolico. Per Harrison, l’aldilà domina talmente la nostra esistenza che la cultura umana può essere vista come il costante negoziato, la collaborazione e perfino il conflitto tra i morti e i loro discendenti. Tramite l’interpretazione di scrittori e pensatori come Virgilio, Dante, Whitman, Pater, Nietzsche, Rilke ed Ernesto De Martino, l’autore dà luogo a un’opera suggestiva, illuminante e profondamente originale.
«Un libro scritto in modo inimitabile, provocatorio e intellettualmente avvincente».
«Publishers Weekly»
– 01/03/2005
SULLA VITA DELLA MORTE
Che cosa costituisce il tratto essenziale dell’humanitas e di conseguenza che cosa rende affatto altra la cultura umana da quella animale? Questo l’interrogativo che sta alla base del bel saggio di Robert Pogue Harrison – dal titolo tra il luttuoso e il melodrammatico de Il dominio dei morti (The Dominion of the Dead) – dove fin dalle prime pagine si sottolinea come tratto distintivo della nostra specie sia sempre stato il prendersi cura dei morti; l’allestire per i defunti non solo una tomba, istituendo piuttosto in loro celebrazione e ricordo una sorta di memoria vivente, la quale ha sempre cercato di fare in modo che essi non scomparissero mai del tutto dal nostro orizzonte. Però questa sollecitudine/attenzione nei confronti di coloro i quali hanno compiuto il passo al di là – per dirla con un’espressione di Maurice Blanchot – forse non deriva tanto da una pietas nei confronti dei propri cari trapassati, quanto dalla coscienza stessa dell’ineluttabilità dell’exitus: tratto che accomuna noi mortali e ci distingue dagli altri animali che hanno sì esperienza/cognizione della morte altrui (di cui possono senz’altro soffrire), ma difettano di consapevolezza rispetto al proprio destino all’insegna di un cruciale venir meno.
Il saperci mortali tuttavia comporta ben altro, afferma Harrison. Fa sì che “ci rendiamo conto di non essere noi i creatori del nostro mondo”. In un certo qual senso, dunque, noi non solo deriviamo dai morti (gli antenati che ci hanno preceduto) ma dipendiamo da essi. La stessa lingua madre che parliamo non è, se non in minima parte, di nostra invenzione, provenendo da un passato remoto o remotissimo, alla pari della gran parte di costumi, usanze e tradizioni culturali distintivi di un esserci strettamente legato al mondo dei morti. Per il Nostro, paradossalmente insomma, lo specifico dell’umanità – dei vivi – sta nel modo in cui ci si pone in relazione coi morti. In tale prospettiva la funzione compassionevole della sepoltura (non appena dei corpi, sottintendendo essa l’immagazzinamento/preservamento del retaggio potremmo dire spirituale di chi ci ha preceduto), l’inumazione, ci rammenta l’humus: terreno fertile per l’anima che ci proviene dai morti ed elemento costitutivo di un’hum-anitas terrestre segnata dalla contingenza e dalla finitu-dine.
È come se noi viventi – sostiene Harrison – potessimo stare “culturalmente, istituzionalmente” in piedi solo in quanto le nostre costruzioni intellettuali, artistiche o scientifiche possono ergersi sulle solide basi gettate dagli antichi. Tesi del saggio è perciò la reiterata sottolineatura della nostra fatale “soggezione verso i morti”. Dipendenza che, oggi come oggi, non lascia intravedere possibilità di emancipazione alcuna; men che meno quella derivante da fantasmatiche illusioni biotecnologiche nella speranza in un futuribile prolungamento all’infinito della vita. Brama che svela al contempo una pericolosa hybris e un’incapacità di accettare il carattere transitorio del nostro statuto esistenziale.
Colpisce, tra le altre, una considerazione: “la mortalità viene riscattata solo con la morte”. Coma a dire non vi è possibilità di fuga dalla condizione umana – che è sempre esposta alla vulnerabilità e alla morte – se non attraverso la negazione dell’umanità stessa, ovvero di una modalità di abitare la terra in maniera naturale e non virtuale, sintetica o, peggio ancora, postumana.
– 27/11/2004
Le tombe hanno voce
Cessate d’uccidere i morti, / Non gridate più, non gridate / Se li volete ancora udirie, / Se sperate di non perire»: nello scrivere queste parole (che si leggono nel Dolore] Ungaretti, come suo solito, andava in pesca d’assoluto, si. ma a partire da un’emer-genza ben concreta, storica, il bliz su Roma, il 19 luglio 1943, nel quale le bombe americane avevano polverizzato, coi banchi dei marmisti a San Lorenzo, anche i sepolcri dell’attiguo cimitero del Verano. La prima redazione di quei versi (poi naturalmente censurata) era uscita proprio l’estate delle bombe. Ed era un’esplicita invettiva contro gli americani, proprio: a quell’altezza ancora ‘nemici’ e non, come poi nel ’47, munifici sponsor della parte politica cui il defascistizzato Unga dovrà accodarsi: «Ora che avete senza nostra colpa / Straziato tumuli da poco chiusi / […] Come farete a udire i vostri morti? / […] Se non v’arresta luce, / Nello sterminio folle, / Orridi apparireste, / Del suggello umano, dimentichi».
Sono tornate in mente, queste parole, davanti al video del marine che, di pattuglia a Falluja, scarica I’M47 su quello che pare un morto ma non lo è. dunque, è certo ostile. Tanto che, leggo, neppure in base alla convenzione di Ginevra (della quale prima o poi qualche falcone televisivo denuncerà, come della Costituzione italiana, l’evidente obsolescenza criptocomunista) lo si potrà processare: quell’anonimo marine cosi lontano, ormai, da ogni suggello umano. Un segno preciso dell’orrido nel quale il presente sprofonda, a Falluja e dintorni, è il fatto che uno degli esercii! dell’onore spari sui moni che l’aliro usa come mine (ma gli stessi kamikaze attualizzano la mitologia dei berserkir. i guerrieri invincibili perché già morti).
Ungaretti (con Leopardi, Caproni, Magrelli, ecc.) è visitato dall’ultimo affascinante libro di Robert Pogue Harrison (II dominio del morti, con un contributo di Andrea Zanzotto, traduzione di Pietro Meneghelli. Ed è proprio un americano a spiegarci come non solo la voce dell’umano sia legata alla sua mortalità (sulle orme dell’Agamben del seminale e ancora ‘impensato’ Linguaggio a la morte], ma come ogni forma di cultura trovi il suo fondamento neU’nautorità» dei trapassati: anche (se non soprattutto) quella che la contesta (esemplare la rilettura della traiettoria di Rimbaud). Non è un caso che all’origine slessa della letteratura occidentale, neWIliade, si trovi l’orrore sacro perla sorte più paventata dai Greci: che i loro moni non trovino adeguata sepoltura. È «rovinosa», l’ira di Achille, perché di «molte vite gagliarde / d’eroi» fa «bollino dei cani, / di tutti gli uccelli»: e ognun ricorda come lo ‘scioglimento’ del poema sia proprio la preghiera di Priamo perché gli vengano restituite le spoglie di Attore. Ma per Harrison questo motivo non è solo alla scaturigine dell’epica; esso l’onda anche il teatro (nonché quella sua demetaforizzazione che è la teoria politica), se si pensa ad Antigone; nonché la terza forma-matrice della letteratura, la poesia lirica: se si pensa a Orfeo.
Ogni forma di rimozione della morie, e azzi dei morti, è per Harrison un segno di barbarie. Con Heidegger (ma soprattutto con Vico – già nume tutelare del suo primo grande saggio, Foreste, tradotto da Garzanti nel ’92), infatti, per l’italianista di Stanford è «la consapevolezza della morte, che definisce la natura umana». Li slessa categoria di umanità è collegata, con una delle etimologie che tramano la Scienza nuova (§ 12), al-‘humus e off inumazione. L’identità dell’individuo, per i posteri, e legata M’iscrizione del suo nomi’ (che è quanto accomuna la letteratura alla sepoltura: in greco sema e tanto ‘segno’ che ‘tomba’): lo dimostra l’inumanità della morte in mare (riconosciuta da Conrad e Melville); e lo ribadisce l’epitaffio di Keats, oggi (per consapevole paradosso) leggibile su un cippo del Cimitero degli Inglesi di Roma: «qui giace un uomo il cui nome fu scritto sull’acqua».
Inumana – cioè insensata – è dunque la morte nelle guerre moderne, o nei genocidi cui esse s’accompagnano: che aggiunge all’eliminazione della vita, infatti, la cancellazione dei resti mortali. Per questo le Madri di Plaza de Mavo si ribellarono, nel 1989, all’iniziativa di esumare i cadaveri dei desa-pareddiK dalle fosse comuni. La loro obiezione spiega molto de) carattere rituale e comunitario della sepoltura (e sono fra le sue migliori, le pagine in cui Harrison legge – e ha il merito di segnalare per primo, a un pubblico non italiano – Morte e pianto rituale di Krnesto De Mattino): private d’identità e di vita erano state, le madri, nel momento in cui venivano loro sottratte le spoglie dei figli. Hanno voluto restare senza vita, continuando a combattere: rifiutando che «al recupero dei resti seguisse una riconciliazione».
Di De Martino Harrison esalta la capacità di applicare «i criteri dell’antropologia culturale, della filologia, della psicologia, della critica letteraria e della filosofia speculativa, come nella migliore tradizione vichiana»: è un identikit che vale un autoritratto. L’interdi-sciplinare cwiositas di quest’errabondo excursus continuo, per dirla con Contini (una «breve odissea tra gli archivi», la definisce il suo autore: pur essa, certo, selvosamente vichiana), gli fanno adire sentieri inconditi. Se lo scotto è il mancato incontro con autori non meno che canonici (mai citati, per esempio, Petrucci sulle scritture ultime delle sepolture, Ferrati! sul carattere postumo della letteratura, Mosse sul simbolismo dei monumenti di guerra, Ricoeur sul funzionamento della memoria luttuosa…), il merito è l’elusione dei loci communes della grande saggistica internazionale, ormai non esenti da certo risaputo mn ron. K un libro, insomma, nel quale la verve di scrittura si coniuga alla profondità dell’analisi. E non è poco.
Una disciplina si affaccia tuttavia, negli ultimi capitoli, con una certa pretesa di protagonismo: ed è la critica filosofica delle immagini. Anche qui, niente Sontag, Boltanski o Didi-Huberman. Però pagine bellissime sul concetto heideggeriano di Schuld (colpa-indebitamento) rideclinato in obbligo nei confronti dei resti altrui: oggi questa responsabilità si attua (o nini sì attua, come quando i nielliti evitano di mostrare i corpi delle vittime, newyorkesi o irachene che siano) soprattutto attraverso le immagini. Le fotografie dei cari estinti consacrano le abitazioni di oggi come le iinagines, le maschere mortuarie degli antenati, quelle ajitiche. La visita al Vietnam Veterans Memoria] di Washington – un semplice, enorme muro sul quale sono iscritti i 59.000 nomi delle vittime americane di quell’orrore: contestato da chi avrebbe voluto immagini più ‘monumentali’ e patriottiche -rinvia al senso più profondo di questo libro. Che, pur incubato per più di dieci anni, proietta ora la sua luce nera su Ground Zero. Per questo ha un significato squisitamente politico la discussione su cosa verrà edificato in luogo
delle Twin Towers, e ancora più l’avrà quello, a venire, sui caduti in Iraq. Come scrive Harrison, «onorare qualcuno significa affermare la base morale da cui si reputa scaturiscano gli onori, e nessuno in America ha l’autorità morale per onorare i veterani del Vietnam. Il loro onore è al di sopra e ai di là di noi».
Libri dello stesso autore