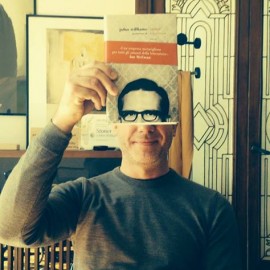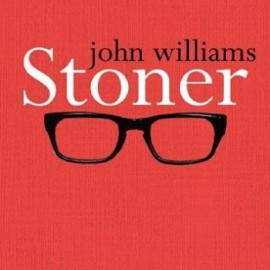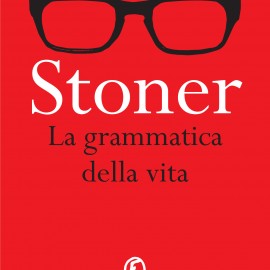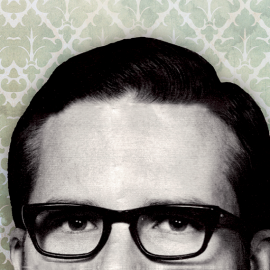Il più grande romanzo americano di cui non avete mai sentito parlare
• Il blog di Fazi Editore - Recensioni
In occasione dell’uscita del romanzo d’esordio di John Williams Nulla, solo la notte, da oggi in libreria, pubblichiamo l’articolo di Tim Kreider apparso sul «New Yorker» il 21 ottobre 2013 con il titolo The Greatest American Novel You’ve Never Heard Of.
In uno di quei rari esempi gratificanti di tarda giustizia nell’arte, Stoner di John Williams è diventato un inatteso bestseller in Europa dopo essere stato tradotto e sostenuto dalla scrittrice francese Anna Gavalda. Una volta ogni dieci anni qualcuno come me tenta di fare lo stesso servizio a questo romanzo anche qui negli Stati Uniti, scrivendo un pezzo e sostenendo che Stoner è un meraviglioso romanzo americano cronicamente sottovalutato – l’ultima tra queste persone, che tra l’altro annovera altri interventi di questo genere, è Morris Dickstein per il «New York Times».
E dunque si tratta di essere ampiamente sconosciuti nel proprio paese, di essere distribuiti e apprezzati solo tra i bibliofili e così lo scrittore John Williams è stato consegnato a quella categoria poco invidiabile alla quale appartengono augusti compagni come Richard Yates e James Salter: quella degli scrittori per scrittori.
Stoner è indiscutibilmente un grande libro, eppure riesco a comprendere perché non sia un romanzo amato appassionatamente nel suo paese. Si potrebbe descrivere come un anti-Gatsby. Ho il sospetto che uno dei motivi per cui Gatsby è un classico è che, nonostante le sue delusioni e la brutta fine che fa, pensiamo tutti segretamente che Gatsby sia piuttosto un bel tipo. Gli americani non lo vedono come un anti eroe o come un personaggio tragico – non più di quanto non vedano l’attuale razza di criminali carismatici in tv semplicemente come delle persone cattive.
La storia del successo di Gatsby: fa un monte di soldi, sembra un tipo molto importante, possiede una villa, dà grandi feste e riesce anche ad avere la ragazza dei suoi sogni, almeno per un po’ di tempo. Il protagonista di Stoner è un accademico per niente glamour, un gran lavoratore con un matrimonio deprimente, viene allontanato dalla figlia, si spacca di fatica per una carriera che termina con la sua morte e poi viene dimenticato: un fallimento.
Il romanzo non è ambientato nella città dei sogni ma in un’entroterra polveroso. È dichiaratamente un romanzo accademico, un genere storicamente di interesse esclusivo degli accademici. I valori contenuti sembrano desueti, valori anteguerra (il che potrebbe essere una delle motivazioni per cui è ambientato una generazione prima di quella in cui l’autore scrive), il tirare avanti sgobbando tutta la vita come la più grande delle virtù e ricompense. E la sua prosa, paragonata all’estatico lirismo art-nouveau di Fitzgerald, è invece austera, trattenuta, e precisa; la sua pulizia è così poco appariscente e simile alla lucentezza che resiste sui pavimenti bruniti di legno massello; la sua struttura è invisibilmente perfetta, come quel genere di case che non si è più capaci di costruire.
Stoner inizia con un breve prologo, che descrive, in una prosa tersa e a mo’ di necrologio, la vita e la morte di un professore assistente poco amato di un’università di provincia. Il prologo ricorda che l’unico elemento che testimonia la sua esistenza è un manoscritto medievale donato alla biblioteca dai suoi colleghi in suo nome. E poi conclude:
Può capitare che qualche studente, imbattendosi nel suo nome, si chieda indolente chi fosse, ma di rado la curiosità si spinge oltre la semplice domanda occasionale. I colleghi di Stoner, che da vivo non l’avevano mai stimato granché, oggi ne parlano raramente; per i più vecchi il suo nome è il monito della fine che li attende tutti, per i più giovani è soltanto un suono, che non evoca alcun passato o identità particolare cui associare loro stessi o le loro carriere.
Senza troppi giri di parole: è deprimente. Ed è anche, in quel suo modo dimesso, un incipit audace: anticipando la tradizionale suspence narrativa, privandoci anche di una promessa di una qualche tragedia catartica, Williams obbliga a chiedersi: di cosa parlerà questo libro? La sua ambizione è evidente nell’apparente umiltà del suo soggetto: come la tetralogia del Coniglio di Updike, è pensato per essere niente più e niente di meno del racconto di una vita.
E c’è qualcosa perfino in questi primi passaggi, una sicurezza assolutamente non mostrata, come le delicate note iniziali di un musicista virtuoso o come i primi gesti casuali di un grande artista, che ci dice che siamo in presenza non soltanto di un grande scrittore, ma di qualcosa di ulteriore – qualcuno che conosce la vita, che forse addirittura la comprende. È la stessa cosa che mi capita quando leggo James Salter: la presenza di una saggezza. E la saggezza è, certo, sempre fuori moda.
Nonostante la prosa trasparente, Stoner non è un libro facile da leggere – non perché la prosa sia densa o astrusa, ma perché è così dolorosa. Ho dovuto interrompere per un anno o due, quasi alla metà del libro, quando la moglie di Stoner, Edith, intraprende una deliberata ma inconsapevole missione per allontanarlo dalla figlia, l’unica persona che lui ami davvero. Più tardi, ormai persa la figlia, Stoner trova il vero amore in una giovane studentessa, una sua pari intellettualmente – e ancora una volta un nemico, osservando quella felicità, decide di togliergliela.
Williams riesce misteriosamente a privare il suo eroe della felicità del matrimonio, della figlia, dell’amante, addirittura della sua vocazione. Ogni cosa appare spietatamente inevitabile, come quei capricci annichilenti degli Dei nelle tragedie di Euripide.
Gli antagonisti del romanzo ne costituiscono l’aspetto più problematico; sono fondamentalmente strumenti usati dal mondo per distruggere e soffocare tutto quel che Stoner ama. Due di questi sono anche sfigurati– uno, Hollis Lomax, collega e nemico di Stoner, è un gobbo, e l’altro, Charles Walker, il delfino di Lomax, ha un braccio e una gamba menomati. Questo sottolineare il male con la deformità fisica colpisce il lettore del XXI secolo per il suo senso di oppressione. Ma diversamente dai personaggi malvagi del melodramma, questi vivono davvero. La moglie di Stoner, Edith, non è una caricatura; è una donna cresciuta in un vuoto emotivo, istruita solo a ruoli ornamentali e inutili, totalmente al riparo dalla realtà e «il suo apprendistato morale, sia a scuola che a casa, era stato censorio nei modi e coercitivo negli intenti e quasi interamente mancante riguardo il sesso». Di fatto esercitata a diventare una fragile e subdola isterica. La sua crudeltà è tanto odiosa perché lei rimane inconsapevole – quindi non è neppure un semplice personaggio malvagio. E Lomax, il più grande avversario di Stoner nell’arena della sua carriera, è uno spirito sensibile, ferito (in questo non diverso da Stoner), che crede onestamente che sia Stoner ad essere inconsapevolmente malvagio, severo verso se stesso e verso il suo studente preferito e disabile.
La stessa rivelazione portò Lomax e Stoner alle loro vocazioni, «un’epifania di ciò che le parole possono far conoscere e che però non si può esprimere con le parole». (Questo, ad ogni modo, è un marchingegno che il romanzo porta avanti di continuo, in momenti di quiete, di trascendenza, momenti che fanno venire la pelle d’oca per motivi che non riesci a nominare, e che comunicano istanti di eternità attraverso la descrizione di una vista oscura di una finestra d’ufficio in una notte d’inverno).
Alla fine di una lunga serata di bevute nella casa di Stoner, passata parlando soprattutto dell’infanzia di Lomax e dell’amore per i libri, Lomax nell’andar via bacia Edith sulle labbra, in maniera casta, – un gesto stranamente carico, che sembra avere meno a che fare con l’attrazione verso la moglie del collega quanto più con il primo amore condiviso dai due.
È possibile che Stoner sia condannato ad essere per sempre amato per lo più dai critici, dagli accademici, e dagli scrittori, perché al suo centro c’è l’ineffabile feticcio che affligge tutti:
l’amore per la letteratura, per il linguaggio, per il mistero della mente e del cuore che si rivelano in quella minuta, strana e imprevedibile combinazione di lettere e parole, di neri e gelidi caratteri stampati sulla carta.
La scoperta giovanile di Lomax della letteratura è definita «una specie di conversione» e in un altro passaggio l’università è paragonata a un monastero, un rifugio per chi è inadeguato alla vita nel mondo. Ma essere inadeguati al mondo non è una mancanza: il mondo fuori dall’università è stupido e brutale; ne sentiamo soltanto gli echi delle guerre mondiali e della Grande Depressione. «Come la Chiesa nel Medioevo, cui non interessava un fico secco né dei laici né di dio in persona», dice Dave Masters, l’amico di Stoner, «ci servono dei pretesti per sopravvivere». Nel momento più manifestamente drammatico di William Stoner, quando si rifiuta di promuovere agli orali lo studente raccomandato Walker, sostiene che le vere menomazioni sono rappresentate da se stesso e dal suo gusto, entrambi confinati nel riparo sicuro dell’Accademia. Walker incarna il mondo, nascondendo la sua mancanza di una pur minima competenza nella materia scelta con una retorica disinvolta – in altre parole è un artista di palle. Egli rappresenta un terreno più istruttivo per Stoner che per Lomax, non un rivale ma una specie di apostata. Dopo aver scritto il suo libro, Stoner
ogni volta che ripensava a quel libro, e al fatto di esserne l’autore, restava stupito e incredulo di fronte alla propria temerarietà. E alla responsabilità che si era assunto». La letteratura è la vera religione di Stoner ed è questo che alla fine redime tutta la sua esistenza.
Il ritornello della scena sul letto di morte, «che cosa ti aspettavi?», è modulato nel corso delle pagine sui toni prima dell’amara delusione fino alla rassegnazione e alla trascendente serenità. All’inizio, Stoner vede la propria esistenza per come il mondo l’ha giudicata, con spietata chiarezza,
Aveva sognato di mantenere una specie d’integrità, una sorta di purezza incontaminata; aveva trovato il compromesso e la forza dirompente della superficialità. Aveva concepito la saggezza e al termine di quei lunghi anni aveva trovato l’ignoranza.
Ma poi, dopo quello che può essere descritto come una visione delirante o un guizzo di grazia – tre giovani coppie allegre che attraversano il prato, facendo eco al trio di amici con cui era andato a scuola –, Stoner pensando a quella riflessione, «gli sembrava che quei pensieri fossero crudeli, ingiusti verso la sua vita». Nei suoi ultimi momenti Stoner prende in mano il suo libro – uno studio superato sull’influenza della poesia latina sulla lirica medievale – dal comodino, e quando ne tocca le pagine sente «l’eccitazione di un tempo, simile al terrore». La prima volta che Stoner aveva provato quello stupore, da matricola di un corso di Letteratura inglese, trasformato in paralisi dal sonetto 73 di Shakespeare,
la luce entrava di taglio dalle finestre posandosi sui volti dei suoi compagni, che parevano illuminarsi dall’interno, stagliandosi nel buio. Uno studente strizzò gli occhi e un’ombra sottile gli si posò sulla guancia, la cui parte inferiore era esposta al sole.
Quando i volti dei suoi compagni furono trasfigurati, Stoner abbassò lo sguardo sulle sue goffe mani da contadino e le vide come per la prima volta, come qualcosa di strano e meraviglioso. Armeggiando adesso col suo libro sul letto di morte, Stoner è ancora una volta colpito dal movimento miracoloso delle sue dita – entrambe le volte Williams utilizza la parola “stupito” come se fosse la Parola ad animare la carne. Ed ancora, alla fine, «la luce del sole, attraversando la finestra, brillò sulla pagina e lui non riuscì a vedere cosa c’era scritto». Proprio per la bellezza assoluta della sua prosa, Stoner ci dice che anche le parole stesse non sono essenziali; la letteratura, proprio come Stoner, è solo un riflettore imperfetto di quella luce che proviene dall’esterno.
Parte della grandezza di Stoner è che guarda alla vita per intero e per quel che è, senza delusione e senza disperazione. Realizza alla fine di aver trovato quel che cercava all’università non nei libri, ma nell’amore e nello studio di essi, dunque non in qualche oscuro Gral dell’erudizione, ma nella sua ricerca. La sua vita non è andata sprecata nella mediocrità e nell’anonimato; la sua carriera poco significativa non è stata una fatica ottusa ma un atto di devozione. È stato un sacerdote della letteratura, e si è consegnato pienamente a quel che amava. La conclusione del libro, così com’è – non so se chiamarla consolazione o avvertimento –, è che non c’è niente di meglio nella vita. La riga, «poco gli importava che il libro fosse dimenticato e non servisse più a nulla. Perfino il fatto che avesse avuto o meno qualche valore gli sembrava inutile», può essere considerata come l’epitaffio del romanzo, la cui ultima immagine è quella del libro che cade nel silenzio dalle dita senza vita di Stoner.
Revolutionary Road, un romanzo lodato in maniera simile e letto altrettanto poco, piacque a una tardiva ampia comunità di lettori grazie all’edizione tie-in dell’adattamento cinematografico di Sam Mendes. (Osservare tutti quei pendolari che leggevano il romanzo spietato di Yates era come guardare persone bere dell’arsenico etichettato come acqua miracolosa). È difficile immaginare un film di successo tratto da Stoner, perché è così essenzialmente basato sulla dissonanza tra la vita osservata – logora e vile, come un gioco o uno spreco – e la vita esperita, permeata di amore e significato. «Ci sono guerre, sconfitte e vittorie della razza umana che non sono di natura militare e non vengono registrate negli annali della storia», afferma il mentore di Stoner, Archer Sloane, l’uomo che per primo gli aveva rivelato il potere della letteratura. Il romanzo incarna le autentiche virtù che esalta, le stesse virtù che probabilmente lo relegano, come l’eroe del titolo, al suo posto nell’ombra perpetua. Ma il romanzo, come il professore William Stoner, non è lì fuori per vincere concorsi di popolarità. Resiste, illuminato dal suo contenuto.
Articoli sullo stesso libro