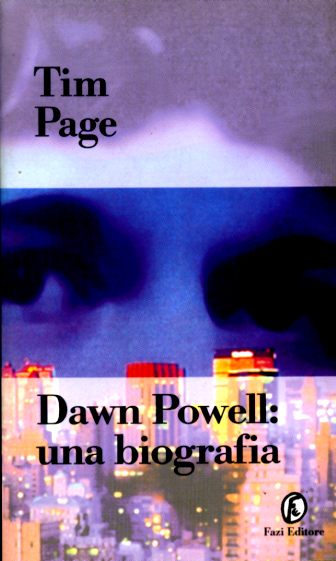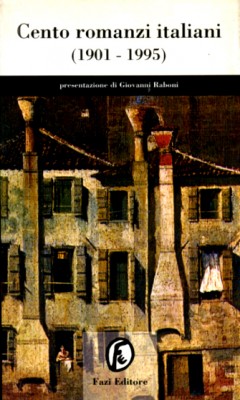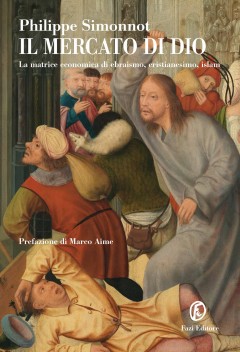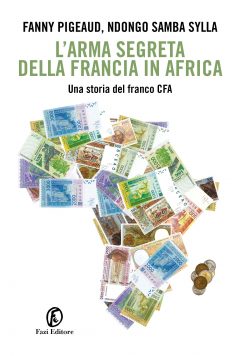
Tim Page
Dawn Powell: una biografia
Traduzione di Chiara Vatteroni
Dawn Powell è stata una delle più grandi, e misconosciute, scrittrici americane del Novecento: la sua vita ha i caratteri di una crudele, tragicomica, appassionante fiaba. Seconda di tre sorelle – nasce nel 1896 in una piccola città dell’Ohio – a sette anni perde la madre, che non sopravvive a un tentativo di aborto. La seconda moglie del padre, un commesso viaggiatore alcolizzato, è una donna malvagia e affetta da disturbi psicologici gravi, una vera e propria perfida matrigna per le tre ragazze. A tredici anni Dawn ha già letto Schopenhauer; quando la matrigna trova i suoi primi scritti e li brucia, Dawn fugge di casa e va a vivere a Shelby da una zia; ottiene poi una borsa di studio al Lake Erie College for Women. Nel 1918 arriva a Manhattan: “C’è una sola città per ciascuno, così come c’è un solo grande amore”, scriverà in uno dei suoi numerosi romanzi. La sua frenetica vita newyorchese si svolge per lo più nel Greenwich Village, dove vive con suo marito, il pubblicitario Joseph Gousha, e suo figlio, Jojo, affetto da autismo. “Scrivo perché non ho nessuno con cui parlare”: eppure la sua vita è un susseguirsi di cene e party con buoni amici come Edmund Wilson e John Dos Passos (e Nabokov, Hemingway, Dorothy Parker, Stella Adler), pur senza tradire mai il legame con la sua famiglia e i vecchi amici di scuola. Dawn Powell, che non fu mai una snob o un’arrampicatrice sociale,sapeva essere brutale quando smascherava la falsità delle persone che la circondavano, ma il suo brutto carattere era delizioso e proverbiale. La biografia di Tim Page colloca magistralmente la sua figura nel posto che le spetta all’interno della storia culturale americana. Gore Vidal ha parlato di Dawn Powell come “la nostra migliore scrittrice della seconda metà del secolo” e la sua opera negli ultimi anni è al centro di una vera e propria riscoperta in America e in Europa.
– 12/01/2000
Erano i fatti a sbagliarsi
Negli Stati Uniti, anzi a New York, Dawn Powell (1896-1965) è una scrittrice di culto; e con sacerdoti di qualità come Gore Vidal e John Updike. Quindi che “The Golden Spur” – suo ultimo romanzo, ma il primo a uscire qui da noi – mi abbia lasciato piuttosto freddo, non significa granché: la prossima volta potrei farmi sorprendere sulla via di Damasco e, rimontando a cavallo, contarmi fra i suoi adepti! Ma per ora quasi m’appassiona di più la sua vita, ben ricostruita da Tim page: dall’infanzia in una cittadina dell’Ohio, il padre alcolizzato, i guai con la matrigna crudele ecc., all’approdo a Manhattan e – da allora – l’indefessa fedeltà ai liberi costumi del Greenwich Village. E più del Golden Spur (che però ho letto solo in traduzione), m’ha interessato spigolare i diari, questi si bellissimi, e – come racconta Page (che li ha curati nel 1995) – la sua opera in realtà più di successo: dove agli sketch di scene di romanzo s’alternano “bozzetti perfettamente autonomi, istantanee di una realtà lontana, vivida e vitale”, e anche annotazioni francamente banali – “e tuttavia, proprio perché le banalità di ieri sono così fugaci e rapidamente dimenticate, esiste un arcano piacere nell’ascoltare, insieme a Dawn Powell, una conversazione che ebbe luogo nel bagno di un locale notturno mezzo secolo fa, recarsi in cime all’Empire State Building quando era nuovissimo, spiare una festa cosmopolita a Manhattan nel bel mezzo della Grande Depressione” (Page). Anche i migliori aperçus sull’arte del romanzo li si trova nei diari. Come in questo appunto del 2 giugno 1962 (non citato da Page), di sapore domesticamente neoplatonico: “ho deciso che la mia idea di fondo è che c’è un solo personaggio, un A. gigante che si sfoglia come un carciofo in diversi personaggi – perché ognuno non è che uno stato d’animo o possibilità di quello di fondo, e un romanziere illumina una sola striscia del carciofo. Nello Spur, come altrove, ogni personaggio rappresenta l’eroe in un altro momento – in un’altra situazione – in circostanze differenti. Il frutto si apre, sembra diverse persone, poi si richiude nell’Uno”. Che è una descrizione davvero eccellente del tutto e niente che avviene in “The Golden Spur”, e rende giustizia anche a quella “spinosità” del libro, che in realtà è propria di tutti gli scrittori satirici – come il grande Evelyn Waugh, o Muriel Spark, cui già Edmund Wilson, recensendo il romanzo a suo tempo sul “New Yorker”, aveva accostato Dawn Powell. Come in molti altri suoi libri (ne dà conto Gore Vidal nel bel saggio stampato in appendice), anche il “carciofone” di “The Golden Spur” è un belloccio sempliciotto di campagna (dell’Ohio) che arriva a Manhattan a cercare se stesso: cioè, nel caso specifico, l’uomo sconosciuto (e – Jonathan lo sente e si sbaglia – di gran successo…) con cui la madre ormai defunta l’avrebbe concepito in una giovanile parentesi bohémienne. L’intreccio, comunque, non è che un pretesto per stendere il più ampio affresco di un Village primi anni sessanta, popolato d’artisti e scrittori più o meno da strapazzo (ma ci sono anche parodie di Hemingway e Peggy Guggenheim), yuppie ante litteram, e donnine che non si fanno pregare, anzi rimorchiano loro (“Le donne di città erano meravigliose, stabilì, però molto strane. le sentiva discutere sui meriti relativi dei loro diaframmi ed ebbe il buon senso di capire che non parlavano di canto”). Un po’ troppo lungo, il romanzo è un susseguirsi di scene e schermaglie, tutte piuttosto divertenti in sé, ma un po’ tediose nell’insieme – forse in conseguenza di un arte fin troppo sofisticata, che non cerca la battuta memorabile, così sicura d’averla già trovata per strada. Come in questa rivelazione folgorante (ma quasi non si vede, a metà paragrafo…), che suggella il gran successo di una terapia psico-analitica: “Erano i fatti a sbagliarsi”.
Le mille ombre di New York Una visitatrice permanente racconta la Grande Mela
The Golden Spur di Dawn Powell, traduzione di Alessandra Osti Fazi, pp. 293, 26.000 lire Dawn Powell: Una Biografia di Tim Page, traduzione di Chiara Vatteroni Fazi, pp. 373, 35.000 lire La notte che Dawn Powell entrò in ospedale per non uscirne più, a New York ci fu il primo blackout totale. Due le ipotesi: buio indossato a lutto e quella o profezia dell’oblio a venire. L’una non esclude l’altra. «Io sono New York – in questo momento – adesso»: Dawn Powell, nata e fuggita dall’Ohio, nutrì sempre per la metropoli l’innamoramento strenuo della visitatrice permanente, come si definiva dopo aver abitato Manhattan per più di quarant’anni. Ne scrisse quando ne scrivevano anche Francis Scott Fitzgerald (di cui condivideva l’anno di nascita, il 1896, e l’editor di Scribner’s, il leggendario Max Perkins) e Dorothy Parker (le iniziali e l’arguzia, ma non la notorietà): contribuì a fare di New York un genere letterario, ma ne venne considerata un’interprete minore. Al momento della morte, avvenuta nell’inverno 1965, quasi tutte le sue opere erano fuori catalogo, e lo sarebbero rimaste fino a quando un lungo articolo dell’amico Gore Vidal sul New Yorker la resuscitò dal silenzio vent’anni dopo, innescando un rilancio internazionale: questa di Tim Page è la prima biografia, minuziosa fino alla devozione, e The Golden Spur è forse il capolavoro. Quando venne pubblicato, nell’ottobre del 1962, Dawn Powell non poteva sapere che sarebbe stato l’ultimo romanzo, eppure The Golden Spur ha la qualità enciclopedica ed essenziale di un testamento: c’è il Greenwich Village, ritaglio di boheme nel cuore arlecchino della metropoli, con alberghetti artritici e bar sudaticci dove tutti vanno «finché possono permettersi di non venire», e c’è poi qualche cartolina di nostalgia midwest e il lercio splendore di Broadway. C’è l’ingenuità vigorosa e l’esperienza sfiancata, ci sono poeti, ballerine e altri destini da strapazzo, il saliscendi mercuriale della fama degli artisti e il viavai delle donnine da uno all’altro dei loro letti. Questa, solo e tutta questa, è Dawn Powell, che scrisse più volte uno stesso romanzo – il giovane dell’Ohio con la vita inceppata in una routine di campi e famigliola mentre invecchia sognando il fascino caleidoscopico di Broadway – e poi lo riscrisse molte altre volte allo specchio – il giovane dell’Ohio che morde la Grande Mela rassegnandosi ad abitarla come un bruco di campagna. Non sorprende sapere che questa è stata anche la sua esistenza. Ebbe un’infanzia di una crudeltà da fiaba, con una matrigna che costrinse le figliastre a riesumare il cadavere della sua primogenita nata morta perché l’abbigliamento era ritenuto inadatto, facendola poi riseppellire con indosso i vestiti dell’unica bambola concessa alle tre sorelline. Nella sua parte newyorchese, invece, quella di Dawn Powell fu una vita di ordinarie tragedie, fugaci mondanità e sbiadite soddisfazioni, cucite intorno a un matrimonio sopravvissuto alle scappatelle e all’alcolismo di entrambi i coniugi, e a un figlio autistico. «Solo il romanzo è il mio legittimo consorte», scrisse allora, ed ebbe quindici di questi matrimoni, oltre a un imprecisato numero di brevi flirt da poche cartelle consumati quasi tutti senza passione su riviste e quotidiani di secondo piano. Frequentava con camaleontica disinvoltura i salotti dei Vanderbilt e i tram affollati, Dos Passos, Edmund Wilson e Hemingway così come gli avvinazzati dell’East Side: aveva fatto della sua vita la bozza originaria di ogni romanzo, ma ristabiliva un equilibrio testando nelle conversazioni in società le battute dei dialoghi. Le sue trame, d’altra parte, non erano che pretesti a forma di recinto. Quello che davvero la interessava era la tavola dolorosamente periodica degli elementi umani, e le esistenze che descrive con affettuoso fatalismo hanno la familiarità delle cose eterne riscoperte per caso. Adottò spesso e disordinatamente la tecnica balzachiana del ritorno dei personaggi, ma forse non per scaltrezza narrativa, quanto per un autentico legame materno con le sue creature: le amava «nella loro interezza, senza ritocchi» e, quindi, anche senza giudizi. Forse per questo la brillantezza della sua ironia non si lasciò mai incapsulare nell’epigramma puntuto alla Wilde, né in sgargianti gag hollywoodiane, animando figure e situazioni di una comicità compiuta e autonoma, soffusa di un malinconico calore autunnale. Dawn Powell sapeva che le storie umane, al fondo, non sono che tenaci strategie di autoillusione, meschine o geniali, buffe o patetiche, e per sé aveva scelto la più raffinata. In un romanzo giovanile c’è un’autrice alle prime armi che permette infine a un amico di leggere quello che sta scrivendo, e gli mormora appena: «Questa… be’, questa sono io». Simone P. Barillari
– 07/01/2000
Dawn Powell: una biografia
Una delle più grandi e misconosciute scrittrici americane de Novecento: questo ha proclamato, nel decennio scorso, un inaspettato revival avvenuto negli Stati Uniti, questo promette ora l’editore Fazi con il lancio in contemporanea del primo romanzo di Dawn Powell tradotto in Italia, e di una calorosa biografia a lei dedicata dal giornalista Tim Page. Opere e biografia riservano motivi di interesse: una serie di romanzi popolati di personaggi bislacchi e animati da un saporito spirito di osservazione, in particolare sulla New York artistica e ribelle dove l’autrice visse per un quarantennio; e una vita che miscela elementi drammatici (la precoce morte della madre, un marito alcolizzato, una perfida matrigna, un figlio autistico) con la felicità di amicizie preziose, con Nabokov, Hemingway, Dos Passos, Edmund Wilson…
Fazi propone l’ultimo romanzo e una biografia della scrittrice americana che riuscì a farsi spazio nei salotti newyorchesi. Una vita segnata dalle difficoltà e dalla sofferenza, fino alla morte. Grazie a Gore Vidal il rinnovato interesse dei critici.
La “scoperta” di Dawn Powell. Attenta cronista dei sentimenti
La riscoperta dei talenti artistici dimenticati dal caso o dalla congiura degli eventi dovrebbe risultare un proficuo lavoro per artisti in crisi d’identità: se ne potrebbero ricavare frustazioni cocenti o conferme dei propri valori misconosciuti, in un’ideale passaparola per i posteri, nel gioco sempre beffardo e affollato dei destini. Ci si sono messi d’impegno Gore Vidal e, prima ancora, Edmund Wilson per disseppellire la voce – neanche troppo ignota nell’America degli anni Trenta e i Cinquanta – di Dawn Powell, definita in termini maiuscoli “la più grande scrittrice comica americana”. Non sappiamo se in Italia la sorte decreterà per lei lo stesso destino di riabilitazione toccato in sorte a un John Fante; di certo ci troviamo di fronte a una voce dai contorni ancora troppo sommari per decretarne la sicura grandezza dopo aver letto un solo romanzo, tra l’altro l’ultimo della sua vita. Dalla concreta e precisa biografia di Tim Page emerge soprattutto il ritratto affettuoso di una piccola donna coraggiosa che, in tempi non sospetti – Powell visse tra il 1896 e il 1965 – affrontò le intemperie del destino a testa alta, creandosi un preciso spazio nella New York degli anni d’oro, con amicizie sparse tra intellettuali e animali da salotto, evidenziando le punte d’iceberg dei Dos Passos, degli Hemingway, dei Wilson. Profuga da un retaggio familiare di serie minore nelle campagne dell’Ohia, Powell riuscì a farsi strada tra un ampio spettro di riviste e romanzi di modesto successo, faticando per tutta l’esistenza a tener la testa fuor d’acqua: un’unione quasi virtuale col marito Jack, un figlio autistico che le segnerà la vita anche economicamente, ma su tutto una ferrea volontà di narrare le frivolezze materiali del proprio tempo, tra cronaca mondana e narrativa ricca di spunti ironici e di arguti pettegolezzi da portinaia laureata. Un primo ciclo di romanzi si ricollega al mondo opaco e rustico dell’Ohio, zeppo di fermenti d’odio e lampi di giovanile nostalgia; dal 1936 prende avvio, con “Turn”, “Magic Wheel”, il ciclo newyorchese, in cui la Powell catapultò le sue profonde conoscenze – popolari e intellettuali – del mondo del Greenwich Village da cui si era lasciata catturare fin dall’arrivo nella Grande Mela nel lontano – e quasi magico – 1918. Dalla biografia di Page si rivela l’entusiasmo di una donna briosa e presente alla sua epoca, in grado di reggere – con alterne fortune – al ritmo del caos competitivo della metropoli, passando con disinvoltura da un editore all’altro ma anche, molto sfacciatamente, da un letto all’altro, senza disdegnare alcun tipo di esperienza. Quasi commoventi le curiosità finali, quando quasi settantenne si poneva domande interessate sulla nuova gioventù sballata tra erba e sesso libero, vagabondaggi e droghe esotiche: vediamo una dama d’altri tempi corpulenta e un pò snob, attratta dall’esperienza e dal contatto con la gente vivace e fricchettona per scelta del Village. La fine fu ovviamente povera e destinata all’oblio, addirittura quello dell’allucinante cimitero degli sconosciuti di Hart Island, tra barboni, neonati abortiti, cadaveri senza nome e vittime della sfortuna. All’orizzonte, le luci sempre accese di Manhattan. La riscoperta di Powell va accreditata soprattutto a Vidal, che la conobbe in anni remoti, quando già comunque era palese il divario tra il grande affabulatore e la volenterosa narratrice delle proprie esperienze. Dalla lettura di questo ultimo – e per noi primo – romanzo, abbiamo tratto l’impressione di una simpatica e attenta cronista dei caratteri, vivace e pungente perché critica, anche da un punto di vista strettamente materiale. Certo, in anni dove operavano nomi Faulkner o Nabokov – piuttosto invisi a Powell – ma anche Hemingway, Dos Passos o i primi fuochi d’artificio di Mailer e dello stesso Vidal, troviamo un’autrice che, se da un lato opera con disinvoltura dal punto di vista ironico nel delineare i suoi personaggi, dall’altro poco si discosta dalle atmosfere e dallo stile un pò datato della Wharton, di Willa Cather o anche del più famoso – all’epoca – J. P. Marquand. La modernità adesso esaltata della Powell probabilmente emergerà da una attenta analisi della sua opera: avvicinandoci a questo “The Golden Spur” abbiamo ricavato l’impressione di un tentativo onesto di rivalutare una scrittrice legata a un mondo e a un’epoca eternizzabili soprattutto nell’atmosfera disinvolta in cui ha vissuto e operato. La storia del provincialotto “Jonathan Jaimison” che dall’Ohio approda a New York convinto di trovarvi il proprio padre reale è grottesca e godibile, ma ricollocabile in un tempo determinato, di difficile sovrapposizione metaforica. Si sorride e si riflette, ma come guardando un vecchio film in bianco e nero dove le ragazzotte ciarlano doppiate con voce da pollaio e i maschietti hanno le sembianze un pò ebeti di un James Stewart qui piuttosto libertino. Una cronaca d’antan, collocabile tra il Babbitt di Sinclair Lewis e i primi vagiti del cronista Tom Wolfe: ma vale la pena di curiosare nel suo mondo zeppo di belle caratterizzazioni, non fosse altro che per decretarne un posto privilegiato nell’analisi di costume di un’epoca e nell’omaggio alla mai troppo osannata madre di tutte le metropoli, New York. Per certi versi, Powell potrebbe funzionare nelle vesti della nonna disinvolta di un McInerney, che allo stesso modo inneggiò in seguito alla città, da protagonista attivo. E questo Powell cercò sempre di esserlo.