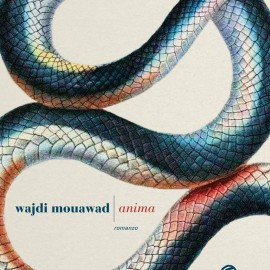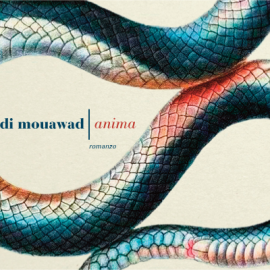
Il re della tragedia si chiama Wajdi Mouawad
• Il blog di Fazi Editore - Recensioni
Pubblichiamo la traduzione di Andrea Marchetto dell’intervista di Ález Vicente a Mouawad Wajdi, autore del cantico bestiale Anima, pubblicata l’8 febbraio 2014 su El Pais.
Le tragedie greche iniziano solitamente con l’irrompere dell’alba. Come in una di queste, Wajdi Mouawad ci ha dato appuntamento alle prime ore del giorno, dopo una drammatica alba nella quale nubi minacciose hanno lasciato il posto a un cielo pallido ma terso. Il drammaturgo e direttore teatrale aspetta in un piccolo caffé del centro di Tolosa, a fianco del mercato de Carmenes, intorno al quale circola una popolazione tra il borghese e il boemo, che si risveglia allo stesso ritmo della città. Mouawad regge un saggio sui fenici con la mano destra. Su questa, si può apprezzare la figura di un grande scarafaggio tatuato, nel quale si può riconoscere il viso di Gregor Samsa dopo una notte di sonno tranquillo. La vita ha portato l’autore a installarsi nella città francese, dove ha conosciuto la sua compagna e dove oggi vive con i suoi figli, lontano dall’intellettualità parigina, che sembra aborrire. «A Parigi esiste ancora una corte che ti tratta senza pietà. Io mi sono formato in teatri di provincia dove ho potuto crescere libero. Non vivrei mai nella capitale», chiarisce. Mouawad non sembrava destinato a passare i suoi giorni necessariamente qui. L’autore è nato 46 anni fa in una comunità cristiana maronita del Libano, si è esiliato in Francia e è sbarcato in Quebec, prima di ritornare convertito in drammaturgo di successo in Europa.
Non si può capire chi sia senza considerare quel drammatico sradicamento, che nella sua opera ha assunto dimensioni quasi mitologiche.
«Questo è il laboratorio che mi ha dato la vita, quello dell’esilio, della guerra, delle lingue che non sono la tua. L’esilio è stato il luogo di una sofferenza atroce, ma anche un paradosso. Mi ha spezzato in due e, allo stesso tempo, mi salvato la vita», racconta con un tremito nello sguardo. «Grazie a esso, sono scampato ai circoli viziosi nei quali sono stato cresciuto. Sono stato un bambino molto amato, ma mi hanno educato a odiare gli altri: ad aborrire musulmani, sciiti, sunniti, drusi, palestinesi, ebrei, israeliani. Tutti allo stesso modo. Nel 1977, quando avevo nove anni, il leader della sinistra druso Kamal Youmblatt fu assassinato». Oggi si ricorda di essere sceso in strada per ballare su un cadavere ancora caldo. «Fino ai vent’anni non ho preso coscienza di ciò che significasse quella celebrazione. Mi è sembrato un gesto profondamente ingiusto, del quale io, oltretutto, ero il boia. La volontà di scrivere nasce da quel sentimento», riconosce.
La sua opera forma un compendio di odissee necessariamente dolorose, i cui protagonisti sono giovani segnati dalla tragedia nonostante non l’abbiano vissuta pienamente. In un determinato momento, tutti si rendono conto di dover fare i conti con un passato che punta nella direzione del Vicino Oriente. «L’infanzia è un coltello piantato nella gola», ha scritto in Incendi (2003), la sua opera più conosciuta, un testo monumentale a metà strada tra il cinema di detective ed eco mitologiche, trasposto al grande schermo dal cineasta Denis Villeneuve, che ha paragonato l’opera a «sopravvivere a un incidente in autostrada».
Nel testo, Jeanne e Simon ricevevano un incarico postumo da loro madre, morta dopo cinque anni di confino in un inspiegabile silenzio: consegnare una lettera a un padre che credevano morto e una a un fratello di cui ignoravano l’esistenza. Dopo aver viaggiato in Libano, riuscivano a svelare il segreto di famiglia che riempiva i vuoti della loro terribile storia. In Litoral (1999), Wilfrid portava alla luce il cadavere di un padre che conobbe appena, cercando un posto in cui seppellirlo nel suo paese natale, senza rotta e con scarso senso dell’orientamento. Loup, l’iraconda adolescente protagonista di Bosques (2006) superava il trauma dell’abbandono seguendo la traccia di sette donne della sua famiglia, le quali attraversarono un secolo di guerre e massacri per «riunire i tasselli sparsi di un puzzle» in diversi punti dell’asse spaziotemporale. Ogni volta che Mouawad cerca di raccogliere questi tasselli per cercare un modo di ricomporli, erige un nuovo progetto teatrale.
Mouawad è figlio di un rappresentante di un’azienda che commercia plastica e di una casalinga, rifugiatisi in Francia durante la guerra in Libano. Appena compiuti dieci anni, il piccolo Wajidi è passato da riconoscere il rumore degli esplosivi che cadevano su Beirut a imparare che Carlo Martello fermò gli arabi a Poitiers, come gli disse un professore del sud-est parigino al suo primo giorno di scuola. La prima poesia che ha imparato a memoria è stata profeticamente, la composizione di Du Bellay che inizia: «Felice che, come Ulisse, ha fatto un lungo viaggio». Assicura che, in Francia, diventò «un esempio di integrazione felice». È stato un eccellente alunno, capitano della squadra di rugby e figlio modello di una famiglia che prova sollievo per aver smesso di sentire il rumore delle bombe.
«E però, vivevamo un’autentica lacerazione, nonostante nessuno osasse dirlo a voce alta», commenta. «Oggi tutti i membri della mia famiglia continuano a lamentarsi: “Non sapete cosa ho passato”. Anche a me succede spesso». Dopo sei anni a Parigi, le autorità francesi decisero di non rinnovare i loro permessi di soggiorno: «Ci dissero che eravamo lì da troppo tempo e che era ora che ce ne andassimo». Sua madre sembrava entusiasta perché le strade canadesi erano pulite, Qualche mese più tardi morì di cancro.
Al giovane Mouawad il Quebec sembrò un luogo immerso in «una pace mostruosa». E anche un luogo in cui nessuno sapeva scrivere il suo nome – che significa ‘esistenza’ e si può tradurre con ‘vita mia’, come puntualizza. Lui e i suoi fratelli erano gli unici in famiglia ad avere dei nomi arabi. «Da piccolo odiavo i miei genitori per avermi fatto una cosa del genere. I miei cugini si chiamavano Pascal, Claude o Antoine. I nomi francesi mi sembravano più belli. Ne volevo uno così anche io», afferma. Fu a Montreal, all’inizio degli anni Novanta, che iniziò a divorare i classici: la Bibbia, l’Iliade, l’Odissea. E, soprattutto, il suo venerato Sofocle, che gli fece vedere la vita sotto un’altra visuale.
«Scoprire la tragedia è stato qualcosa di rivelatore. Mi ha affascinato il carattere fallibile degli eroi greci o il problema della dismisura. Sofocle non smette di ripetere che non bisogna essere presuntuosi, perché nessuno è sicuro che non commetterà l’inimmaginabile», aggiunge. All’improvviso si chiese che cosa sarebbe stato di lui se fosse rimasto in Libano. Sarebbe finito nelle stesse famiglie cristiane che massacrarono Sabra e Chatila? «Secondo i greci, l’immortalità non consisteva nella discendenza, ma nel fare qualcosa di straordinario per il bene della polis, perché il tuo ricordo fosse perpetuato in eterno». Mi dissi che anch’io volevo vivere così», si entusiasma. Sostine che l’ultima cosa che voleva era essere un idiota: «Per i greci l’idiota è colui che non si preoccupa degli affari pubblici e pensa solo a se stesso. Proprio come la gente che oggi dice che non gli interessa la politica e l’unica cosa che gli importa e chiudersi in casa».
Le tragedie di Mouawad non sono esattamente come quelle di Sofocle. Ovviamente, le sue opere portano a un’inevitabile catarsi finale, la stessa che spinge il pubblico a versare lacrime e alzarsi in piedi. Ma non compaiono oracoli ne intervengono deus ex machina che risolvano la faccenda davanti agli occhi sconcertati dei suoi eroi. «Non credo nella predestinazione e il mio rapporto con gli dèi non si basa sull’autorità. Se esiste un Dio, direi che lui crede in me più di quanto io creda in lui», sorride.
Da bambino, suo fratello maggiore lo convinse che gli animali erano capaci di parlare. Come nella favole di Perrault e i film Disney, ma con una maggior solidità metafisica, è esattamente ciò che succede nel suo nuovo libro. Creature domestiche e selvagge narrano l’assassinio di una donna incinta, accoltellata e poi stuprata da un indiano d’America, e il conseguente inseguimento del protagonista, che cercherà vendetta, finendo per trovare la brutalità che risiede in lui stesso, legata – come è costume nell’opera di Mouawad – ai suoi antenati. Anima è un thriller mitologico che ha scritto negli ultimi dieci anni, mentre montava e smontava progetti teatrali. «La narrativa è un genere che solitamente non preferisco alla drammaturgia. Quando scrivo letteratura noto un silenzio nella mia testa. Nel teatro, invece, ascolto un fermento permanente». Mi sono reso conto che avevo bisogno di lavorare a questo romanzo per preservare il mio equilibrio mentale. Era come un giardino segreto nella parte posteriore della mia testa, nel quale mi potevo ritirare quando ne avessi avuto voglia. L’ho tenuto segreto per molti anni, senza sapere bene che cosa farci», confessa.
Nel 2007, durante un viaggio a Barcellona comprò una cartina della frontiera tra Stati Uniti e Canada, territorio in cui è ambientato il romanzo. Casualmente, scoprì che nella zona di frontiera degli Stati Uniti esistevano città con nomi come Lebanon e Gerusalemme. «Osservai la mia vita riflessa in un nuovo territorio. Capì che il romanzo mi stava spingendo verso quei luoghi». E come se non fosse abbastanza, lesse che il luogo era stato scenario di una sanguinolenta battaglia durante la Guerra di secessione: l’Illinois era unionista mentre il Missouri difendeva lo schiavismo. Le falle geologiche unirono quindi due geografie distinte, nelle quali gli animali parlano e gli uomini uccidono. La differenza tra uno e l’altro, come ha scritto giustamente Kafka, è relativa.
La pubblicazione del libro coincide con la rappresentazione del suo spettacolo Seuls nel teatro LLiure di Barcellona. Un monologo che esplora quella che sarebbe potuta essere la sua vita, partendo da un alter ego, Herwan, libanese emigrato in Quebec, che prepara una tesi su questa figura tutelare chiamata Robert Lepage. Di nuovo, il libro e l’opera teatrale permettono di rimuovere le acque torbide dalle sue origini, di riconciliarsi con una redenzione quasi impossibile e indagare nella natura del male più assoluto. «Non sono sicuro che parli del male, come fanno Shakespreare o Sarah Kane», corregge educatamente. «Se versassimo un secchio di acido su ciò che scrivo, rimarrebbe solo una cosa. Quello che m’interessa è il tradimento dell’amore. Ci ostiniamo a credere che saremo sempre capaci di amare, nonostante sappiamo perfettamente che, prima o poi, dovremo accettare che non è vero», argomenta. «E allora ci chiediamo cosa faremo a partire da quel momento».
Dice che suo padre è andato a vedere una delle sue opere solo una volta. All’uscita gli ha detto che avrebbe fatto meglio a dedicarsi alla commedia. «La gente non vuole pensare alla morte», gli ha consigliato. «La gente ha bisogno di ridere». La mancanza di riconoscimento da parte del padre non gli dà fastidio. «Avrei preferito avere il riconoscimento di mio fratello, anche lui scriveva e mi ha influenzato molto», ammette. Mouawad ricorda un corso che impartì l’anno passato a Santander tra registi e drammaturgi giovani. «Chiesi che mi parlassero dei loro progetti. Uno parlava di un padre che non può essere seppellito perché la terra del cimitero è diventata radioattiva. Un altro di due gemelli che si divoravano nel ventre materno. Nessuno si rese conto che stavano parlando della Guerra civile. Quando glielo feci notare, non mi fecero caso». La sua opera ritrae una cultura e una generazione che si considera al riparo dalla guerra, nonostante in realtà la stia vivendo nelle proprie viscere tutti i giorni. «C’è qualcosa di minaccioso in un silenzio troppo grande», scrisse Sofocle. Non è stato necessario chiedergli se sottoscrive.