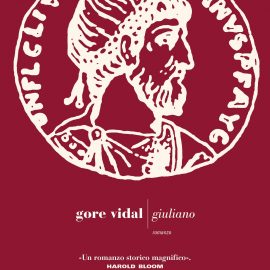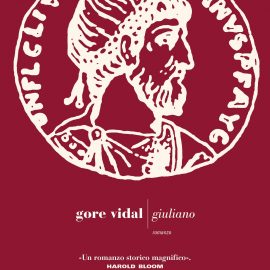
Postfazione di Domenico De Masi a «Giuliano» di Gore Vidal
• Il blog di Fazi Editore
Quando Vidal ha scritto Giuliano aveva più o meno la stessa età dell’imperatore al momento in cui fu ammazzato a tradimento. Mi sono sempre chiesto (ma perché non l’ho chiesto direttamente all’autore?) cosa possa avere spinto un trentenne borghese di Washington a interessarsi con tanta acuta tenacia di un trentenne imperatore romano, e neppure dei più noti.
Vidal ha una vocazione geniale a trasformare la realtà storica in immagini (cioè a creare opere d’arte, come spiegherebbe Benedetto Croce), investigando con gli strumenti della psicologia moderna le pieghe più nascoste dell’anima dei potenti, antichi e prossimi, fino a scovarvi le prove che gli consentono di dimostrare, attraverso la letteratura, le proprie tesi sul corso della storia. Così ha fatto con le guerre di Dario e con Pearl Harbor, così ha fatto con Lincoln e con Roosevelt. E così ha fatto con Giuliano.
Dei quattro romanzi più fortunati che narrano vite di imperatori romani (Memorie di Adriano della Yourcenar, Io, Claudio e Il divo Claudio di Graves, Giuliano di Vidal) questo è di gran lunga il più “colto”, il più ricco di riferimenti a luoghi e fatti precisi, quello che si muove più disinvoltamente tra le figure che si affollarono intorno a Giuliano e nei luoghi innumerevoli in cui, da pagano errante, egli fu spedito o si spedì. Nicomedia, Costantinopoli, Macellum, Pergamo, Efeso, Atene («dove persino i vetturini conoscono Omero»), Milano, Como, Torino, Vienne, Autun, Reims, Colonia, Parigi, Sirmio, Eraclea, Antiochia, Tarso, senza contare le tante località minori e le città conquistate nella fatale spedizione persiana.
Manca Roma perché Giuliano, imperatore romano e visionario cultore del genio di Roma, mai a Roma volle mettere piede, restando, in tutta la sua breve esistenza, sempre e solo asiatico per istinto, greco per cultura, universale per intenzione di conquiste. Del resto, la stessa nomina ad Augusto gli venne non dai romani, secondo il costume romano, ma dai barbari, secondo i loro rituali.
Ma perché Gore Vidal ha dedicato proprio a questo imperatore secondario un’opera così imponente? Per trenta dei suoi trentadue anni, Giuliano visse una condizione due volte mortale: come uomo e come condannato a morte. È questa estrema condizione umana doppiamente precaria che ha indotto Vidal a privilegiarlo dedicandogli cinque anni di studio e un capolavoro letterario?
Quando Giuliano era ancora bambino, lo zio Costanzo gli ammazzò il padre per usurparne il trono e rinviò a un secondo momento l’esecuzione sua e del fratellastro Gallo. Dunque, fino alla morte dello zio, per tre decenni, Giuliano è vissuto come in un braccio della morte, in attesa di un’esecuzione che poteva sopraggiungere da un momento all’altro. Una mossa sbagliata, una parola di troppo, la fugace prevalenza di cortigiani avversi, una minima fobia di Costanzo sarebbero bastate per muovere la mano del boia e chiudere la partita.
Giuliano condivide questa situazione paradossale con il fratellastro, molto più avvenente di lui, parimenti ambizioso, ma assai meno intelligente e mostruosamente bestiale sia per istinto che per ignoranza. Gallo diventerà imperatore d’Oriente grazie alla sua irruenza primitiva, cadrà in disgrazia a causa della sua smodata trivialità, finirà decapitato per alto tradimento. Giuliano è di tutt’altra pasta: aggraziato, letterato, lucidamente sottile, diventerà imperatore d’Oriente e d’Occidente esercitando la sua ben coltivata prudenza, ma cadrà tuttavia in disgrazia per la sua religiosità monomaniacale e resterà vittima della sua apostasia, sprecando la grande occasione di ricompattare un impero imponente, che andava sgretolandosi.
Per quanto diversi fossero i due giovani e nobili morituri, per quanto mostruoso fosse Gallo e ammirevole Giuliano, tuttavia il nostro eroe quasi morbosamente subiva il fascino sinistro del fratellastro. «Eravamo come due animali potenzialmente ostili, costretti a stare nella stessa gabbia» dirà Giuliano, con una metafora assai simile a quella che gli verrà in mente più tardi, quando la moglie Elena lo lascerà vedovo e lo consegnerà a una volontaria castità: «Eravamo due bestie regali, tenute al giogo dallo stesso padrone, per trascinare un cocchio dorato».
Condannato ad essere un problema politico fin dalla nascita, costretto a farsi sgobbone e chierico pur di sopravvivere, messo involontariamente al centro di infinite trame, Giuliano opterà per una trasparente integrità morale e ribalterà l’estrema incertezza della propria esistenza in ossessione per l’immortalità.
È tutto questo che ha conquistato l’immaginazione di Gore Vidal costringendolo a cimentarsi con una figura tuttavia marginale nell’epopea greco-romana?
La struttura che Vidal impone al proprio romanzo è allo stesso tempo lieve e grandiosa, come quella di un tempio classico. Diciassette anni dopo la morte di Giuliano, il vecchio Libanio, un filosofo pagano che fu insegnante e intimo dello sfortunato imperatore, e che tuttora lo venera, decide di riabilitarne la memoria scrivendone, senza peli sulla lingua, una biografia così ben documentata da confutare una volta per sempre le infamanti falsità diffuse dai cristiani contro di lui.
Libanio intende dimostrare che la lotta di Giuliano contro il cristianesimo era giusta e che sarebbe riuscita vittoriosa se i cristiani non avessero congiurato contro l’imperatore uccidendolo a tradimento. Le prove sono in mano a Prisco, anch’egli pagano, vecchio compagno-filosofo dell’imperatore, che, alla morte di questi, era riuscito a trafugarne i diari e le memorie, scritte da Giuliano durante gli ultimi quattro mesi di vita, forse presagendo la sua tragica fine.
Il romanzo racconta lo scambio epistolare di documenti tra Libanio e Prisco, ormai vecchi brontoloni che non hanno più nulla da perdere, e consente così la lettura delle preziose memorie imperiali, commentate in controcanto dalle osservazioni affettuosamente sarcastiche dei due filosofi.
Ecco una probabile chiave che spiega come mai Gore Vidal si sia imbarcato nell’eccentrica avventura storico-letteraria di ricostruire minuziosamente la vita di un Augusto minore. Forse questo capolavoro è nato per la gioia esaltante, consentita ai grandi scrittori, di vincere la sfida sottesa a ogni romanzo storico: intrecciare fantasia e realtà senza che l’una prevarichi l’altra, fino a scolpire un ritratto psicologico così vivo da diventare più autentico del personaggio che fu reale.
Nel nostro caso la sfida è resa ancora più ardua da una duplice circostanza: sulle vicende di Giuliano esistono documenti assai meno numerosi e meno attendibili che non sulla vita di altri più celebri imperatori; allo stesso tempo, però, la storia di Giuliano è estremamente complessa, essendo egli, allo stesso tempo, filosofo, politico, condottiero, scrittore e sacerdote, mosso in misura incandescente dal duplice bisogno di sopravvivere lui stesso e di far sopravvivere la civiltà ellenica, minacciata all’esterno dai barbari e all’interno dai cristiani. I primi soccomberanno sotto la sua genialità di stratega; i secondi lo abbatteranno profittando della sua ingenuità di fanatico.
Gore Vidal, dunque, potrebbe essere stato conquistato dalla doppia sfida di riempire con l’immaginazione i vuoti della documentazione e, allo stesso tempo, di esplorare la personalità obliqua dell’imperatore, dei suoi contemporanei e dei suoi tempi esibendo dosi parimenti sorprendenti sia di saggezza che di ironia: doti, cioè, che generalmente suppongono una maturità assai più solida di quella che siamo predisposti a trovare in uno scrittore di trent’anni.
Si rifletta non solo sulla squisitezza letteraria ma anche sulla maturità riflessiva e sull’acume psicologico di queste schegge che hanno già tutta la forza di aforismi: «Gallo andava sempre in estasi quando la sua sete di violenza coincideva con i modelli di giustizia normalmente condivisi». «Gli dèi che noi adoriamo non sono mai stati uomini; sono piuttosto qualità e poteri divenuti poesia, perché potessimo ricavarne insegnamento». «La follia degli intelligenti è sempre più pericolosa di quella degli sciocchi». «La sua natura già di per sé sospettosa, era esacerbata dalla coscienza di essere in un certo senso meno intelligente delle persone con cui doveva avere a che fare». «La retorica dell’odio è spesso più efficace quando si esprime nel linguaggio dell’amore». «In fondo al cuore, tutti siamo così semplici da diventare incomprensibili». «Gli uomini sono strani. Se non possono essere i primi, non gli dispiace affatto essere gli ultimi». «Per fortuna, quando la maggioranza vede storto, nessuno ci fa più caso – anzi, è la visione perfetta ad essere giudicata anormale». «Siamo dei giocattoli. Un lattante divino ci prende nella mano, poi ci posa e, quando gli aggrada, ci rompe». «La storia non è altro che un inutile pettegolezzo su degli eventi che cessano di essere veri nel momento stesso in cui avvengono». «Agli uomini è sempre piaciuto distruggere, almeno quanto costruire: e questo spiega perché la guerra è tanto popolare».
E si apprezzi l’ironia (diventata ormai proverbiale) di Gore Vidal in queste osservazioni fulminanti: «I miei concittadini si lasciano comprare con poco, ma sono troppo frivoli per restare fedeli a chi li ha comprati». «Il vescovo aveva il dono di spiegare solo le cose che uno sapeva già, lasciando avvolte dal mistero quelle che invece si vorrebbero conoscere». «Non hai mai notato che quando un medico prescrive questa o quella cura, e il paziente la segue e guarisce, dopo ha sempre un’espressione un po’ sorpresa?». «Ai medici piace che i loro pazienti si spengano in modo corretto e irreversibile». «Aveva fama di essere stupido, e io non ho motivo di contraddire l’opinione generale». «Hai il dono, Cesare, di rendere impossibile quello che già è difficile!».
Per quanto impietose, queste affermazioni non sono imparentate con l’ironia di un Voltaire, non trasudano aromi salottieri: sembrano scolpite nel marmo come si addice al pensiero classico distillato dalla filosofia greca.
Ma perché Gore Vidal ha dedicato cinque anni della sua giovinezza e una parte notevole della sua genialità artistica a questa figura comunque secondaria del panteon classico? Arriva ad accreditare Giuliano persino come migliore di Marco Aurelio, che reputa sovrastimato dai posteri. Lo preferisce ad Adriano, che non perde l’occasione di ridicolizzare per il suo straripante amore nei confronti di Antinoo. Lo paragona e persino lo antepone ad Alessandro per originalità strategica e meditata temerarietà. Gli contrappone simmetricamente la figura di Gallo per costruirgli un lato oscuro che ne metta in ulteriore risalto lo splendore. Perché tanta generosità verso un Cesare Augusto minore?
Il Giuliano che Vidal tenta a tutti i costi di farci amare, in parte riuscendoci, è un giovane intellettualmente precoce, disinteressato al denaro, avido di libri, costituzionalmente incline alla filosofia, parimenti capace di capire gli uomini e manovrare gli eserciti. Ma è anche un giovane puerilmente schiavo dei presagi e dei maghi, dotato di una intelligenza acutissima ma rivolta al passato assai più che al futuro, patologicamente affetto da una inguaribile monomania: riconquistare all’ellenismo, sottraendole alla Chiesa, tutte le masse degli ancora indecisi; difendere il culto degli dèi pagani dall’invadenza della teologia cristiana, scaltra debitrice a Mitra e all’Olimpo di tutti i suoi dogmi e delle sue credenze contrabbandate come originali; salvare la perfezione estetica e filosofica del mondo classico dalla rozza minaccia della supponenza ecclesiastica che, a suo parere, non aveva ancora vinto la partita proprio a causa dell’accanimento con cui traduceva le controversie dottrinali in massacri degli “empi” e persino degli stessi fedeli. «In quanto a ferocia, al mondo non c’è nulla che eguagli un vescovo a caccia di “eresie”».
A questa sua monomania, il Giuliano descritto da Vidal immolerà migliaia di vite umane e la sua stessa giovane esistenza, tendendo fino allo spasimo la corda della sua vita, senza mai rendersi conto che la propria stella brillava sulla fine di un mondo, mentre la stella di Adriano e quella di Alessandro avevano brillato su due mondi allo zenit.
Giuliano pretende di ringiovanire un sistema invecchiato, di trasformare l’inverno in primavera, di liberare l’Olimpo ellenico dalla marea montante della religione cristiana. Follemente si imbarca nella tentata conquista della Persia, e vagheggia quella dell’India e della Cina, per eguagliare e superare Alessandro, per conquistarsi un arco di trionfo nel foro di Roma, per sancire definitivamente il trionfo delle religioni elleniche su quella cristiana, per portare la verità dei “suoi” dèi fino agli estremi confini dell’Oriente barbaro. E perché la Persia è la terra santa del suo Mitra e del suo Zarathustra.
Ma forse, alla fine dei conti, Giuliano non era nient’altro che un conservatore che ha vagheggiato per tutta la vita l’impossibile ritorno a «quell’incantevole mondo perduto in cui gli dèi, prima di essere perseguitati, vivevano ancora tra noi, e la terra era semplice e gli uomini buoni». Gore Vidal sa bene che questa perduta età dell’oro, più affine alla semplicità contadina di Esiodo che non alla complessità epica di Omero o a quella filosofica di Platone, non è mai esistita. Perché, dunque, concedere tanta importanza a un lontano imperatore che follemente l’ha inseguita?
Giuliano è un libro cupo, funestato nella prima metà dalla incombente condanna a morte di Giuliano e nella seconda metà dalla ineludibile predestinazione del nostro eroe a un sacrificio precoce.
Della incombente esecuzione vi sono mille continui segnali; del pessimo futuro vi sono mille continui presagi. E la solida preparazione filosofica, che ha conferito a Giuliano la scaltrezza necessaria per scampare all’esecuzione, non basta per assicurargli la prudenza necessaria a salvarlo dalle congiure. Né basta per dargli l’unità di misura necessaria a comprendere che i riti pagani non sono meno illusori di quelli cristiani.
Perché mai la medesima sapienza filosofica basta a Prisco per restare laico e non basta a Giuliano per diventarlo? Come mai Prisco è così saggio da accontentarsi del suo ruolo di filosofo, guadagnandosi la longevità, mentre Giuliano è così saggio da capire che la saggezza non è tutto? Ma, in fondo, «chi può sapere da quale porta entrerà la saggezza?». E quale saggezza?
Forse sono stati questi dubbi umanissimi, e il desiderio di fugarli, che hanno spinto Gore Vidal a ricostruire minuziosamente l’avventura terrena di Giuliano, nella speranza che la storia di un uomo eccezionale potesse decifrare il mistero di tutte le altre umane avventure.
E quando Libanio esclama: «È tutta una commedia, Prisco! È una tragedia!», il lettore ha l’impressione che Vidal lo abbia prodigiosamente condotto sul punto di attingere il segreto della nostra esistenza, così come Massimo condusse Giuliano negli estremi vortici luminosi dell’iniziazione ai misteri.
E qui, nella mente del lettore, si fa strada finalmente un’ipotesi. Ma siamo sicuri che Giuliano sia stato un Augusto minore? Siamo sicuri che Gore Vidal abbia capricciosamente dedicato un capolavoro a una stella secondaria della galassia imperiale?
Come condottiero, Giuliano ottenne la più grande vittoria degli eserciti romani in Gallia dopo Giulio Cesare. Come governatore fu clemente, giusto e inflessibile. Come uomo fu affascinante. Come scrittore fu brillante. Come amante fu tenero. Come marito fu fedele. Come conquistatore arrivò da Parigi a Ctesifonte. A trentadue anni realizzò imprese che Traiano, universalmente elogiato come il massimo stratega romano, non riuscì a compiere nel doppio degli anni. Ancora giovanissimo, fu imperatore di Roma e signore del mondo.
Giuliano era consapevole della umana finitezza, anche quando un uomo è imperatore. Perciò si mantenne sobrio, discreto, generoso, autentico, esplicito, autocritico per tutta la vita. Certo, era anche vanitoso, ma non pretendeva mai più di quanto gli spettasse. Aveva troppa fretta di imporre al mondo le proprie idee religiose, ma aveva studiato quasi trent’anni per approfondirle e per convincersi che esse erano le più adatte a farsi carico dell’umana felicità.
Ma, allora, perché generalmente si ritiene che Giuliano sia meno grande di Cesare e di Augusto, di Adriano e di Marco Aurelio? Perché nei nostri libri di storia la sua epopea viene liquidata in poche righe e il suo nome resta inscindibilmente legato al marchio infamante di «apostata»? E cosa significa, in fondo, quella parola «apostata» che tutti, anche i laici, continuano a ripetere sprezzantemente e acriticamente?
Il 4 febbraio del 362 l’imperatore Giuliano Augusto ribaltò l’editto con cui Costantino aveva privilegiato la religione cristiana e, coraggiosamente, coerentemente, proclamò la libertà di culto in tutto il mondo, ripristinando l’eclettismo di Roma, che mai aveva tentato di imporre un credo unico ai popoli conquistati, ritenendo giusto che la varietà degli dèi rispecchiasse la varietà della natura e delle genti. Giuliano Augusto si batté con tutte le forze contro Gesù considerandolo un semplice rabbino riformatore, un ribelle che aveva tentato di farsi eleggere re e che per questo era stato giustiziato. Con pari veemenza e coerenza Giuliano Augusto combatté i cristiani che, ai suoi occhi bene informati, apparivano nevrotizzati dall’idea della morte, rinunciatari, crudeli, colpevoli di saccheggiare con pari voracità sia i riti ellenici per farne feste cristiane, sia i templi pagani per farne chiese e ossari.
Nella mente di Giuliano, esercitata per anni agli studi filosofici, appariva inaccettabile che mille generazioni di uomini, fra i quali Omero e Platone, avessero potuto sbagliare tutto in materia di religione, mentre una manciata di semplici pescatori della Galilea fosse arrivata a capire tutto, in un batter d’occhio, privilegiata da una rivelazione immeritata.
«Col senno di poi, le sue azioni mi sembrano quelle di un pazzo», ammette Prisco. Ma si trattò comunque di una pazzia che, come quella di Amleto, possedeva un metodo, era guidata da una strategia e, armata di eserciti e di poteri, rischiava persino di riuscire vincente. Perciò un giavellotto romano, vibrato dalle mani di un congiurato cristiano, convinto di rendere un servizio al proprio dio, mise fine all’ultimo umano tentativo di ripristinare l’ellenismo.
Ecco dunque perché, con buona ragione, il ribelle Gore Vidal ha dedicato un capolavoro proprio al ribelle Giuliano Augusto. Certamente, come Prisco, anche Vidal preferisce l’intelligenza dell’uomo a tutte le magie. Né gli è dato sapere se il mondo ispirato all’Ellade che tanto piaceva a Giuliano sarebbe stato più vero, più buono, più bello del mondo ispirato al Golgota, che tanto piace ai cristiani. Di certo, però, Giuliano non merita il posto defilato cui lo condannarono i suoi successori cristiani, preoccupati di ucciderne subdolamente la memoria così come subdolamente ne avevano stroncato la vita.
Ancora giovanissimo, Gore Vidal dedicò cinque anni della sua prodigiosa intelligenza, della sua geniale creatività, della sua smisurata erudizione a ripristinare una verità storica astutamente travisata, così come Giuliano, alla medesima età, aveva dedicato tutte le sue forze a ripristinare una fede religiosa ritenuta autentica ma ormai tradita e un modello di vita reputato felice ma ormai smarrito. Vidal lo ha fatto con le armi della letteratura; Giuliano preferiva farlo con le armi della filosofia o, se non bastava, degli eserciti.
E quando, con estremo rammarico, il lettore termina la lettura di questa grande epopea, ha ormai fatto proprie le parole di Prisco: «A volte ho l’impressione che la storia dell’impero romano sia un’unica, interminabile ripetizione delle stesse facce. In fondo si assomigliano tutti, questi uomini d’azione: solo Giuliano è stato diverso».
Domenico De Masi
Articoli sullo stesso libro