«I romanzieri: William Makepeace Thackeray» di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
• Il blog di Fazi Editore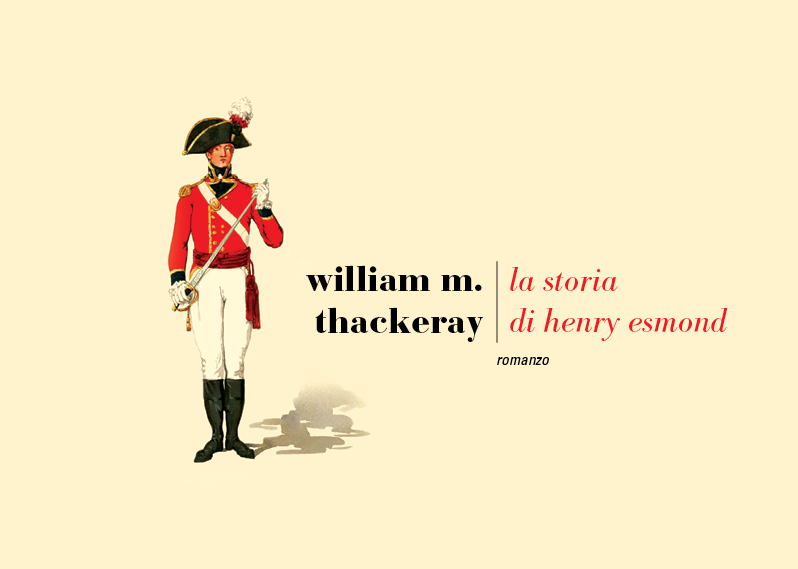
Il dissidio Shakespeare-Ben Jonson si ripete nell’età vittoriana fra Dickens e Thackeray. In formato ridotto, si capisce: e chi del resto non sembrerebbe un piccolo uomo al cospetto di Shakespeare? Ma se distogliamo lo sguardo dai predecessori, vedremo bene che si tratta in realtà di un dissidio fra colossi. E il dissidio è posto esattamente nei medesimi termini che, del resto, sono eterni: estro contro scuola, romanticismo contro classicismo. Questa volta però i due contendenti sono quasi di egual statura. Anche i “classicisti” più accaniti non si sono mai arrischiati a sostenere che Ben Jonson potesse essere ritenuto superiore a Shakespeare. Molti invece, oggi, pongono la levigatezza e il “buon senso” di Thackeray al primo posto dinnanzi alla “sciatteria” e alla “quasi demenza” (half–lunacy) di Dickens.
Cercheremo adesso di dipanare un po’ questa matassa che è unicamente frutto di un equivoco, come ho già detto. Ma s’intende che l’unico modo per porre un vero giudizio è leggere, bene e con attenzione, l’uno e l’altro. E dalla lettura di ognuno dei due rivali si possono trarre grandi profitti e grandi acquisizioni estetiche.
Le vite di Dickens e Thackeray formano un acuto contrasto, specie durante la loro gioventù. Furono educati a scuole diverse, intendo dire scuole di vita, non letterarie.
Thackeray era un anglo-indiano, nato nel 1811 a Calcutta, figlio di un alto e ricco funzionario della East India Company. All’età di sei anni, età alla quale il clima indiano comincia a esser nocivo ai bambini, venne inviato in collegio in Inghilterra; si era nel 1817; la nave fece scalo a Sant’Elena per rifornirsi di acqua; il piccolo Thackeray fu condotto a godersi la vista di Napoleone che passeggiava come un leone ingabbiato nei giardini di Longwood. Egli fu quindi uno di quegli «abominables petits morveux anglais» dei quali si lagnava l’imperatore. Dalla scuola passò a Cambridge dove non si laureò ma strinse parecchie utili amicizie. Dopo di che passò un paio di anni a Weimar e poi si recò a Parigi. E più per divertirsi che altro cominciò a pubblicare articoli in vari giornali e riviste accompagnandoli di disegni perché egli possedeva anche un divertente talento di pittore. Non è stato facile, dopo, andare a ripescare queste prime opere di Thackeray perché egli usava un numero enorme di pseudonimi e ancor oggi non si è sicuri che tutto sia stato scoperto. Questo del resto non ha molta importanza: in questo nugolo di saggi, schizzi, pezzi di colore ecc. che andava pubblicando sotto il nome di Yellowplush, Titmarsh, FitzBoodle e Ikey Solomons, non vi è nulla di artisticamente notevole, benché vi si preannuncino tutti i temi usati poi nella sua arte matura.
Nel 1840 Thackeray ebbe il più grande (ed il solo) dolore della sua vita: sua moglie impazzì dopo quattro anni di matrimonio: e impazzì malamente, debuttando con un tentativo di uccidere l’infelice Titmarsh, continuando col rompere «everything in my flat except my neck» e finendo con lo strangolare un’infermiera nella casa di salute.
Forse naturale maturazione del suo talento, forse una eccitazione comunicatagli dalla pazzia della moglie, da quel momento Thackeray cominciò a scrivere sul serio.
Nel 1841 venne pubblicato The Great Hoggarty Diamond, per il quale Thackeray utilizzò i propri ricordi di bohème parigina, e che mostra di già le qualità di solidità e di eleganza dell’autore. Nel 1842 The Luck of Barry Lyndon, opera abilissimamente costruita ma sgradevole per il suo non sincero cinismo. Nel 1843 The Irish Sketch Book, raccolta gradevolissima e acutissima sotto l’aspetto umoristico delle impressioni riportate durante un viaggio in Irlanda.
In quegli stessi anni Thackeray contribuì alla fondazione del «Punch», il famoso settimanale umoristico che continua ancora oggi vigorosissimo la sua carriera. E da allora in poi sarà nel «Punch» che verranno pubblicate quelle serie di penetrantissimi studi che furono poi raccolti sotto il titolo di The Book of Snobs. Non bisogna dimenticare che è stato Thackeray a “lanciare” la parola “snob”, che doveva poi avere tanta fortuna e finire con l’accettare un significato radicalmente opposto a quello originario. Di questa specie particolare di snobs, cioè di quella vera, Thackeray compie uno studio accurato, penetrante e quanto mai divertente in questo libro che è uno dei più riusciti della sua produzione minore.
Nel 1847-48 venivano pubblicate sul «Punch» le puntate di Vanity Fair, uno dei capolavori del nostro autore. Capolavoro sul serio. L’omogeneità, la novità, l’ardire (per l’epoca vittoriana) del romanzo sono assoluti. Lo studio dei caratteri, l’humour continuo ma mai esplicito, la nobile risolutezza dell’autore di non lasciarsi trascinare al “lieto fine” malgrado il decorso fondamentalmente allegro delle vicende, la sottile vena di patetica poesia che circola in queste vicende mondane fanno di Vanity Fair uno dei grandi romanzi, uno dei dieci o venti migliori che vi siano. Basterebbe la figura di Becky Sharp, la graziosissima intrigante sconfitta, a farne un’opera di assoluto primo piano. Ma Becky è lungi dall’essere la sola figura originale del libro: Sir Pitt Crawley, Jos, Captain Dobbin sarebbero, ognuno da solo, eccellenti protagonisti di qualsiasi altro romanzo.
E bisogna osservare che uno di questi personaggi sarebbe possibile immaginarlo trattato da Dickens; essi sono “essenzialmente” di Thackeray e ciò basta a comprovare quanto sia errato qualsiasi paragone di valore fra Dickens e Thackeray. Si può preferire personalmente l’uno all’altro; probabilmente si nasce Dickensiani o Thackerayani come si nasceva Platonisti o Aristotelici, e ciò dipende da particolari condizioni di carattere, di cultura e di ambiente; ma quel che non si ha il diritto di fare è il trovare Dickens “volgare” e Thackeray “raffinato“, due aggettivi che nell’arte, a questo livello, significano men che niente e si risolvono in un biasimo per l’autore che si vuole lodare.
Sarebbe (forse) più plausibile dire che Dickens descrive i suoi personaggi “liricamente”, mettendosi successivamente nella pelle di ognuno di essi, mentre Thackeray li guarda con un certo distacco; li giudica con serena imparzialità e non si affeziona a nessuno di loro. Egli è un po’ l’artista distante che vede le azioni degli uomini, le trova ridicole o commoventi, le descrive con somma perizia ma senza compartecipazione. Le numerose allusioni discorsive che in Vanity Fair e altrove egli fa alle “marionette” sono una confessione di questa sua forma mentis. Esse mancano totalmente nell’opera di Dickens per il quale Pickwick e Micawber erano evidentemente delle solide realtà.
Sia come sia, è assolutamente necessario leggere Vanity Fair, che rimane un grandissimo romanzo.
Inferiore come opera d’arte ma ancor più rivelatore dell’estetica del suo autore è Pendennis, pubblicato nel 1848-50. Per qualsiasi altro scrittore la tentazione d’idealizzare il personaggio di Pendennis sarebbe stata irresistibile, perché egli rappresenta Thackeray stesso nella sua gioventù. La superiore imparzialità dell’autore resiste, e Pendennis è reso frequentemente come un uomo irritante e talvolta come persona addirittura detestabile. E ciò, si capisce, non in modo arbitrario ma con logiche, rigorose deduzioni dalle premesse già fatte. I personaggi del Maggiore, del Capitano e di Morgan sono dei veri e propri trionfi; Helen è un saporito miscuglio di materna amorevolezza e di femminile slealtà, Blanche è costantemente divertente, Laura è una tale trovata fra le “marionette” di Thackeray che sarebbe facile dire che Pendennis supera Vanity Fair in piacevolezza, se non fosse che la costruzione generale e il “montaggio” delle scene sono nettamente inferiori e mancano del continuo allant delle vicende di Vanity Fair.
Infatti il secondo capolavoro di Thackeray non è Pendennis ma il libro che lo segue, Henry Esmond (1852). È un romanzo storico nel quale l’autore fa sfoggio della propria perfetta conoscenza degli usi e del linguaggio del periodo della Regina Anna. Ma ciò costituisce soltanto una preziosa cornice del vero dramma che è narrato in prima persona dal grave e modesto protagonista al quale Thackeray ha fatto compiere il prodigio di far apparire giustificato e inevitabile un trasferimento di amore da una figlia alla madre di lei, caso abbastanza raro. La tessitura, la tecnica formale del romanzo è stupefacente e lo stile, nella sua doppia accezione di modo di scrivere e di giusta resa dell’ambiente, perfetto. E chiunque l’abbia letto una volta non dimenticherà più la scena famosa nella quale si presenta per la prima volta Beatrice nell’atto di scender la scala con il candelabro in mano. Una scena, fra tante, nella quale la prosa, pur mantenendosi familiare, uguaglia la più alta poesia e gareggia con la pittura più ricca di toni.
Non dimenticate di leggere Esmond:
è un boccone da re.
Questo semi-dilettante, in Vanity Fair e in Esmond, è riuscito a pareggiare i massimi.
In altri tempi le opere di assoluto prim’ordine di Thackeray erano tre. Il gusto del suo tempo esaltò alle stelle The Newcomes (1853-55). Esso adesso ci appare come un troppo lungo romanzo, irto di scene deprimenti rese senza compartecipazione, come era prevedibile, e riempito di caratteri assurdi. Non tutti, si capisce: per esempio Lady Kew è il più perfetto disegno, fra i molti tracciati da Thackeray, di una acuta e cinica signora del gran mondo.
Dopo Esmond la vena di Thackeray era decisamente in ribasso. The Virginians (1857-59) è nettamente illeggibile (ma letto, da me). Thackeray, che aveva voluto dare un seguito a Esmond, vi ha commesso l’errore di essere eminentemente noioso e il delitto di ripresentarci la sua squisita Beatrice, invecchiata, incattivita e orribile. Metamorfosi che nella vita vediamo ad ogni piè sospinto ma alla quale deve rifiutarsi la penna di uno scrittore che assume degli obblighi verso i personaggi da lui creati.
Altre opere, non romanzesche, di Thackeray sono i suoi studi critici su The English Humourists of the Eighteenth Century (1851), di una penetrazione e di una dilettosità rare e che degnamente lo inseriscono nella grande serie degli artisti-critici, e The Four Georges (1856) che è meno buono ma diverte per la copia di aneddoti raccolti su questi quattro sovrani, dopo tutto, babbei.
Nel 1863 Thackeray morì, vittima del suo vizio prediletto, la ghiottoneria. Egli stesso dichiarò prima di morire, in un gioco di parole anglo-francese: «My exit is the consequence of too many entrées».
Lasciò incompiuto un romanzo, Denis Duval, che, come l’ultima opera di Dickens, mostrava un fortunato ritorno alla maniera di Esmond e prometteva di essere una delle sue opere migliori.
Da quanto ho detto risulta chiaro che un “mondo” di Thackeray non esiste; senza essere un po’ matti non si creano dei mondi (come si dimostra nella Genesi). E Thackeray, l’acuto, l’imparziale, il cinico Thackeray tutto era fuorché matto.
Mondi, niente. Ma uomini sì. Mentre i personaggi di Dickens non possono essere iscritti a nessuna anagrafe, Becky Sharp, Joe, Sir Pitt, Dobbin, Pendennis, Helen, Morgan, Esmond e Beatrix sono delle aggiunte alla Stato Civile.
Inoltre, stilista grande. Mentre Dickens, trascinato da una sua foga super-naturale, butta giù e fa strafalcioni e solecismi ma raggiunge le cime, Thackeray sta a pensarci su e le cime le raggiunge lo stesso, non a forza d’impeto ma mediante l’attenzione. Lo ha detto lui stesso: «Genius is perhaps an infinite aptitude at taking pains».
Appunto per questo Vittoriano perfetto.
Quando tutto questo sia stato detto, quando si sia reso giustizia all’uno e all’altro, quando si sia riconosciuto il posto altissimo di Thackeray, la sua forse maggiore intelligenza, la sua forse superiore energia icastica, la sua indubbiamente più scelta schiera di adoratori, il suo maggior titolo ad esser chiamato “artista di primo piano”, quando tutto ciò sia stato concesso, firmato, controfirmato, siglato e bollato, rimane il mio personale parere: Thackeray è un grandissimo uomo, Dickens, però, è un semidio.
(E sento già le pietre dei lapidatori fischiarmi intorno al capo).
GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA
