Tradurre «Storia del figlio» di Marie-Hélène Lafon
• Il blog di Fazi Editore - Parola ai traduttori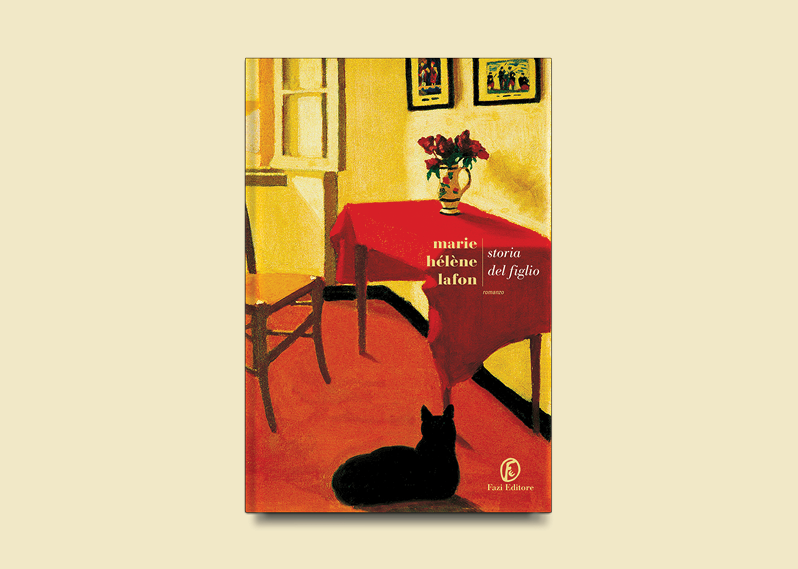
In occasione dell’uscita di Storia del figlio, vi proponiamo la riflessione di Antonella Conti sulla traduzione del romanzo di Marie-Hélène Lafon.
Quando mi accingo a raccogliere le idee per questo contributo, scruto nelle pieghe della memoria per ritrovare la cronologia e le circostanze del mio primo incontro con Marie-Hélène Lafon. Lo devo forse all’amico Bertrand, lettore seriale e ispiratore di felici scoperte francofone, che mi ha regalato Sur la photo e L’Annonce una manciata di anni fa? Sì, è quasi certo. Grazie Bertrand.
Ma è altrettanto probabile che la fascinazione conosciuta allora non avrebbe avuto la stessa immediatezza ed evidenza se non fosse stata preceduta dall’ammirazione ormai consolidata per i documentari di Raymond Depardon, ineffabili viaggi visivi tra quegli stessi altipiani dalla bellezza incongrua e brutale, tra quelle stesse vite sepolte in fattorie remote di cui racconta Marie-Hélène Lafon. Vite minuscole, per citare l’immenso Pierre Michon e il titolo del suo romanzo, “il libro che ha cambiato la vita” di Marie-Hélène Lafon “costringendola a cominciare a scrivere”, come rivela lei stessa in un’intervista. E poi naturalmente c’è l’impronta, davvero nitida, di Gustave Flaubert, al di là del garbato clin d’oeil al celeberrimo incipit di Madame Bovary che in questa Histoire du fils apre un capitolo-quadro, il secondo (“Erano nell’aula di studio”, p. 23).
Rinuncio a stabilire l’esatta provenienza delle suggestioni, delle visioni, delle voci autoriali che accompagnano nella mia mente il nome di Marie-Hélène Lafon, echi profondi di una Francia lontana da Parigi, provinciale e assopita, aspra e arcaica, poetica e struggente. Quel che è certo è che, nella mia percezione, tutte confluiscono nella raffinata letterarietà di Storia del figlio, premio Renaudot nel 2020, probabilmente il capolavoro di quest’autrice cresciuta in una fattoria del Cantal come molti dei suoi personaggi, poi “transfuga sociale” a Parigi, dove insegna lettere classiche.
Simili a tableaux vivants illuminati ciascuno da una luce che gli è propria, i dodici capitoli di questa saga famigliare lunga un secolo (1908-2008) si emancipano dalla linearità cronologica e prendono corpo intorno a dodici date cardine e altrettanti nuclei narrativi dominati dalla voce di un personaggio. La storia di un figlio, come recita il titolo, abbraccia e articola quelle dei suoi antenati e discendenti, e tutte s’innestano nei gangli della grande Storia del Novecento. Da un luogo all’altro, da un personaggio all’altro, da un’epoca all’altra, ogni tappa lascia emergere un mondo vivo, concreto, sensualmente tangibile eppure avvolto da un’atmosfera rarefatta e vibrante. Non ci sono dialoghi in questo romanzo, ma il discorso indiretto libero anima il testo come una linfa che meglio non potrebbe servire una trama intessuta sul segreto, sul non-detto, sul dato impressionistico. La parola della narratrice si confonde con quella dei personaggi, modulandosi sul ritmo del loro respiro interiore.
La prosa di Storia del figlio, esatta, rigorosa, essenziale pur nella sua portata immaginifica, sembra cullare il lettore in un dolce sciabordio, ma poi qua e là s’impunta in un silenzio, un’omissione, o al contrario si espande in una colata verbale che spazza via la punteggiatura e con questa, a volte, la consequenzialità discorsiva. Spesso dilaga in libere associazioni, monologhi interiori in cui il linguaggio viene manipolato dai personaggi come un oggetto magico e apotropaico, oppure smontato e rimontato come un gioco del meccano, indagato nelle sue leggi grammaticali, nelle convenzioni del lessico famigliare, nei tic individuali.
Ci si lascia così trasportare dalla corrente delle percezioni sinestetiche del piccolo Armand, il quale “riflette molto sugli odori e sui colori delle persone, delle cose, delle stanze o dei momenti” (p. 13), e perciò non esita ad attribuire al fratello Paul “l’odore del vento e della lama fredda dei coltelli” (p. 14), mentre per la madre è incerto, forse quello “[del] rosso”, o forse “[della] neve quando la sera diventa blu ai margini del bosco” (p. 14). Ci si commuove davanti ai tentativi di André, dieci anni, di servirsi della grammatica per rimettere in ordine i pezzi di un destino che gli ha negato la possibilità di costruire compiutamente la propria identità: “Sconosciuto è un aggettivo qualificativo, ne è sicuro, su questo, sulla grammatica, può contarci. A padre sconosciuto, figlio sconosciuto. Lui e quel padre avrebbero dunque in comune un aggettivo di quattro sillabe, la prima delle quali contiene un prefisso di senso negativo” (p. 56).
André parla a lungo con se stesso, e nel farlo interpella il proprio linguaggio personale e segreto, lo utilizza come un viatico per insinuarsi nei meandri della coscienza: “Léoty è il cognome di sua madre, e il cognome da ragazza di Hélène; gli piacciono queste parole, il cognome da ragazza, anche sua madre dev’essere stata una ragazza, intuisce grossomodo che le donne sono delle ragazze prima che nascano i figli, ma le donne che sono delle vecchie madri senza marito, come la sua, non restano comunque ragazze più a lungo delle altre; si dice ragazza e figlio di vecchi; le sue cugine sono delle ragazze e lui un figlio di vecchi…” (p. 56).
Riconosce i tratti variegati del parlato altrui, li incorpora con benevolenza e gratitudine nel proprio universo verbale: “Fino a Juliette, le altre donne non lo avevano attirato più di tanto; Silvia avrebbe detto che non gli stuzzicavano l’appetito. Aveva nelle orecchie la sua voce e le sue piroette con le parole. Col passare del tempo sentiva che alcune espressioni gli sarebbero rimaste, avrebbero fatto parte di lui per sempre […] si dibattevano sotto la pelle come bestie intrappolate…” (p. 47-48).
Gabrielle, quanto a lei, sembra essere il personaggio antifrastico a suo figlio André per quel che riguarda il rapporto col linguaggio. Con i famigliari, rifiuta qualunque discorso che possa sfiorare il suo segreto, e di fatto costringe al silenzio anche gli altri: “[…] con Gabrielle non si poteva parlare, neanche Hélène poteva, e André ancora meno. Gabrielle sorvolava su tutto…” (p. 41); oppure si rifugia nella frivolezza, nella negazione del reale potere comunicativo della parola: “Gabrielle lancia parole in aria, ma poi non insiste, e riparte, col suo profumo aspro, i suoi abiti di Parigi, il suo pianoforte” (p. 60).
Infine, bisognerebbe almeno accennare a quei tratti di oralità che percorrono il romanzo, a quel linguaggio talmente presente e riconoscibile da apparire quasi un altro personaggio locutore. Si tratta di un socioletto garbatamente popolare dall’espressività intensa, dal vocabolario corposo e un po’ sanguigno, spesso desueto, con cui si costruiscono ghirlande di proverbi, doppi sensi maliziosi, metafore allusive cariche di affettività.
La palette stilistica di Marie-Hélène Lafon è inesauribile. Potremmo soffermarci ancora a lungo sulle sue nuance, sulle strategie narrative messe in atto dall’autrice, ma questo ci porterebbe troppo lontano. Meglio concludere, semplicemente, con le parole luminose che ha usato per raccontare il rapporto con la propria arte: “Un testo si inventa, si scrive, si forgia, parola per parola, segno per segno, frase per frase. Ogni frase si percorre, si respira, passa attraverso il corpo: sale dalle viscere per ergersi nell’aria. […] La scrittura per me è qualcosa di fisico, […] una faccenda carnale”.
Parole di cui le sono grata, perché non si potrebbe spiegare meglio quello che da lettrice e da traduttrice ho sentito essere il moto propulsivo di questo piccolo grande romanzo.
Antonella Conti
