Tradurre «Il Re del Grano e la Regina della Primavera» di Naomi Mitchison
• Il blog di Fazi Editore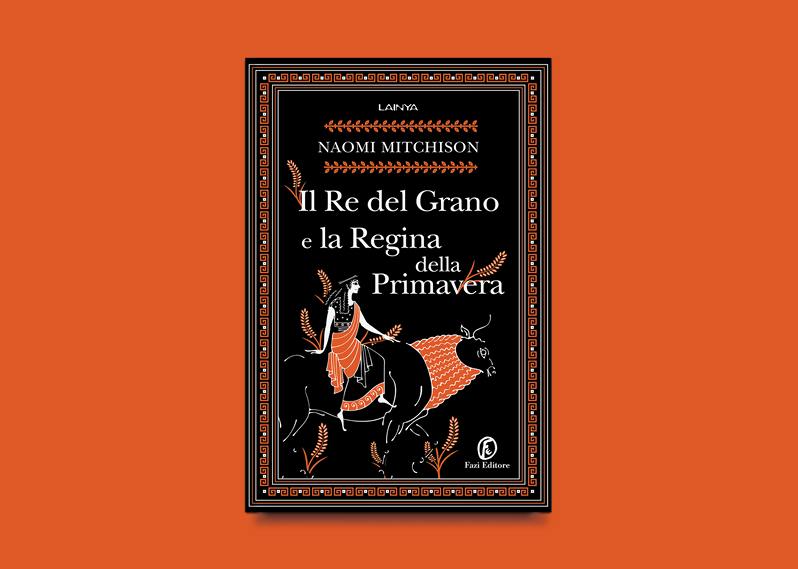
In occasione dell’uscita de Il Re del Grano e la Regina della Primavera, la traduttrice Sabina Terziani racconta il romanzo di Naomi Mitchison.
Negli anni Sessanta Naomi Mitchison ebbe l’onore di essere per così dire adottata dai bakgatla del Botswana in qualità di madre saggia della tribù. Trenta anni prima, a trentaquattro anni, aveva scritto Il Re del Grano e la Regina della Primavera, considerato da molti il suo romanzo più bello, e mi piace pensare che il ruolo di madre saggia l’avesse prefigurato e se lo fosse per così dire guadagnato creando due personaggi come Erif Der e Tarrik. Etica collettiva e individualismo sono sempre in dialogo e in conflitto in Mitchison, e se in Botswana la nostra autrice diventa il punto di riferimento di una collettività tanto culturalmente distante dall’occidente quanto nel romanzo Marob è distante dalla Grecia del 200 a.C., Mitchison e la sua individualità — europea e coloniale nonostante tutto — generano cambiamenti, migliorano la vita delle persone. Per Erif e Tarrik, invece, l’altrove che cambia la vita è rappresentato dalla nascita dolorosa di un’individualità che li porta a vivere i riti della comunità con un senso di distanza e di dubbio ispirati dalle parole del filosofo Sfero.
Da giovane, Naomi si dedicò insieme al fratello alla ricerca in campo genetico. Il metodo scientifico si unì in seguito all’interesse per i simboli, i miti e la storia che strutturano le decine di romanzi scritti nell’arco della sua lunga vita. In Il Re del Grano, la filosofia di Sfero è per i personaggi il motore di un’evoluzione interiore che si manifesta nella società e diventa storia in un rapporto di ontogenesi e filogenesi. Ma Il Re del Grano non è certo un saggio sulla nascita del pensiero scientifico nelle società arcaiche; è un romanzo che ibrida un mondo immaginario dove esiste la magia — Marob — e due società realmente esistite, quella di Sparta e quella tolemaica d’Egitto, con una ricchezza immaginativa e un’energia vitale tipiche degli organismi ibridi e che non hanno niente a che vedere con la ricostruzione storica e l’archeologia.
Vivacità e immediatezza si sarebbero spente se Mitchison avesse scelto di raccontare la vita a Marob, Sparta e Alessandria usando termini dotti, ed è con questa scelta autoriale che ho dovuto fare i conti. All’inizio la vaghezza delle descrizioni di vestiti e oggetti quotidiani mi ha irritato. Perché Mitchison non parla di fibule, chitoni e lucerne, ma di spille, vestiti, gonne e lampade? Perché i figli di Cleomene vanno a scuola, quando tutti sanno che a Sparta si studiava all’agoghè? Perché quando Erif e suo fratello vanno a Delfi non visitano la lesche degli cnidi ma una generica “sala delle riunioni” (clubhouse)? Perché Zeus viene menzionato in pochissimi casi, e i protagonisti parlano sempre di un generico “dio”? Nel caso dell’agoghè non me la sono sentita di seguire Mitchison nella sua vaghezza programmatica perché si trattava di un’istituzione specifica e irripetibile, ma negli altri casi ho rispettato quella che mi è parsa una volontà precisa di vedere il mondo con gli occhi dei protagonisti e non con quelli dello studioso. Per una ragazza come Fililla, il chitone era qualcosa di talmente normale che quando ce l’aveva addosso per lei era un vestito, e qualsiasi oggetto che le permettesse di illuminare una stanza era una lampada. La gente scriveva e leggeva libri, non serve dire che erano rotoli. Il lettore può immaginare questi oggetti d’uso quotidiano come preferisce, e il modo proposto da Mitchison è quello che lo fa sentire dentro la realtà narrata, al fianco dei personaggi.
Sabina Terziani
