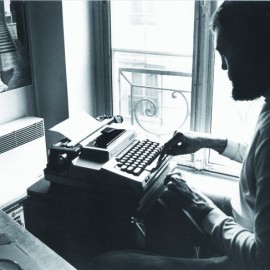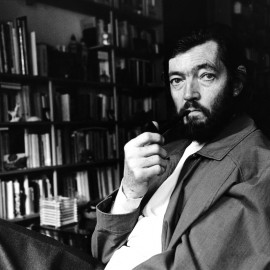Dichiarazione giurata (estratto di «A passeggio con John Keats» di Julio Cortázar)
• Il blog di Fazi Editore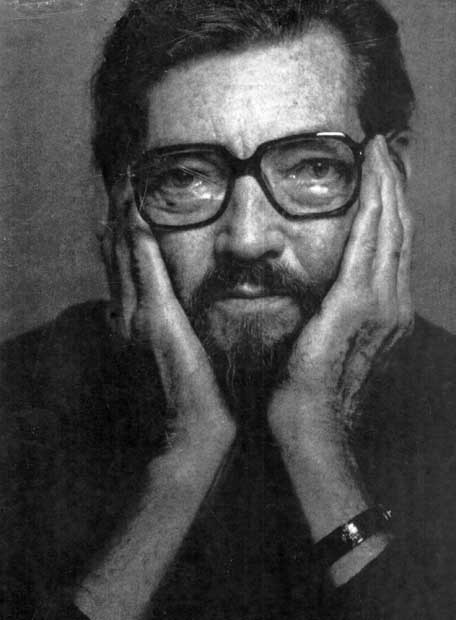
In occasione del centenario della nascita di Julio Cortázar pubblichiamo, in anteprima per il nostro blog, un estratto da A passeggio con John Keats, fino ad oggi inedito in Italia: un’opera fondamentale su Keats ma anche un libro-rivelazione su Cortázar. Il volume sarà disponibile in libreria dal 28 agosto.
Un libro romantico, che segue fedelmente il suo impulso e il suo tema come fa il girasole. Ossia un libro di sostanze confuse, mai sistemate per accontentare un signor professore, mai catalogate in minuziosi colombari alfabetici. E all’improvviso, sì, all’improvviso ordinatissimo, quando si tratta di questo: anche il buon romantico aveva un metodo quando si faceva il nodo alla cravatta secondo la moda dell’epoca.
Da anni ho rinunciato a pensare in modo coerente, la mia penna Waterman pensa per me e lo fa meglio. Sembra che accumuli energie nella tasca,
la conservo nel panciotto, sul cuore, ed è possibile che, a forza di ascoltarlo andare e venire, la grande staffa rotonda, livida,
il suo tipico cuore di inchiostro, il suo cordoncino elastico, si vada colmando di desideri e di fantasie. Allora mi salta in mano e il resto è facile, è esattamente il momento.
A ogni modo, i miei innumerevoli pregiudizi non la lasciano scorrazzare libera per la pagina. Se davvero si potesse scrivere in modo automatico, è probabile che gli occhi, distratti dal contemplare un riflesso che scivola sui vetri, rinuncerebbero a vigilare sull’ostinata pattinatrice, niente di più violento del suo desiderio di esaurire la pista, uscire con un’ultima piroetta lasciandola ricoperta di segni e arabeschi. Ma gli occhi, macchina della convenienza, risentono profondamente di questa ginnastica personale e libera, loro che vedono solamente la danza, che si limitano unicamente a vedere.
A ogni modo, poiché mi amministro abbastanza bene dalla centrale dell’ozio, distribuisco le mie funzioni con generosità di padroncino di tenuta e, dopo aver regalato agli occhi un intero album di Matisse, accetto l’impulso ciclista che nasce nella mano, la lascio mettersi a cavalcioni sullo stecchino-che-parla, e se ne vanno lì mentre li guardo e sorseggio il mio succulento mate in cui una selva minuta profuma per me.
Leggermente narcisista, non è vero? Come le lingue che si radunano in tutto questo; come l’opprimente montagna di citazioni: come il linguaggio che mi è venuta voglia di usare. So che questo cammino insieme al mio poeta disgusterà in modo repentino e gli uni e gli altri, perché, vedete, quel che accade è che qui si parla di un passato con linguaggio di presente,
e questo fa inorridire coloro che prima di aprire un Dante indossano la maschera e compongono il corrispondente volto guelfo, facendo tabula rasa nella loro memoria dei numeri telefonici, della bomba h e della poesia di Pierre Jean Jouve
però, ancor di più, qui si parla al presente, presentissimo, di un passato trapassato
e questa cosa infastidirà coloro che fanno nascere la poesia col ragazzo delle Ardenne, relegando il resto a quel che normalmente etichettiamo col termine di “crinolina”.
Pertanto farò una pessima figura sia con i guardiani di tombe sia con i sostenitori del bebop. Ma anche questo vuol dire mantenersi fedeli al mio poeta, perché lui aveva l’attitudine spaventosa di fare brutta figura con tutti nella repubblica letteraria. Solamente i suoi amici compresero questo aspetto, e ciò aiuta a non lasciarsi tentare dalla facile e vantaggiosa affiliazione unilaterale.
Quanto all’incorrere in citazioni, la cosa è meno giustificabile, come tutto ciò che nasce dal desiderio. Che si tratti di minestra, acqua saponata o citazioni, l’atto di cospargere è da maleducati. Quando nel 1950 tornavo dall’Europa a bordo del m.s. Anna C., rumorosamente accompagnato da svariate centinaia di immigranti italiani e un po’ meno di portoghesi,
e di mattino, quando all’incirca alle sei ti accendono le luci del camerone velis nolis e così come dormire con le grida e gli interminabili scambi di opinioni sulla questione se saremmo giunti a Rio alle nove o il giorno dopo all’alba
ergo occorreva alzarsi o meglio scendere giacché io avevo una cuccetta alta
ottenuta dopo abili manovre di fronte al capo alloggi, col pretesto di crisi asmatiche,
ergo alle sei e cinque in una dozzina di ragazzi stavamo davanti alle file sing-sing, i lavandini, ciascuno con l’asciugamano come un cappuccio d’auriga, una mano premendo l’ingegnosa trovata del rubinetto ad usum terza classe (un getto sottilissimo se premi e grazie mille) e l’altra mano che capta le gocce e le distribuisce alla faccia alle orecchie ai capelli
evitando al contempo di bagnare chi ti sta accanto (dall’uno e dall’altro lato) perché va bene gettarsi addosso la propria acqua ma anche una sola goccia-d’acqua-di-chi-ti-sta-a-fianco è una cosa seria, è un abuso. Ebbene, lo stesso vale per le citazioni. Cospargere di citazioni la scrittura è pedanteria
il tizio vuole vantarsi (in fondo, con la biblioteca a portata di mano…)
è disinvoltura
le cose buone le dicono gli altri
è un centone è tradizionalismo
Montaigne, i molti Lorenzo Valla, e dietro acquattata la convinzione che gli antichi avevano sempre ragione.
È un peccato (per gli altri; personalmente non mi preoccupa) questa obbligatoria differenza che l’impiego o la messa al bando delle citazioni impone ai libri, catalogandoli: c’è il saggio, in cui proliferano per il piacere di tutti, e c’è il libro di “creazione”, dove
in modo assai spiritoso
un’unica citazione gode dell’onore del pappagallo: per lei sola è il trespolo, che di colpo si chiama epigrafe. Nella casa grande non c’è posto per lei, salvo raramente, e sempre facendosi perdonare (ci sono quei libri che sono soltanto una megacitazione di un altro libro, ma non siamo vigliacchi, su!).
La citazione è narcisista, come l’intercalare di frasi in una lingua straniera. Nessuno ignora che citiamo da altri tutto quello da cui possiamo trarre profitto. Ciò per quanto riguarda l’aspetto intellettuale. Vi sono poi, però, le citazioni che rimandano alla memoria per analogie inintellegibili, che lasciano il fiore e se ne ritornano al loro nulla; i versi sciolti, che sbocciano come suoni armonici da uno stato d’animo, dall’aprire una finestra, dal sentire il desiderio di una carezza o di un colore. Poiché da anni ho rinunciato a pensare, è naturale che altri pensino al posto mio, nella mia memoria, e che mi mettano in mano pietruzze colorate, come quei ragazzi che vanno mostrando agli altri le loro figurine con parsimonia: dapprima la tartaruga, i levrieri, il pesce spada, e poi quelle speciali e composte da gruppi, la famiglia allo zoo, le scimmie sapienti, il concerto delle fate.
Se cito perché ne ho voglia, è che la voglia genera le citazioni. Quando lo stecchino-che-parla si mette a farlo al posto di un altro, rispetto lo spirito che mi abita e mi usa per ripetersi, per tornare dalla sua mastaba. Voracità del poeta che trabocca dai suoi libri, invade quelli altrui. «La figlia di Minosse e Pasifae» in quante isole dimora?
Allora è giusto rispettare anche la lingua. Dillo a parole tue quando vuoi, Villon; e tu, Andrew Marvell, e tu, D’Annunzio. Peccato non conoscere il russo, non conoscere l’armeno, conoscere così male il tedesco e lo spagnolo.
Dico queste cose per anticipare che quanto segue risponde alla maggior libertà d’espressione possibile, giacché ogni movimento espressivo in ambiti poetici dev’essere, letteralmente, un catch-as-catch-can. Non mi fido della libertà del fine settimana, di questo ritorno alle radici umane che sentiamo il sabato sera e la domenica. Credo in una libertà composta, come può esserlo una fedele obbedienza a ciò che si ama.
«Inutile obbedienza solitaria»,
dice Ricardo E. Molinari, e andare a fissarsi con chi nientemeno apro la colombaia delle citazioni.
Inutile, come ogni obbedienza, come Madame Butterfly; solitaria – quasi di troppo, quasi, anche, inutile.
Ma libertà, e cioè adesione a quanto infine e ogni giorno
(ogni giorno è sempre l’ultimo, infine)
sappiamo buono, bello, vero.
E con ciò, libriccino, apriti ai giochi.