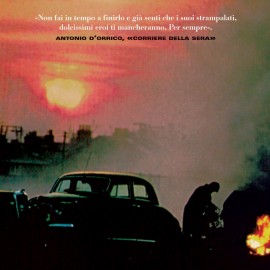Salve ragazzi, sono tornato
• Il blog di Fazi Editore - La voce degli autori
Pubblichiamo l’intervista di Stefano Montefiori a Robert McLiam Wilson, autore del capolavoro che ha conquistato una generazione, apparsa su La lettura del Corriere della Sera il 12 aprile 2015.
I fan di Robert McLiam Wilson sono pronti a mettere tra i migliori incipit di sempre quello di Eureka Street: «Tutte le storie sono storie d’amore». Punto e accapo. E dalla seconda riga fino a pagina 414 della prima edizione non si riesce a mettere giù il romanzo del trentenne working class Jake, cattolico, dell’amico protestante Chuckie e degli altri personaggi che rendono la Belfast degli anni Novanta un posto attraente, un luogo letterario che mette addosso la voglia di corteggiare ragazze, sopportare amici sgangherati e darsi da fare, insomma amare la vita (nonostante la violenza, che c’è ed è descritta in tutta la sua idiozia).
Eureka Street è stato un libro fondamentale per molti. Per quel particolare tipo umano abituato ad alternare in fretta euforia e tristezza, poi, Eureka Street è un compagno ideale dei momenti migliori. Le case editrici da quasi vent’anni lo ristampano (Fazi, in questi giorni) perché Eureka Street non ha mai smesso di conquistare lettori. E dal 1996, quando il romanzo apparve in Gran Bretagna, il suo autore non ha quasi pubblicato altro. Di recente articoli per «Libération», la rivista «Lui» e «Charlie Hebdo» (dopo l’attentato). Ma niente libri.
Irlandese cattolico nato a Belfast 49 anni fa, studi a Cambridge e molti mestieri (muratore, guardia di sicurezza, venditore di kilt), McLiam Wilson ha scritto un primo ottimo romanzo nel 1989 (Ripley Bogle), un secondo nel 1992 (Il dolore di Manfred, che lui non sopporta), un saggio sui senzatetto nello stesso anno (The Dispossessed), ha conosciuto l’enorme affetto del pubblico e vinto premi con Eureka Street nel 1996 e poi ha abbandonato — o quasi — la scena letteraria. Da circa sette anni Robert McLiam Wilson vive a Parigi con la moglie irlandese Mary Ann, insegnante al British Council, conosciuta in una libreria («accompagnavo un mio amico che faceva la corte a un’amica di Mary Ann, loro non si sono mai messi insieme, noi sì»). Partecipa al festival «Printemps du livre» di Grenoble, e in questa occasione lo contattiamo.
La risposta automatica dell’email è promettente: «Sì. Buongiorno buongiorno. Sono attualmente sequestrato in un luogo tenuto segreto nella speranza di terminare un romanzo dopo un intervallo di, hum, qualche anno. Così, può darsi che io non sia in grado di rispondervi in fretta a meno che: 1) Lavoriamo già insieme. 2) Siamo legati da un insieme predominante di indicatori genetici. 3) Mi offrite una somma di denaro indecente in cambio di quasi zero lavoro. 4) Mi fate una proposta grottescamente imbarazzante e vergognosamente sessuale. 5) Voi o il vostro messaggio attivano il mio senso di colpa in un modo infinitamente prevedibile. Naturalmente, suppongo che mi auguriate buona fortuna. Scusate, Robert».
Non è chiaro che cosa lo abbia convinto a rispondere (di sicuro non l’ipotesi 3, e neanche la 4), fatto sta che pochi giorni dopo McLiam Wilson aspetta l’inviato de «la Lettura» al binario della stazione di Grenoble. Gentile, pieno di humour e sigarette. Banale dirlo, è così che uno si immagina Jake, il protagonista di Eureka Street. Solo che parla un francese perfetto, «con l’accento di una mucca irlandese però », tiene a far notare. Camminiamo fino al caffè, e la prima domanda si fa da sola.
Che cosa è successo dal 1996 a oggi?
«Eureka Street è andato benissimo, e questo mi ha un po’ riempito di complessi. Sono un tipo strano, quando mi invitavano a parlare del libro la gente mi diceva cose fantastiche e io invece di essere contento mi imbarazzavo e rispondevo no no dovreste leggere Tolstoj! Restare modesti, l’autoderisione: è una cosa molto britannica, è così che funzioniamo. Se non hai questo atteggiamento sei giudicato bizzarro, ma diciamo che io ho un po’ esagerato, sono andato troppo lontano, fino a rifiutare il successo».
Troppa pressione?
«Dopo quel romanzo sono stato coperto di elogi, mi sono detto ora devi essere all’altezza, e questo mi ha un po’ bloccato. Non sono un tipo molto professionale quanto alla mia figura di scrittore, e poi sono un proletario, un provinciale. Non prendo sul serio me stesso, ma prendo terribilmente sul serio la letteratura. La pressione si è aggiunta al mio modo di lavorare, che consisteva già nel riscrivere di continuo le stesse pagine, cercando di migliorarle il più possibile».
Anche «Eureka Street» ha subito questo trattamento? Sembrerebbe un libro scritto di getto.
«Tutto il lavoro consiste nel nascondere il lavoro. L’impressione di facilità è faticosissima, i buoni libri non cascano dal camion. Di Eureka Street ho scritto 4 o 5 versioni e ci sono frasi che mi fanno male ancora adesso, non mi convincono».
Ha sofferto della sindrome della pagina bianca, dopo?
«No, ho scelto di non pubblicare niente ma ho scritto molto. Il nuovo romanzo The Extremists uscirà all’inizio dell’anno prossimo, e ne ho già pronto un altro, che potrei pubblicare nel 2017».
Vent’anni di silenzio e poi due libri in due anni?
(ride) «Come gli autobus, aspetti aspetti e alla fine ne arriva uno dietro l’altro».
Come mai ha scritto ma non pubblicato?
«Dopo Eureka Street, in molti Paesi (tra i quali l’Italia) è stato tradotto il romanzo precedente, Il dolore di Manfred, che ha per protagonista un anziano signore. Detesto Il dolore di Manfred, faccio fatica a restare gentile quando qualcuno mi dice che lo ha molto amato. Anche il romanzo che ho già pronto parla di un anziano, non mi piaceva farne due di seguito apparentemente sullo stesso argomento».
E il prossimo, «The Extremists»? Di che cosa parla?
«In questi anni l’ho scritto e riscritto un sacco di volte, sono arrivato a 900 pagine, più o meno otto mesi fa è scattato qualcosa e ho pensato che ci siamo, il romanzo ha preso forma, mi pare niente male e merita di essere finito e stampato presto. È la storia di un tipo, di cui non sappiamo granché, che a un certo punto si mette a camminare, dall’Inghilterra alla Francia, fino al Mediterraneo. A poco a poco sempre più persone si mettono a seguirlo, inventandosi ragioni, motivazioni e destini. Il personaggio principale, quello che racconta la storia, è un giornalista che non sopporta quella specie di falso profeta e fa di tutto per scoprire una verità sporca e rivelarla. A un certo punto tra il seguito sempre più numeroso si formano dei gruppi, gli ebrei da una parte, i musulmani dall’altra, quelli di sinistra, di destra… Parlo delle tensioni tra le comunità».
C’entra la sua esperienza di abitante a Parigi?
«Ho notato una grande differenza con Londra. In Inghilterra le tensioni sono meno violente, non perché gli inglesi siano più buoni ma perché certe cose non si possono dire, sono imbarazzanti, e l’imbarazzo per un inglese è la fine del mondo. A Parigi una volta stavo andando con degli amici a una partita di calcio, uno di noi era in ritardo e io ho detto dobbiamo andare; mi hanno risposto no dai, aspettiamo il francese. Stavo con due arabi e un nero, nati a Parigi, e per indicare il nostro amico bianco lo hanno chiamato il francese. E loro allora che cosa sono? Una distinzione incomprensibile a Londra».
Perché si è trasferito in Francia?
«È piuttosto semplice. In un match tra Belfast e Parigi, Parigi vince. Era tanto tempo che io e Mary Ann pensavamo di trasferirci lì. E poi ne avevo abbastanza dei miei vicini di casa a Belfast, che mi sussurravano che era tutta colpa degli ebrei».
Subito dopo l’attentato a «Charlie Hebdo», lei ha scritto un lungo articolo per «The Big Issue» in cui definisce i terroristi semplicemente come arroganti e stupidi. Pensa che rischiamo di nobilitarli cercando spiegazioni troppo profonde?
«Chi viene dai quartieri difficili conosce molto bene quella miscela, la peggiore del mondo, di stupidità e arroganza. I gemelli perfetti, l’accoppiata mortale. Non c’è altro. A Belfast anni fa ho conosciuto degli italiani, degli intellettuali, che pensavano che l’Ira fosse socialista. Ah sì? Quelli dell’Ira erano capaci di ammazzare un ragazzo per aver rubato una macchina, ma erano di sinistra? Gli studiosi proiettano la loro complessità su azioni semplicemente idiote. Io ho il vantaggio di essere un proletario cresciuto a Belfast, e riconosco a prima vista la stupidità. Prendiamo Bobby Sands, che fuori dell’Irlanda è molto rispettato ed è morto, cosa che mi dispiace. Ma le sue poesie erano orrende, una truffa. Dalla Colombia al Perù a Belfast a Parigi, i terroristi sono tutti uguali. Mancano di empatia, e quindi di intelligenza».
Accanto a questi temi, lei è un autore capace di leggerezza, per esempio quando scrive per «Lui», la rivista francese che riprende la vecchia formula di «Playboy», donne nude e giornalismo di alto livello.
«Comincio ad appassionarmi al giornalismo, mi dà disciplina. Sono diventato bravo, rispetto i termini di consegna. Scrivo su “Charlie Hebdo” per solidarietà dopo l’attentato, e su “Lui” articoli pro-famiglia accanto alle foto delle ragazze, mi fa ridere. Non sono francese e quindi posso avere senso dell’umorismo. I francesi sono educatissimi, molto intelligenti e colti, ma non sono divertenti. Non è colpa loro, sono fatti così, è il loro Dna».
Quanto conta per lei l’umorismo?
«Molto. Mi è capitato anche di stare molto male. Quando abitavo a Berlino, per esempio, nel 2000, ho toccato il fondo, ho pensato al suicidio e ci ho provato. Lo humour è importante, tiene lontani dalla sofferenza. È anche questione di educazione, non si può sbattere tutto il dolore addosso alla gente. Il fatto è, se non lo si fosse capito, che sono un gran malinconico».
Si sente pronto, adesso?
«Ma sì, non sono troppo in difficoltà per la storia dei vent’anni di attesa. Che cosa sono in fin dei conti un tentativo di suicidio e un’abitudine, durata poco, alla droga tra amici? E poi è stato divertente aspettare che tutti ripetessero che il romanzo è morto per dire Shalom, figli di p…, sono tornato».