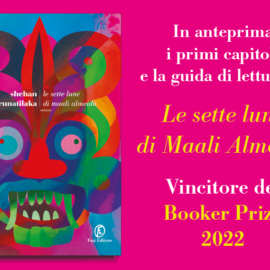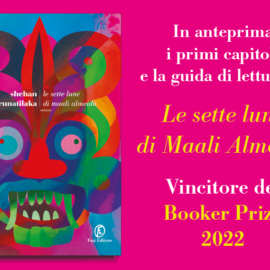
Tradurre «Le sette lune di Maali Almeida» di Shehan Karunatilaka
• Il blog di Fazi Editore - Parola ai traduttori
Silvia Castoldi racconta la sua esperienza con la traduzione di Le sette lune di Maali Almeida di Shehan Karuntilaka, il romanzo vincitore del Booker Prize 2022.
Una storia di fantasmi che riesce a essere nello stesso tempo una satira, un romanzo politico, un giallo, un thriller metafisico, un noir dell’aldilà, e dissolve i confini non solo tra generi letterari diversi, ma tra vita e morte, corpo e spirito, oriente e occidente. Un romanzo filosofico che per narrarci la storia dello Sri Lanka ci conduce nel «cuore oscuro del mondo». Una visione della vita oltremondana in cui l’autore ha il coraggio di dire la sua sull’amore, la morte, la vita, l’immortalità dell’anima, la ricerca di un senso, la capacità di perdonare, in primo luogo se stessi.
Nello Sri Lanka del 1990, il protagonista, Maali Almeida, «fotografo (di guerra), giocatore d’azzardo, puttana», si risveglia morto in un aldilà che sembra una via di mezzo tra un ufficio passaporti e l’agenzia delle entrate, in preda a un caos che riecheggia quello del mondo dei vivi e della carneficina della guerra civile. Maali ha sette giorni di tempo (sette lune, perché una luna in questa versione dell’aldilà equivale a un giorno) per scoprire come è morto, ovvero chi lo ha ucciso, e per riportare alla luce le sue foto segrete, che non solo rappresentano il vertice della sua carriera, ma svelano anche i retroscena dei conflitti che dilaniano il suo paese. Tutto questo mentre impara con fatica a padroneggiare le proprie capacità di influenzare le azioni dei vivi e a difendersi da demoni e pericoli di varia natura, solo per poi scoprire che il loro orrore non è altro che un pallido riflesso dell’orrore di cui grondano le atrocità commesse nel nostro mondo.
Appena ho iniziato a leggere il romanzo ho avuto l’impressione di piombare dentro un turbine vertiginoso di immagini, suoni, creature misteriose: ghoul, preta, diavoli, yaka, demoni. I mala preta rubano il sapore al cibo, i Naga yaka hanno bei volti su teste di cobra, i Kota yaka cavalcano gatti, indossano perle e impugnano asce da battaglia, il Bahirava yaka è nato dalle urla di Sita, e si leva solo quando gli dèi combattono o quando il sole sanguina. E poi i fantasmi creati dai vivi, i testimoni e le vittime dell’umana ferocia: lo Zio Cannibale è morto in un attentato, il Bambino Belva è stato costretto a uccidere gli zii per le Tigri tamil, il Demone Marino è finito ridotto a brandelli all’università, lo Spettro Ateo era un consigliere provinciale accoltellato dallo JVP, la Donna dal Sari Nero ha perso cinque figli in guerra. E infine c’è il Mahakali, il più spaventoso di tutti. Un coro da tragedia: siamo noi a popolare l’inferno.
Mi sono ritrovata immersa nella fantasmagoria di un mondo di una pienezza e di una sovrabbondanza travolgenti: un mondo mitologico che irrompe nel quotidiano, lo infesta, lo popola dei sussurri di chi non vuole dimenticare o non vuole essere dimenticato. E nelle parole di quei sussurri, che affollano il romanzo, parole come putha, o aiya, o malli, o thambi, le lingue, il singalese e il tamil, affiorano in continuazione, si scontrano tra loro, resistono alla minaccia onnipresente del predominio dell’inglese, ma anche e forse soprattutto ai tentativi reciproci di cancellazione e di annientamento, non solo dell’idioma avversario ma anche dei suoi parlanti: «La tua Amma è seduta in un angolo e guarda le quattro pagine scritte quasi tutte in singalese, che non è la sua lingua madre, anche se ha vissuto per tutta la vita in una nazione che sostiene di parlare solo quella». Per espressa volontà dell’autore non comparirà un glossario in fondo al libro: il lettore si ritrova immerso in questo gorgo linguistico e deve imparare a nuotare con le sue sole forze.
Nelle sue interviste, Karunatilaka cita come modelli di riferimento Gabriel García Márquez e Salman Rushdie, e in effetti il realismo magico influenza profondamente il romanzo, forse anche perché fornisce un linguaggio con cui si può parlare di un mondo divenuto intollerabile: facendolo esplodere, frantumando i confini tra realtà oggettiva e realtà onirica. E infatti in Le sette lune di Maali Almeida sia la linea di demarcazione tra il regno dei vivi e quello dei morti, sia le differenze tra gli uni e gli altri si fanno molto sottili, al punto che in qualche occasione vediamo personaggi passare dalla vita alla morte quasi senza soluzione di continuità, rimanendo uguali a se stessi perché incapaci di cambiare.
Il romanzo è scritto in seconda persona, narrato da un protagonista che presenta dentro di sé una scissione, uno sdoppiamento che lo accompagna da sempre («Hai sempre creduto che la voce nella tua testa appartenesse a qualcun altro. Quella che ti raccontava la storia della tua vita come se fosse già successa. Il narratore onnisciente che aggiungeva un commento fuori campo alla tua giornata»), ma si acuisce ulteriormente al momento della morte («Hai sentito il tuo sé scindersi nel tu e nell’io, e poi nei molteplici tu e negli infiniti io che sei stato prima e che sarai di nuovo»): un io che agisce e un tu che osserva, interviene e giudica: una frattura che, oltre a trarre alimento dall’omosessualità di Maali in un contesto sociale in cui essere gay è oggetto di un forte stigma, o dai rimorsi che lo perseguitano per tutte le slealtà che ha commesso nei riguardi di amici e amanti, sembra un rispecchiamento della divisione che lacera il suo paese.
E forse tutto il romanzo è il racconto di questa frattura, dei suoi molteplici livelli di significato, individuale e collettivo, e di come sia (im)possibile superarla: un problema non risolvibile nei termini in cui è formulato, perché lasciarsi guidare unicamente dal proprio legittimo rancore significa coltivare la scissione, invece di sanarla, e può solo condurre dentro un vicolo cieco.
Ci vuole qualcosa di più, una svolta, uno scatto del pensiero che infrange la barriera tra io, tu, noi, tra passato e futuro, e si lascia tutto alle spalle, rendendosi conto all’ultimo istante che l’oblio è il giusto prezzo da pagare per avere la possibilità di ricominciare da capo.
Silvia Castoldi
Articoli sullo stesso libro