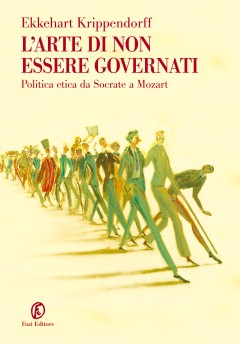Jonathan D. Spence
Girotondo cinese
Traduzione di Cristina Foldes
A cura di Carlo Laurenti
Alla base dei saggi raccolti in questo volume sta un’idea avventurosa della conoscenza, che non è mai una somma astratta di nozioni, ma il prodotto di un desiderio irresistibile, quando non di una vera e propria follia. Intrepidi viaggiatori, mercanti, missionari, eruditi vissuti nel chiuso delle biblioteche hanno partecipato a questa avventura, da sempre al centro dell’interesse di Spence, magistrale interprete del reciproco rapporto di fascinazione (fatto di entusiasmo, di curiosità, di spaesamento) che lega, dal Medio Evo ai giorni nostri, l’Occidente e la Cina.
– 08/01/1997
Fascino dell’incontro tra culture diverse
Un libro strano dal quale si può imparare molto, ma che può anche essere letto come un racconto di illusioni ed erudizioni, alla maniera di Borges o, meglio ancora, del Canetti di ‘Autodafé’. È del resto lo stesso Carlo Laurenti, curatore dell’edizione italiana di ‘Girotondo cinese’ (tradotto da Cristina Foldes), a rivelare che in queste pagine si nasconde, nella persona del poliglotta Arthur Waley, il modello di Kien, il sinologo misantropo immortalato da Canetti nel suo capolavoro giovanile. Una sorpresa, una delle tante che il libro di Jonathan D. Spence riserva al lettore curioso e rigorosamente non specialista che voglia salire su questa giostra di temi e figure orientali. Apprezzato anche in Italia grazie alla traduzione di alcune delle sue opere più significative (ricordiamo ‘L’imperatore della Cina’, pubblicato nel 1986 da Adelphi, e ‘Il palazzo della memoria di Matteo Ricci’, edito dal Saggiatore nell’87), Spence riunisce infatti, come nella miglior tradizione anglosassone, competenza di studioso e abilità di scrittore. Per rendersene conto basta scorrere il saggio dedicato ad Arcadio Huang, il cinese che nella Parigi del primo Settecento s’avventura nella compilazione di un dizionario di ideogrammi e, nel frattempo, fornisce a Montesquieu più di uno spunto per l’elaborazione delle ‘Lettere persiane’. A ben vedere, il vero argomento di ‘Girotondo cinese’ è appunto questo tentativo – spesso mancato, ma comunque affascinante – di far incontrare tra loro culture diverse, se non addirittura contrapposte. Una scommessa che può essere giocata su tavoli diversi: quello della peregrinazione picaresca, sulle orme del portoghese Mendes Pinto, oppure quello della conoscenza e dello slancio evangelico, di cui rimane modello insuperato Matteo Ricci, protagonista di uno dei più intensi capitoli del libro. Da vero narratore, Spence si identifica in ciascuno degli eroi del suo romanzo dal vero (c’è anche l’André Malraux della ‘Tentazione dell’Occidente’, prototipo del rivoluzionario ‘blasé), riuscendo a farci percepire la lontananza di un Oriente che, di anno in anno, sembra farsi meno estremo restando tuttavia irraggiungibile.
– 03/01/1997
Uno sguardo sulla Cina
(…) Jonathan Spence é inglese, docente alla Yale University, e di lui l’editore Fazi ha da poco pubblicato “Girotondo cinese”, a cura del sinologo italiano Carlo Laurenti e di Cristina Foldes. E’ incredibile quanto bene conosca la Cina, questo Spence! Il volume é insieme storia a sé e rassegna commentata delle immagini, in buona parte straordinarie. Non ci sono le ultracelebri, e ormai fin troppo note, scattate da Cartier-Bresson per la Magnum negli anni di passaggio al regime maoista, le provenienze archiviatiche e collezionistiche sono disparate (non appartengono agli Archivi Alinari) e a me non pare ne siano state pubblicate in Italia prima di ora. C’é dunque il piacere della scoperta. Il volume, inoltre, contiene qualche immagine in più della mostra, dove mancano quelle della rivoluzione culturale e del periodo denghista. La storia di Spence si ferma all’inizio del 1996: un passo più in là e ci avrebbe regalato anche i funerali di Deng, le sue immagini estreme di mummietta semicancellata dalla vecchiaia sclerotica, un altro ancora e avrebbe potuto includere quel che nell’Eterno Presente é già stato: la fine di Hong-Kong e della sua libertà sotto la Corona britannica, che secondo il tempo lineare avverrà tra poco. (…)
– 03/01/1997
Girotondo cinese
Di saggi come questo se ne leggono pochi. E quando capita di trovarne qualcuno, si resta stupefatti per l’intreccio di erudizione e di passione, di grandi temi e di piccoli dettagli, di competenze specialistiche e di sapienza narrativa. Jonathan Spence ama di vero amore l’oggetto dei suoi studi, lo smisurato pianeta Cina, e fa in modo che anche il lettore ne rimanga affascinato. A cominciare dal titolo della raccolta (rubato a Wallace Stevens) seduce senza intimorire, coltivando l’understatement di chi sa davvero, e quindi non teme né la chiarezza né l’ironia. “Girotondo cinese” riunisce 12 saggi scritti all’origine per giornali e riviste, poi organizzati in volume seguendo tre filoni principali. La prima sezione ripercorre la storia, cominciata 4 secoli fa, dei rapporti tra l’Occidente e la Cina: a quel tempo, insieme al Nuovo Mondo, la palestra in cui gli europei sperimentavano la loro diversità. E la stessa sorte toccò anche ai pochi cinesi che fortunosamente riuscirono ad arrivare, per esempio, a Parigi. Come Arcadio Huang, che agli inizi del ‘700 ebbe l’incarico di interprete dal cinese nella biblioteca del re, e che diventerà uno degli ispiratori delle “Lettere persiane” di Montesquieu. L’espediente letterario di uno sguardo forestiero e finto ingenuo consentiva di criticare la Francia senza incorrere nelle ire dei potenti, e il modello, non inedito, già allora, avrà vita lunghissima: Andrè Malraux lo userà per “Le tentazioni dell’occidente” (a cui é dedicato un saggio del “Girotondo”) e poi verrà sfruttato da un genere popolare come la fantascienza. Le tribolazioni di un cinese in Europa erano anche il tema di un precedente libro di Spence: “L’enigma di Hu” (Adelphi 1992). Hu fu però più sfortunato, e passò gran parte dei suoi tre anni in Francia nel manicomio di Charenton. Tornato in Cina, e interrogato su quel che aveva visto, rispose seccamente “E’ come qui”. Se non fosse uno dei più grandi sinologi contemporanei, Spence potrebbe tranquillamente fare lo scrittore, tanto é bravo a scovare nelle pieghe della storia episodi e personaggi bizzarri che paiono usciti da un racconto di Jorge Luis Borges. C’é una sottile vena di follia nell’esistenza e negli scritti del gesuita Matteo Ricci, partito per la cina alla fine del ‘500 come missionario, dopo che l’India e il Giappone, da questo punto di vista, lo savevano deluso. Ad attrarlo, suggerisce Spence, c’é anche il fatto che “la lingua cina” non ha una grammatica complicata come “la greca o la tedesca” (evidentemente gli ideogrammi gli incutevano meno paura di un aoristo). La stessa vena di follia riappare nei ritratti degli studiosi raccolti sotto il titolo “Maestri”. Di tutti il più eccentrico è Arthur Waley, presenza un po’ defilata del gruppo di Bloomsbury: era amico di Leonard Woolf e di Edward Morgan Forster, con cui aveva in comune l’interesse per l’Asia. Traduttore dal cinese e dal giapponese, Waley considerava un disonore la carriera accademica, e si rintanò senza rimpianti nella biblioteca del British Museum. Da dove non si mosse mai, e anzi faceva un vanto di non aver messo piede né in Cina né in Giappone. Ma le sue traduzioni fecero scoprire agli inglesi un universo poetico fino ad allora completamente ignoto. In amichevole gara con Spence, il curatore del’edizione italiana Carlo Laurenti aggiunge un tassello al mosaico, avanzando l’ipotesi che ad Arthur Waley e alla sua bibliomania si sia ispirato Elias Canetti per scrivere “Auto da fé”. La sezione centrale, “L’impulso confuciano”, abbandona la storia delle idee per temi più interni agli studi cinesi. Ma un bravo divulgatore lo si ammira nei momenti difficili. E così Spence, per delineare la figura dell’imperatore K’ang-hsi ( che regnò per 6 anni), chiede aiuto a Shakespeare e organizza la materia in piccole tappe: sette, come le sette età della vita.
Libri dello stesso autore