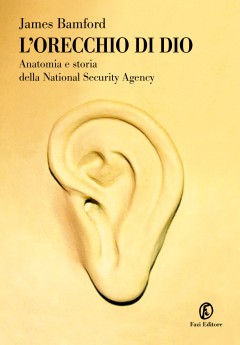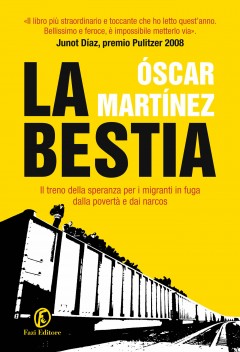Antonella Anedda
Cosa sono gli anni
Saggi e racconti
Cosa sono gli anni è una grande riflessione sul senso moderno del vivere. Saggismo letterario, autobiografia, lettura e analisi dei capolavori poetici e narrativi di questo secolo, sono l’universo morale che riverbera in ogni pagina. La domanda di Antonella Anedda non è tanto “che cosa sia la bellezza”, quanto soprattutto “cosa significhi vivere” e perché il male e il bene si stringano in una lotta ineluttabile. Questo saggio ha il passo del romanzo, il tempo di un lungo racconto in cui si nascondono molteplici riferimenti letterari, da Dostoevskij a Beckett, da Celan a Kavafis o al cinema di Tarkovskij. Come un filosofo antico, anche Antonella Anedda, notevole figura della poesia italiana contemporanea, ripropone un’idea forte di letteratura: l’idea che lo scrivere resti la domanda essenziale sull’uomo.
– 11/07/2014
Vola alta parola. Incontri poetici Anedda e D’Elia
– 09/01/1997
Antonella Anedda. Cosa sono gli anni.
Ho capito questo libro in un giorno di maggio, un lunedì sera tiepido e fragrante, limpido e tranquillo. E’ stata una prova tesa all’ago sensibile che tengo pronto al mio interno, quando lascio le pagine mi sfilino davanti senza più tregua, o aria smorta, o senso di perdita per la realtà. “Cosa vedo ?”, mi sono chiesto, aiutandomi con mille domande, con i ricordi, le ceneri, le speranze chieste alle file di libri presenti in questa stanza. La risposta era lì, nella prima pagina di ‘Cosa sono gli anni’: “Questo è un libro di gratitudini e rapine. D’immense gratitudini e di piccole rapine”. Così il secondo appuntamento con Antonella Anedda si è compiuto in un bel mese primaverile, quando di solito mi sento più pronto a imparare, a cogliere le briciole di forza che si mettono in moto, in attesa del mondo, in attesa che il mondo le faccia partire. Basta una strada soltanto perché la via venga tracciata. Basta poco per un incontro. E in quel poco i bagliori, anche i più fugaci, sanno che in molti alzano il viso. Sembra quasi facile non confondersi più nell’alfabeto, tutte le parole sono esatte, come scolpite nel tempo da una seconda vita di Andrei Tarkovskij. Una innocente nudità che non lascia presupporre assenza di paura, di verità, o di durezza, ma che mette in luce, di fronte alla consistenza del mondo, una casta consistenza vitale e poetica. In ogni pagina scritta alla mano vibrante di Antonella Anedda tutto questo è offerto in un nitore fermo e deciso, dove non può esistere un’ombra, un’indifferenza. E’ nei biglietti conservati nelle tasche che ritroviamo quel che resta di una lettura, di una poesia, di quei versi che si sono perfino tradotti. Non c’è verità più vera di una terra che sa fare a meno del cielo, non per ingratitudine ma per evitare l’abbandono, o per cederlo ai vinti. Cosa sono gli anni, se non le tappe di un viaggio che va di isola in isola, partendo dall’immensa città-madre? Poi, improvvisamente, scopriamo che fra Roma e La Maddalena si stende la pianura russa. E tutto si fa chiaro. C’è un racconto che sfila dalle bocche della Cvetaeva, della Achmatova, di Mandel’štam e di Beckett, un racconto che giunge fino a qui, dove sono, nella Genova di Campana, nella città che costeggia la Sardegna con l’aiuto di Jaccottet e di Cristina Campo, tenuti saldamente per mano dall’amica Antonella: la specie degli “imperdonabili” ha acquistato un senso in più. Me ne ero persuaso immediatamente nel 1992, quando uscì da Crocetti “Residenze invernali”, il primo libro di Antonella Anedda, il suo primo appuntamento con la speranza, con la forza che lega, senza mezzi termini, alla poesia. Un libro già alla terza edizione e che presto verrà tradotto in inglese: senza alcun dubbio una delle pochissime raccolte di poesia che resteranno con mille ragioni oltre il millennio. Ragioni pressanti, quelle di alleanze non astratte, quelle di una ricerca priva di egoismo. Se la vita non è un susseguirsi di stati di vuoto, allora essere contadini o insegnanti è la stessa cosa, allora isola e penisola coincidono, mare e pianura coincidono: ogni cosa è presente nell’oceano pensante, “intelligente”, di Solaris (Tarkovskij forse aveva compreso la miseria dei segreti, aveva così deciso di regalare al pubblico un chiaro aspetto dell’universo). Un fuoco che brucia non ci è di conforto, ma una lenta fiamma aiuta a farsi avvicinare da quelle parole che hanno vissuto troppo a lungo in silenzio. Gran parte dei libri sono pieni di sciocchezze, così le città abitate dagli scrittori, ma c’è uno spazio fitto di mani che s’intendono: nei brani che compongono “Cosa sono gli anni”, così come nelle sezioni che compongono “Residenze invernali”, ritrovo l’esistenza dell’uomo che diventa poeta soltanto se degno di voltarsi. Gli uomini che non scompaiono nel linguaggio sono “veri e poco stranieri”. Appena un po’ assonnati, appena un po’ colpiti da un altro tempo. Certi saggi nascono da brevi annotazioni per un racconto: costeggiando il passo di una persona, familiare o estranea, sembra che si possa attingere ai misteri che spesso i poeti (le grandi figure di questo libro, oltre alle già citate: Simone Weil, Emily Dickinson, Marianne Moore, Rainer M. Rilke, Paul Celan, Natan Zach, Amelia Rosselli) rendono silenziosi per meglio vivere con i figli e con i genitori. L’autrice parla anche di questo: di come un poeta possa vivere in famiglia senza troppo pesare su chi gli resta accanto, senza che i suoi scritti possano costituire un “pericolo” per la vita dei propri cari. Ecco, un rigore morale teso come la fune dell’acrobata fra un punto e l’altro dell’esistenza. Da qui parte, ancora una volta, e con parole compatte, una volontà capace di allearsi agli stupori, evitando di appesantire il respiro o abbandonando il fardello. Le figure che si scorgono in queste pagine sono madri, sono padri intenti a vegliare su fragilità intaccate, o in procinto di esserlo, dalla durezza dei giorni. Nel saggio centrale del libro, a cui dà il titolo, si richiama l’attenzione sull’attesa, l’unica vera sostenitrice di un fiore che riesce a crescere nella terra secca: lo spazio diventa più importante del tempo, poiché contiene quasi tutti i nostri gesti, necessari o meno. “Gli anni passati, quelli che forse passeranno: non sapere cosa siano è ‘the resolute doubt’ , l’intrepido dubbio che chiama senza voce, ascolta senza udire – che nelle avversità, perfino nella morte, ad altri dà coraggio. E’ il coraggio delle opere, delle parole, chiamate a sostare in questi fogli”. La scrittura si nutre del quotidiano, lascia perdere i grandi orizzonti per concentrarsi sulla maternità, sugli spazi più domestici. Smette con la morte, ce ne rende partecipi: la separazione, questa insidia che resta ai piedi sia delle persone amate che della poesia, come scriveva la Cvetaeva, come sottolinea Antonella Anedda, nutre il peso che ci addossiamo fino alla fine. Ma evitare il compiacimento, l’enfasi, ci porta alle cose infinite del mondo, al “naturale senso delle cose” cantato da Stevens nel suo ufficio di assicuratore. Nessun distacco da niente. “Questi sono gli anni”. Ho capito questo libro quando, dopo averlo chiuso sulle parole: “C’è il respiro di una bambina che si addormenta e nel silenzio, nell’ombra del lume da notte a forma di luna, ci sono io con un quaderno sulle ginocchia”, mi sono ricordato che Antonella l’ha dedicato, con piene mani di poeta, alla figlia Sofia. SENZA RECINTI Questo è un libro di gratitudini e rapine. D’immense gratitudini e di piccole rapine. Quando, a sedici anni, andavo a un appuntamento, studiavo. Come se quell’incontro, spesso senza seguito, spesso insignificante, fosse il preludio di un’alta conversazione, della più stellare delle unioni. E se c’era indifferenza questa derivava da ignoranza, semplicemente era luce che tardava. Studiando interrogavo me stessa e in quel dialogo silenzioso, nel mento sollevato verso qualcosa che era del mondo e non esattamente del monto, trovavo la forza di andare nel mondo. Ho continuato a incontrare così la scrittura. Quando leggo mi metto alla prova, alzo il viso per capire cosa posso imparare. Ciò che è stato scritto può non solo non essere perduto, ma sfavillare in attesa di essere decifrato. Eppure di ciò che ho letto e perfino tradotto non conservo quasi nulla. Come davanti all’amato, non è abbastanza o è troppo, come prima di un appuntamento, nello specchio non c’è che vuoto e un bagliore che è anche paura. Ho messo tutto in tasca fugacemente e se rovescio le tasche, ecco non ci sono che frammenti: un po’ di bucce, qualche biglietto. La rapina dunque non è riuscita. Resta la gratitudine, forse il coraggio. La gratitudine è per questo coraggio, per la solitudine che viene da un libro socchiuso in lontananza. E’ il roveto della mia balbuzie. Le frasi, come le bucce, sono nel buio. Ho allineato le bucce sulla pietra. Sono il mio alfabeto. Ciò che ho letto stamattina – una poesia per me ancora sconosciuta, pochi versi tremendi, di separazione, quella dura poesia di Zbigniew Herbert intitolata “Alle porte della valle”, letta mentre aspettavo l’autobus e poi in autobus, ora si unisce al corteo di luci sulla strada bagnata e alla frusta di brividi che mi dà da pensare la morte di chi amo. Cose prive di cielo, più forti di ogni abbandono, della freddezza di una voce. Queste prose sono nate in autunno, due anni fa, nell’isola di un’isola. Per arrivare sul Continente bisogna prendere un traghetto e, dopo un tragitto in pullman fra curve di querce, un secondo, più grande traghetto. Nei giorni limpidi s’intravede la Corsica e fino a poco tempo fa una nave partiva per Bonifacio, radente gli scogli, lungo il maestrale delle Bocche. Laggiù ho scritto a memoria, con pochi libri sul tavolo, poi, a casa, a Roma, ho controllato e corretto le citazioni, perché spesso le avevo trasformate e resistevano, in una specie di sogno ostinato. Ho lasciato inalterati i sogni veri e tutto ciò che era andato così lontano da essere ormai irriconoscibile. Sono grata ai traduttori dalle lingue che non conosco: trascinano lontananze, spesso oscuramente, con fatica. A uno di loro, solo un nome, senza età, né volto, fermo alla data di pubblicazione – 1931 – per la casa editrice Barion, devo l’incontro con il primo libro in cui mi sono perduta e di cui non riesco a dire nulla: “Guerra e pace”. Per anni, in una sovrapposizione irragionevole (giallo, erba bruciata, solitudine ?) e ragionevole (mia nonna Ester che conosceva quasi tutti i romanzi russi dell’Ottocento), la campagna sarda è stata indistinguibile dalla steppa e io non tanto da Nataša quanto da Andrei Bolkonskij. Quella chiusura, quella pena davanti alla primavera e, inaspettato, improbabile l’amore; e stadio dopo stadio la delusione, il distacco e, sul ciglio della morte, una fessura in cui tutto perdendosi acquista un senso. Più tardi la fessura è stata “La morte di Ivan Il’jç”, ma quella tarda infanzia dei tredici anni appartiene al ricevimento in casa Rostov quando il vecchio balla con Mar’ja Dmitrievna, e alla danza contadina di Nataša a casa dello zio, dopo la caccia al lupo. Questo per me lega la Sardegna alla Russia: essere contadini e pastori, essere asiatici (gli occhi sono all’insù, e gli uomini volteggiano sulle groppe dei cavalli), una sfrenatezza triste che è lo stesso richiamo della musica (non da camera ma da spiazzo d’erba, non da borghesi ma da servi-pastori uniti come anime alla piccola nobiltà terriera), l’essere estranei e insieme inchiodati all’Occidente. E lega la Sardegna a una povera Bisanzio (dunque già alla Russia) la nera Madonna di Bonaria arrivata a Cagliari su acque notturne di naufragio con il corpo tozzo che stringe un grido bloccato: quello dei marinai prima e dei monaci poi che videro la candela miracolosamente accesa, nonostante il legno, nonostante il mare. Allora sì giallo, erba bruciata, solitudine, e lanciata in avanti, già nel tempo che poi avrei raggiunto, la foto di un bambino conosciuto solo da adulto, una foto anni cinquanta scattata a Mosca, come si legge sul retro: un viso biondo-sfocato nel grigio inverno dell’aria, un sorriso incerto, più grande dei suoi cinque anni. “Domani tornerò, ci sarà tempesta, o il vento si placherà di colpo nella notte”, avevo annotato prima di partire. Il vento si è placato. I fogli: la traduzione di “Che cosa sono gli anni” di Marianne Moore, e i libri: “Mal vu, mal dit” di Beckett, “Indizi terrestri” di Marina Cvetaeva, “I quaderni di Voronez” di Mandel’štam, erano asciutti sulla panca del ponte, nel sole di dicembre. Queste prose non sono saggi, o forse lo sono, nel senso di una scrittura che saggia la terra del libro, la penna come un ramo nel fango per capirne la profondità. Sono un saggio di me stessa: offrono non il fianco, ma il collo. Sono la memoria di frasi cresciute su altre frasi, il debito verso chi muore con frasi strette in gola: interi universi rosi lentamente dal vuoto. Ho voluto raccontare ‘anche’ il momento in cui chi legge solleva gli occhi dal libro, dare spessore alla durata, alla coscienza di uno sguardo. Non fingere, ma per necessità, come non possono fingere la “Sainte Victoire” di Cézanne e gli oggetti schiusi e moltiplicati nello spazio cubista. Una storia senza trama, senza protagonisti, per lampi e lingua senza recinti. Un tempo che diventa spazio, lo spazio della pagina dove si chiude la parola, tempeste di segni che posandosi chiamano lontananze. Uno sguardo dalle feritoie, non oltre ma accanto alla scrittura. Dire, nell’attimo in cui si smette di leggere, la trasformazione degli echi, eco dell’eco, che incrocia senza paura il volo della sabbia dall’aiuola del cortile. “A seconda del vento che ti spinge / intorno alla parola si addensa la neve”. Non solo un commento a Paul Celan, ma tutte le nevi e i venti e le striature bianche sul marmo verdecupo del tavolo e lo schiudersi della foresta, e – obliquamente – con la coda dell’occhio, l’insolito vento di stasera che piega i cespugli del Granicolo. Come il nome di Osip Mandel’štam per Celan, altri nomi scendono lungo una rotta dove ognuno a suo modo trova il suo luogo e il nome profondo cui appartiene. Le citazioni, che a voce, con la mia voce, mi ripugnerebbe fare, qui sono il vero suono di voci altrimenti perdute, sono la prova di un passaggio: sì, comete, sì, tracce di un regno che l’arte imita senza conoscere ma anche le orme di realtà sulla realtà, linee lievi o profonde come quelle del destino sulla mano. Orme che sono separazioni, dunque anche stelle, a seconda dei passi, a seconda del vento. Per questo nella distanza dei libri non ci sono distanze, in ogni pagina che basta un fiammifero a bruciare arde ciò che ci spinge: una passione che non è salvezza, che non è conforto. E le città italiane sono piene di “innocenti” come Lizaveta Serdjašcaja dei Karamazov, che battono la testa sul selciato e restano distese con la guancia rigata dal sangue. Come una donna, qualche settimana fa in pieno centro, caduta di colpo dopo aver riso e gridato e poi rimasta ferma, con la mano serrata alla ruota di una bicicletta mentre in alto la voce di qualcuno diceva: ave maria, e gli ombrelli si chiudevano sotto la pensilina nella mattina di pioggia. Questa realtà non la finzione di una trama mi autorizza a dire: “io”. Io tento di decifrare nel raggio ristretto del linguaggio l’enigma di quella guancia, il pudore di quel corpo nel vestito sollevato. Tento di capire che cosa è il tempo, il chiuso tempo di ognuno a petto del tempo dell’altro. Il tempo fitto dei libri e il grande, il leggibile tempo della creatura ferita. Cosa sono gli anni. Ancora distesa sul ventre la donna non gridava più. Adesso era immobile, quasi fiduciosa, le dita strette ai raggi della ruota, quasi in ascolto. NOTE PER UN VENERDÌ SANTO. POETI VECCHI Stamattina sull’autobus, alle sette: persone stanche ed estranee, uomini e donne dalle gambe già gonfie che spingendosi a vicenda cercavano un posto su cui sedersi e dormire. Nessuna bellezza, nessuna gentilezza, nessuna luce, ma il giallo dei lampioni, dei volti, delle strade bagnate. Un mondo livido e immerso nella solitudine eppure indiscutibilmente nostro, una vicinanza inquieta fatta di cose impenetrabili. Da qui a volte hanno risposto le voci che con disperazione e desiderio Ingeborg Bachmann chiamava “frasi vere”, da qui e dalle stazioni all’alba, dagli orti bruciati, dalla visione di case con i lumi ancora accesi dove ombre chine su ombre consumavano una colazione lontana. Per questo scrivere, cioè ascoltare, vedere e sull’udito, sullo sguardo, accatastare lavoro, contempla l’umiltà dell’errore, la fatica dell’errare. Tutto lo sforzo, il buio e la breve, incerta lucerna di un verso che sembra raggiungere il nocciolo duro della mente, tutto è in un invisibile crescere che a un tratto, forse come il legno sotto la terra scatterà in avanti, in un ramo. Se c’è poesia è in quel moto, in un linguaggio – parole semplici, le più usuali – che a un tratto compone un sistema nel quale i suoni sono la punta estrema nel quale i suoni sono la punta estrema dei pensieri. Perché a monte dell’ispirazione c’è davvero un monte che solo la perfetta distanza, quella cima di neve solcata dal vento, ci dà la forza di scalare. Raramente l’ispirazione coincide con la pienezza della forma, occorre che si contragga un nodo più forte: desiderio e disperazione e là, nel buio della corda intrecciata, l’impotenza del linguaggio, la lingua serrata e infittita. Un fiato terreno che sostenga lo sforzo: il cane sanbernardo che soffiando calore salva l’assiderato nella neve. ”Di nuovo in autobus”. In quello stesso giorno, anzi era quasi notte, con i lampioni accesi e i negozi chiusi, un altro vecchio, una vera icona di vecchio con il cappello bagnato e le spalle piegate è salito dalla porta riservata a chi ha la tessera con una borsa piena. Subito ha salutato qualcuno e dall’ombra dei sedili è emersa un’altra ombra, una vecchietta d’ombra, con un cappotto color fumo, con le scarpe quasi nuove ma estive – fa ancora molto freddo – e i capelli puliti ma tagliati storti, anche loro grigi, un incrocio fra la cenere e il topo. “Tieni” ha detto il vecchio. Ha preso un frutto dalla borsa e lo ha teso alla vecchia. “Non ti privare”, ha risposto lei, “però grazie”, ha aggiunto poi tendendo anche lei il braccio, e lì nel vuoto dell’autobus la grande pera rossa è restata per un attimo fra le loro mani. Non so se si conoscessero come sembrava dalla familiarità del tono ma entrambi erano su una sponda diversa, di remota e rovesciata infanzia. Questo racconto è ciò a cui affacciarsi scrivendo, è un tentativo di precisione e dimestichezza. Perché la parola è dimessa e insieme precisa, ha bisogno di poco e può partire da queste pentole colme d’acqua che scintillano nel pomeriggio a ridosso del sole, da questa persiana verdemuschio socchiusa e scrostata, da queste tazze colme di latte. E vorrei usare il linguaggio per “bisogno”, come si una un oggetto quotidiano: tavolo, sedia, cappotto. Usarlo senza gioco, senza rito, senza allusione, solo con il discernimento del senso e dell’ascolto: le parole degli altri, le nostre, il grido del lattaio al mattino. A questo orizzonte appartiene la spenta grandezza della poesia di Wallece Stevens. “Il freddo, le aurore boreali, il lavoro d’assicuratore”. I versi nascono durante il tragitto da casa al lavoro, lentamente, secondo il passo di un uomo anziano, e sono versi coscientemente senili, cioè scritti dopo aver fissato bene la vanità. Non è l’equazione vecchiaia-saggezza, ma Stevens, come Kavafis, in parte come Celan che respinge le sue composizioni giovanili, trova la sua voce relativamente tardi e questo ha in poesia un suono inconfondibile. È il suono, spesso tragico, di ogni conversazione, non importa se immaginario, di fogli bruciati, è l’intero, stavolta ben chiaro a portarsi del pensiero e del corpo in un’altura da cui, non ci si mette una mano sugli occhi, si può vedere la fine. Il poeta vecchio è il poeta che non è morto giovane, un essere ferito per sempre, che “sente più acutamente il freddo” per sempre fuori da ogni gerundio. Non sta “invecchiando” ma “è già” vecchio, in un presente che è lapide e coltello: “Il mio corpo, la mia figura invecchiano: / è una ferita di orrido coltello. / Io non so sopportare”, scrive Kavafis nel 1918, ma la poesia non è che il sigillo di un vivere la vecchiaia che appare già dai quarant’anni, con titoli espliciti: “Un vecchio”, “Le anime dei vecchi”, e che è solitudine del corpo costretto a misurarsi con uno spazio breve, con il breve incanto indispensabile a dare e ricevere piacere. Non era, non era forse solo l’omosessualità il timore dei pregiudizi altrui la causa della reticenza e del pudore a pubblicare di Kavafis, ma la coscienza di quanto è debole comunque la narcosi della poesia rispetto all’essere amati, di quanto poco possano saggezza, cultura, successo di fronte all’indifferenza di uno sguardo. Questa è la via straziata del desiderio, dolore senza scampo, straziato dall’orrido coltello. All’ “io” non so sopportare” di Kavafis, che è atrocemente vero, si può solo rispondere con: io imparo a sopportare, io sopporto, senza ricorrere alla morte, nella luce della vita, respiro, attesa, tepore che resiste. Candele ancora accese. Quando Stevens scrive: “One must have a mind of winter / to regard the frost and boughs”, l’animo invernale è ciò che occorre per vedere, sostenere le cose nella loro sfolgorante realtà. Come “il grande uomo rosso” che legge alle anime tornate sulla terra il poema che in cielo non potevano ascoltare, Stevens chiama i suoi spettri accanto alla pentola, alla stufa, alla brocca piena di fiori, lascia che “rientrino scalzi nella realtà”. Il rosso non è solo il colore dei capelli di Stevens ma, come nelle figure sulle coppe antiche, come nei nibbi i cui occhi con gli anni diventano sempre più rossi, il rosso della vita, della presenza, di una forma che prende colore. Gli oltre settant’anni del poeta servono a scardinare la distanza del desiderio e del rapporto tra “qui e laggiù”, tra mondo della morte e vita. Stavolta non siamo noi a dover imparare l’alfabeto di un mondo nuovo, sono le ombre dai cuori sottili ed esauriti a tornare sulla terra per ritrovare, risentire ciò che era loro mancato. A differenza di Marina Cvetaeva, Stevens non chiede notizie “da laggiù”, non domanda, ma legge e ascolta. La montagna a immagine dei monti Tatra che Marina scalava nel suo desiderio e nella sua disperazione per la morte di Rilke, ora è un orizzonte, povero, piano, fatto di cose, di sere qualunque. Se fosse vissuta, se fosse potuta diventare vecchia, Marina Cvetaeva sarebbe giunta fino a questa terra? O ci sono paesaggi preclusi da sempre, fin dal giorno in cui si comincia a scrivere? E dove devo spingermi io, che sono interamente, disperatamente dalla parte della montagna, ma capisco profondamente (già profondamente?) “l’emozione rotonda”, le luci boreali, il paradiso fisico della contemplazione? Da qui, dallo sguardo che si abbassa e distingue, si schiude il poco, l’immenso che ora avanza verso la notte feriale. E mi sembra che se non fossi tanto stanca, se non avessi tanto sonno stasera, venerdì santo, forse riuscirei a decifrare una scheggia del nostro destino e la quiete vegliata da una sola stella dentro il cielo bruno. Invece, a lungo, sogno. Erano fermi in branco, sotto una tettoia di lamiera. Pioveva, l’acqua scendeva in grossi rivoli neri. “Moriamo”, dissero i cani nel loro linguaggio. Alzarono i musi, mossero appena le zampe. I primi, i più vicini, le tenevano sollevate dondolandole con indifferenza. “Guardaci”, dissero di nuovo e con il solo oscillare delle teste mossero la pioggia come una tenda. Un lampo illuminò prima il cielo, poi la tettoia e la paglia. Nascosti dal fieno, qualche spiga posata sulla palpebre, distesi e immobili c’erano altri cani. “Avvicinati”, disse il più giovane, apparentemente il più sano con le robuste zampette incrociate per terra. Io andavo verso quella lingua sconosciuta che improvvisamente capivo. Attraverso stagni con sciami di oche selvatiche, camminavo fra l’erba. Era novembre, vedevo uomini tagliare i boschi, varcavo i cancelli, mi inseguiva lo scatto delle forbici intorno ai cespugli. Arriva davanti a una tettoia di lamiera, riconobbi il cane che aveva parlato per ultimo, con stanchezza, perché da allora erano passati anni. “Entra”, disse il cane. Non era sono come sembrava, aveva un lungo taglio sulla testa, dritto e rosa in mezzo al pelo rossiccio, aveva le zampe intatte ma la coda spezzata, piegata come un guanto dietro il corpo. “Seppelliscici”, chiese, poi si distese su un fianco. Amavo i cani. In quella terra che avevo appena lasciato li tenevo vicini sotto i castagni o accanto alla sedia davanti al camino. E l’ultima sera li avevo ascoltati abbaiare fuori dalla finestra, innocenti e vivi. Adesso anche loro erano usciti dal mondo, forse infilando una porta per sbaglio, forse pensando di seguirmi in una passeggiata ma lì, davanti a quella tettoia, in quel tempo diverso e slittante con qualcos’altro al posto del cuore non potevo più amarli, non potevo toccarli. Fu questo. Fu sufficiente pensarlo guardando i corpi gonfi dei cani morti, distogliendo gli occhi da quelli feriti. Bastò l’incertezza. Non sarei entrata nel regno dei cieli. Avrei ruotato a lungo, ciecamente, fra le cose del mondo. Finché la miseria che mi spingeva come un vento non si fosse placata. UNA MINESTRA DI ORTICHE Nell’aria dell’isola, nell’improvviso maestrale dopo il tepore dei giorni passati, balenano volti appena intravisti in fotografie di libri, lineamenti composti dalla carta e poi fugacemente vivi. L’ortica, solo cibo a te e a Irina Nel deserto di gelo della guerra. C’è un ultimo capitolo da scrivere intorno a Marina Cvetaeva che riguarda sua figlia, Ariana, Alja Efron. Di questa bambina “con la pelliccetta azzurra” che a cinque anni recita i versi di Blok sembrano restare soprattutto dettagli: la capacità di scaldare avanzi e rendere commestibili poche foglie di ortica, la grazia metafisica di alcune risposte fissate nella prosa di “Indizi terrestri”, il respiro delle lettere scritte quasi per tutta la vita a Boris Pasternak dalle tremende distanze in cui la costrinsero a vivere. Fino all’adolescenza Alja è accanto a Marina con una devozione che non offusca ma acuisce sofferenza e sguardo: “Mia madre è molto strana. È paziente, sopporta sempre fino al massimo. Sia arrabbia e ama…”, annota in uno scritto del 1918. con la madre condivide le cure per la sorella minore Irina ce morirà di stenti in un orfanotrofio, condivide l’esilio. Basta scorrere le lettere raccolte ne “Il paese dell’anima” e in “Deserti luoghi”, per trovare conferma della bellezza ma anche della difficoltà di un legame che è insieme alleanza esigente, reciproca esaltazione, unica responsabilità nei confronti della parola, orgoglio. “Pasqua del 1922”: “Ho detto ad Alja non andiamo in chiesa, andiamocene a dormire come i cani. Dio non ha bisogno del nostro dolore”. Con gli anni la vicinanza fra madre e figlia si trasforma in distacco: nasce Mur, il fratello ciecamente idolatrato da Marina, e Alja vede nell’attività politica del padre, Sergej Efron, una via d’uscita al disagio, alla mancanza di identità della condizione di emigrata. La vita all’estero è durissima. Alja si allontana, “non ha cura di sé, si annulla in lavori materiali”. Si convince con il padre e con Mur diventato nel frattempo fanatico e ottuso, che occorre tornare in Russia; tutti e tre trascinano Marina Cvetaeva verso un destino talmente più atroce dell’esilio da diventare, il 31 agosto 1941, morte. Alja seppe la notizia in ritardo: era stata arrestata di notte, all’improvviso. Era così sicura della sua innocenza che non aveva voluto salutare nessuno. A causa dei maltrattamenti perse il bambino che aspettava. Fu rilasciata e poi di nuovo deportata. Di questi anni restano le lettere scritte a Boris Pasternak, lettere aspre e coraggiose – come le definisce Philippe Jaccottet – lettere con un respiro tanto ampio da addolorare, se si confrontano con l’assenza di un’opera, ma che invece sono altezza, sapienza, e sono state “per me” vicinanza, durante un periodo di viaggi, all’alba, dalla città ai Castelli, nella sala d’aspetto delle ferrovie laziali e poi in treno. Lettere quasi senza interlocutore (Pasternak era più prodigo di aiuti materiali che di risposte), quasi, perché io ero un’interlocutrice a sorpresa, a distanza, impensabile. Perché da lì, dal finestrino, dal lago e dal paese italiano che si riflettevano sul vetro, seguivo i passi dei trasferimenti, le illusioni della riabilitazione politica, intuivo la gioia con cui la scheggia della frase di un libro lontano scendeva sul cortile gelato di una confinata politica. Pochi furono gli essere umani in quel tempo all’altezza di questa dignità. Fra i ritratti di Necropoli, quello dello storico ebreo Michail Osipovic Geršenzon non è solo il più commovente, ma quello attraverso il quale Vladislav Chodasevic ha rivelato cosa fosse per lui realmente “scrivere”, Geršenzon è l’antitesi del letterato, la sua generosità, la sua mancanza di affettazione e di cinismo sono l’esatto opposto della meschina volontà di potere di Brjusov. La sua carriera di studioso ebbe inizio e fine nella povertà. Scrive Chodasevic ricordando gli anni della rivoluzione: So per certo che Geršenzon e la moglie Marija Borisovna, all’insaputa dei figli, talvolta non mangiavano nulla per ventiquattr’ore filate, nutrendosi di tè non zuccherato e lasciando ai figli ciò che c’era in casa. Facendo la fame, stando in fila per ore al gelo, spaccando la legna Geršenzon non si fingeva superiore, ma neppure si atteggiava a martire: era semplice, serio ma sereno. Si toglie la fascina dalle spalle, si scuote la polvere dal vestito, riprende fiato, e poi all’improvviso con un’occhiata allegra, si mette a parlare di cose serie, indispensabili, importanti: ha deciso di darsi da fare per uno scrittore arrestato, trascinandosi chissà dove al Cremino. Posso unire la linea invisibile di questi immagini fino alla fila del carcere delle Croci dove Anna Achmatova aspettava notizie del figlio, fino al legno della stanza e mezzo dove si spensero i genitori di Iosif Brodskij. E più indietro fino alla forma geometrica di un campo, di un quadrato o di una grande figura dai molti lati. Un prisma su cui stanno rapidi ed eterni i destini che hanno onorato e svergognato la Russia. 27 dicembre 1938: nella baracca di transito di Vtoraja Recka, Vladivostok, i prigionieri della baracca numero 11 vennero condotti al bagno per un trattamento sanitario: Un fortissimo odore di zolfo ci prese alla gola facendoci lacrimare. All’improvviso c’era un caldo soffocante (…) Osip Emilievic fece tre o quattro passi, come per allontanarsi dalla camera di sterilizzazione, levò la testa in alto, orgogliosamente, fece un profondo respiro e crollò a terra. Osip Emilievic e Osip Mandel’štam, nella memoria di Jurij Moiseenko un deportato che gli fu vicino nelle ultime ore. Una dottoressa del campo accertò la morte di Mandel’štam, gli legarono una placca alla gamba, buttarono il corpo su un carro. Fu seppellito in una fossa comune. Così Izrail’ Metter ne “Il quinto angolo”: Evgenija Markovna e io non vivemmo a lungo nello stesso appartamento. Un mese e mezzo dopo il mio trasloco ricevette una citazione dalla sezione locale della milizia che non lasciava presagire nulla di nuovo. La accompagnai, non stava troppo bene. Davanti alla sezione, nel giardinetto accanto al monumento a Lomonosov, aspettavo Evgenija Markovna tenendo sulle ginocchia la sua figlioletta di un anno. Dovetti aspettare a lungo – poi venni a sapere che Evgenija Markovna era svenuta nell’ufficio del capo. La fecero rinvenire con l’acqua e le consegnarono l’ingiunzione di partire da Leningrado per il Kazachstan entro tre giorni. Partire significava non poter portare con sé la bambina. Il “quinto angolo” non è solo fisicamente quello che i poliziotti del Gpu facevano cercare a calci alla vittima, chiusa in una stanza di quattro angoli. È l’angolo dell’impotenza e dell’inermità. È quella figlioletta che la burocrazia non prevede, come il malore di sua madre fatta rinvenire a forza con lo stesso accanimento dei guardiani nazisti che impedivano ai prigionieri di uccidersi. È quel padre trascinato nei lager per tutta la vita per colpe inesistenti di cui racconta Jurij Nagibin in “Alzati e cammina” con lo stento e la luce di un legame innaturalmente capovolto. In questo padre che invecchia, inchiodato dalla prigionia a una condizione di minorità, c’è lo stupore ma anche l’ironia di una creatura offesa senza motivo che oppone all’insensatezza della persec
“Cosa sono gli anni”, una raccolta di prose della poetessa sarda Antonella Anedda
Penne immerse nella terra
Una scrittura che esplora la quotidianità e fugge la morte
Sono rare le voci riconoscibili nel panorama della poesia italiana di questi anni. Rare e sempre sul punto di perdersi, di confondersi in quel brusio di fondo che sembra contraddistinguere una pratica vieppiù ghettizzata dal mercato editoriale, talora non senza la complicità, la compiacenza sottile e snobistica, degli stessi poeti. Bene ha fatto la rivista “Poesia”, allora, a dedicare il cahier central del suo numero di settembre al nuovo libro della poetessa sarda Antonella Anedda, già autrice di una raccolta di versi “Residenze invernali” edita proprio da Nicola Crocetti, si è imposta per un’intonazione del tutto particolare della sua voce poetica – un vibrato che un po’ ricorda il famoso “tremulo” che Josif Brodskji attribuiva a Marina Cvetaeva, la capacità di tenere una nota dall’inizio alla fine di una composizione – . Ma proprio perché nel caso di “Cosa sono gli anni” non si tratta di un libro di versi, bensì di una raccolta di prose e di mediazioni che attraverso una lettura personalissima ritrovano le parole della grande tradizione, poetica e non, del nostro Novecento, da Simone Weil alla già citata Cvetaeva, da Celan a Brodskjii, passando per Mandel’stam, Marianne Moore, Etty Hillesum, Nathan Zach, Amelia Rosselli, non senza rendere omaggio al più lirico di tutti i registi cinematografici, lo scomparso Andrei Tarkowskji. Scegliendo la prosa, infatti, scrivendo i suoi “poemi terrestri”, Antonella Anedda rompe quella dura cortina di incomprensione e di misconoscimento che divide prosa e poesia, tanto più in una tradizione come quella italiana profondamente condizionata da un’idea a un tempo sublime e inibita di tutto ciò che è lirico. Accettando con ciò il rischio insito in ogni lingua che rimane impigliata (e ferita) nelle maglie del mondo: la balbuzie. “Un fuoco arde in lontananza – si legge in “Senza Recinti” – E’ il roveto della mia balbuzie”. Con ancor più nitore dello stesso “Residenze Invernali” – diario di una discesa negli inferi boreali della malattia – “Cosa sono gli anni”, accetta di far passare il suo respiro attraverso il setaccio ghiacciato del male e della storia, non dimentica mai che, se si vive e si scrive, si vive e si scrive nel secolo di Aushwitz e della Kolima, sospesi a un frammento di coraggio, con un alfabeto quasi minore, fatto di scorze, di “bucce”, di parole indisponibili al sublime, dure di povertà come le patate dipinte da Van Gogh. Ispirazione e coraggio, in queste prose, fanno tutt’uno, a sorreggerle è lo spessore di uno sguardo che dal libro si solleva – cioè si abbassa, scendendo, come avrebbe detto Simone Weil, “con ali più forti” – nella vita. Per non perdere la misura dei propri simili, la misura degli altri, per riparare con la scrittura la stessa separazione che essa impone: un’aureola senza privilegio. “Tento di capire che cos’è il tempo, il chiuso tempo di ognuno a petto del tempo di un altro. Il tempo fitto dei libri e il grande, illeggibile della creatura ferita”. “Cosa sono gli anni”, per l’appunto. Prose che non saggi, se non nel senso di “una scrittura che saggia la terra del libro, la penna come un ramo nel fango per capirne la profondità”, che non cedono all’alienazione teologica del romanzo – all’idea di essere altro da se stessi – ma che nemmeno brillano della luce capziosa, da gemma soffocata, di tanti “taccuini di poeta”.Poesia e prosa si prolungano l’una nell’altra fino a diventare indistinguibili, l’una racchiusa nel tempo, contratta in una musica profonda, irredimibile, l’altra lanciata nella continuità di uno sguardo che ha deciso di non evitare nulla, di lasciarsi ferire dallo spazio. Le immagini dell’Anedda sembrano sfiorare le cose, in realtà le folgorano. Sono una mano che si chiude sul tempo per strappare al bottino della morte qualche brano di luce, un istante che si taglia e poi ricade. Bellezza e salvezza, musica e sguardo, aria e corpo, ali e scarponi che affondano nella neve. La tentazione di alleggerire questo libro, di renderlo meno inevitabile, meno scomodo di quel che è, può essere comprensibilmente molto forte. Parlare, come fa Elio Grasso nella sua pur appassionata introduzione su “Poesia”, di una scrittura nutrita dal quotidiano che respinge l’insidia della morte ripiegandosi nella luce della felicità domestica, è ancora ridurlo a un’immagine, sia pure intesa, di minorità lirica. La Anedda non è la Dickinson, rinchiusa nella bolla tenue e infelice di un Domostroj. E’ assai meno sola. Molto più esposta. Come la casa della Cvetaeva che “brucia nella notte”. Come la parola evocata da Mandel’stam, il suo fuoco ci sveglia “nel mezzo del cammino”.
– 11/01/1997
Temi in oro e nero
Un libro splendente, che manda luce, da tenere sul comodino, da centellinare poco alla volta per gustarne meglio il sapore. Un libro privo di trama, in cui il miracolo del linguaggio s’interseca con la vita. È il miracolo della scrittura – straordinaria, rigorosa, costellata di metafore inedite e necessarie – che Anedda stende tra racconti e saggi. Ci sono momenti teneri, intimi e semplicissimi che allargano il respiro o lo restringono per la pena, se lo sguardo del cuore dell’autrice, magari nelle prime ore mattutine su un autobus, coglie una deformazione fisica, la sofferenza di un volto, la fatica di esistere, o la tenerezza tra due persone anziane. Un narrare di sé e del mondo, che dà corpo a una scrittura incarnata, che si fa sangue, vita e contiguità con la morte. Anedda, oltre alle doti intellettuali, di sensibilità, attenzione e osservazione, che distilla nella musicalità delle parole, ha racchiuso nello scrigno dell’anima il sentimento della compassione, qualità rara e quasi assente in questa fine millennio dove si indugia solo sulla superficie levigata delle cose. Qualità, con le altre, che rende prezioso e unico tutto il testo, rendendoci più riflessive/i e consapevoli dei nostri limiti. “Questo è un libro di gratitudini e rapine” dice l’autrice, facendo riferimento alle diverse figure letterarie del volume, che popolano il cerchio magico tra vita e arte, tra presente e passato. L’itinerario si sposta dalla Bibbia al Corano, all’Odissea, all’opera di Pasternak, Mandel’stam, Rilke, soggiogandoci. E ancora da Herbert, Milosz e Szymbiorska, i grandi polacchi del Novecento, a Emily Dickinson, Marianne Moore ( “la luce del suo linguaggio è ciò da cui imparare” ), a Simone Weil, alle poetesse russe Marina Cvetaeva, Anna Achmatova e a molti altri scrittori e scrittrici come Hetty Hillesum e l’amata Cristina Campo. Con la sua parola pura e indispensabile scava nell’essenziale e sente “la necessità della modestia e il mistero del coraggio, la lotta da sostenere con se stessi, per essere liberi, per essere profondi”. Anedda dice di aver capito l’opera di Marina Cvetaeva, dalla “vita incalzata da se stessa e dagli altri e tuttavia annodata in un laccio di infinita pazienza”, durante una lunga fila tra la gente, invece che nella quiete della sua stanza, coniugando letteratura e mondo nel suo sguardo acuto. L’autrice vede i bagliori che ha lasciato la penna della Cvetaeva, nonostante l’orizzonte buio che la circondava e le terribili difficoltà quotidiane, e tutto questo le fa sentire ancora di più la responsabilità dello scrivere, perché “le parole condividono il destino delle cose”. Anedda sente che l’unico senso della vita umana sta nella pazienza e nella “fatica” che la compongono fino alla sua conclusione. L’autrice deve aver osservato a lungo il dipinto di Klimt “Le tre età”, per rintracciarvi, invece della divisione temporale, l’unione, in quel colore in movimento, che si sposta “dalla bambina alla madre, e dalla madre alla vecchia”, trascinando anche l’osservatore sull’orlo del quadro attraverso le stagioni, le tappe della vita e degli anni. Nei biglietti che le erano rimasti nelle tasche si trova quel che resta di una lettura, di una poesia, il frammento di un’annotazione che riguarda la dimensione domestica dell’esistenza, perché gli anni sono un concatenarsi di giorni riempiti da gesti quotidiani e dalle persone che amiamo, senza che niente si distacchi da niente. Gli anni sono pure “il respiro di una bambina che si addormenta, e nel silenzio, nell’ombra del lume da notte a forma di luna, ci sono io con un quaderno sulle ginocchia”. C’è la scrittrice che annota, che veglia la piccola figlia Sofia alla quale spesso racconta le fiabe che raccontavano a lei da bambina. L’amore supera l’angoscia della morte/separazione. Anedda, più sicura e vitale, s’incammina nell’arco del tempo, scegliendo “le cose come sono, appena schiarite da sguardo e linguaggio” e, con Anna Achmatova, può finalmente riconciliarsi con l’idea della morte, e sussurrare: “Ho spento il lume della morte, e aperto l’uscio/ a te, così semplice e prodigiosa”.
– 10/01/1997
PAROLE
Toglie il fiato. “Questo è un libro di gratitudini e rapine (…). Eppure di ciò che ho letto e perfino tradotto non conservo quasi nulla (…): un po’ di bucce, qualche biglietto. La rapina dunque non è riuscita. Resta la gratitudine” (p.9). Riprendendo le parole di Antonella Anedda, la mia sarà una recensione (modesta) di gratitudine e di nessuna rapina. Intorno a quelle che l’autrice definisce le sue “prose”, si raccolgono, a grappolo, i pensieri intimi, le inquietudini metafisiche, l’analisi linguistica e quella estetica della giornalista, scrittrice, poeta e traduttrice Anedda. Il mosaico di temi è tenuto insieme dalla sua profondità d’animo e dalla maestria del suo scrivere. Che dire? Ogni pagina andrebbe sottolineata; dovremmo apporre una glossa ad ogni paragrafo… E poi, in compagnia della presenza costante di una metafora vergine – di cui la Anedda fa un uso sublime e del tutto nuovo -, in questo sangue che circola nel corpo letterario della scrittrice (il cui Dna presenta geni intaccati dal dolore), ritroviamo altre donne (Marina Cvetajeva e Marianne Moore), altri personaggi (Andrei Bolkonskij, Pierre Bezuchov, padre Sergio e Jurij Zivago) e, con essi, la voglia di andare a rileggersi pagine che abbiamo forse solo sfiorato, durante la nostra giovane età… Ma è il soffocante e ossessivo intervento della morte sulla vita, del mistico sull’agnostico, che dona un’andatura straziante alla scrittura della Anedda (“Non sarei entrata nel regno dei cieli. Avrei ruotato a lungo, ciecamente, fra le cose del mondo. Finché la miseria che mi spingeva come un vento non si fosse placata”). A consolazione e in extremis, è infine risucchiata, la Morte, dalla prorompente vitalità dell’Amore, sia esso per un figlio che s’addormenta al suono delle nostre parole, per le pagine toccanti di Tarkovskij, o più semplicemente per il nostro pertinace amore per la vita. Chiudendo le pagine di questo libro, sentiremo forte il desiderio di essere più profondi, di essere migliori.
– 10/01/1997
PAROLE parole
ANTONELLA ANEDDA COSA SONO GLI ANNI. Saggi e racconti Fazi Editore, pp. 131, lire 20.000
Togli il fiato. “Questo è un libro di gratitudini e rapine. D’immense gratitudini e di piccole rapine. Eppure di ciò che ho letto e perfino tradotto non conservo quasi nulla: un po’ di bucce , qualche biglietto. La rapina dunque non è riuscita. Resta la gratitudine. Riprendendo le parole di Antonella Anedda, la mia sarà una recensione ( modesta ) di gratitudine e di nessuna rapina. Intorno a quelle che l’autrice definisce le sue ‘prose’ si raccolgono, a grappolo, i pensieri intimi, le inquietudini metafisiche, l’analisi linguistica e quella estetica della giornalista, scrittrice, poeta e traduttrice Anedda. Il mosaico di temi è tenuto insieme dalla sua profondità d’animo e dalla maestria del suo scrivere.che dire? Ogni pagina andrebbe sottolineata; dovremmo apporre una glossa ad ogni paragrafo… e poi, in compagnia della presenza costante di una metafora vergine – di cui la Anedda fa un uso sublime e del tutto nuovo – , in questo sangue che circola nel corpo letterario della scrittrice ( il cui Dna presenta geni intaccati dal dolore ) , ritroviamo altre donne ( Marina Cvetajeva e Marianne Moore ), altri personaggi ( Andrej Bolkonskij, Pierre Bezuchov, padre Sergio e Jurij Zivago ) e, con essi la voglia di andare rileggersi pagine che abbiano forse solo sfiorato, durante la nostra giovane età… Ma il soffocante e ossessivo intervento della morte sulla vita, del mistico sull’agnostico che dona un’andatura straziante alla scrittura della Anedda (“Non sarei entrata nel regno dei cieli. Avrei ruotato a lungo ciecamente fra le cose del mondo. Finché la miseria che mi spingeva come un evento non si fosse placata” ). A consolazione in extremis è infine risucchiata, la Morte dalla prorompente vitalità dell’Amore sia esso per un figlio che s’addorme al suono delle nostre parole per le pagine toccanti di Tarkovskij, o più semplicemente per il nostro pertinace amore per la vita. Chiudendo le pagine di questo libro, sentiremo forte il desiderio di essere più profondi, di essere migliori.
– 10/01/1997
Le due compagne di scrivania
Toglie il fiato questo “libro di gratitudini e rapine. Eppure di ciò che ho letto e perfino tradotto non conservo quasi nulla: un po’ di bucce, qualche biglietto. La rapina dunque non è riuscita. Resta la gratitudine”. Parafrasando le parole di Antonella Anedda, la mia sarà una recensione ( modesta ) di gratitudine e nessuna rapina. L’ autrice di ‘Cosa sono gli anni’. ‘Saggi e racconti’ raccoglie le sue riflessioni critiche ed emotive, sotto il nome di prose, scritte due anni fa, nell’isola della bellezza, la Corsica. Quel che rende unico questo mosaico di testi, e il fatto che Anedda ha trovato il percorso segreto che unisce il quartiere altolocato, ma un po’ freddo della cultura con la periferia cruda e verace del cuore. Ossessiva è la presenza della morte, la morte fisica. Ma mentre nella prima parte del libro le angosce e gli accostamenti dell’autrice sono di tipo laico, nella seconda arte si avverte l’ingresso del soprannaturale. In “Andare via” , Anedda si chiede se il Cristo sia risorto davvero: “se Cristo fosse risorto dovremmo vivere altrimenti testimoniare attraverso le nostre azioni la sconfitta della morte. Ma forse Cristo no è risorto”. In Cosa sono gli anni, ( ri )visita stralci di letteratura russa, inciampando nel male e guardando il dolore come a dire noli me tangere. E allora scorgiamo le compagne ai fianchi della scrivania: da un lato la Morte, dall’altro la Vita. Quest’ultima si tiene un po’ più discosta, come se non esercitasse la stessa fatale attrazione, come se Antonella Anedda non nutrisse per lei la stessa passione che per l’altra. Dicono i Ching: La piccola volpe attraverserà il lago e Antonella Anedda lo attraversa navigando sulle onde sinuose che il suo inchiostro smuove “questo buio sul bianco”, lasciandosi alle spalle la morte terribile. Racconta il suo amore per l’arte di Tarkovskij, confidando in “un tempo in cui nessuno sarà più separato da chi ama”; dopo il lutto mangia frittelle. E alla fine, spera (e noi con lei) di aver riportato qualche punto nella piccola ma quotidiana, estenuante lotta da sostenere con se stessi.
– 09/01/2000
Antonella Anedda
Se già è difficile parlare della poesia in generale, le difficoltà aumentano di fronte ai versi di Antonella Anedda. Perché sgombrano il loro spazio in un territorio onirico, dove l’emozione si libera nell’immagine, il ricordo è visione, e il presente un bagliore che entra dalla finestra. L’ombra di un semplice oggetto postato sul tavolo. Poesia come fermo immagine. Se sono qui, e non blocco un istante ma lo colgo, lo assaporo nel suo passare, canto alla vita. O meglio, visto che la lingua dell’autrice nn ama dispiegarsi, suonare – prego per la vita. La concentrazione creativa è nei due tempi fondamentali di ascolto in raccoglimento e dialogo: parlare a e non di, come dice lei stessa dei poeti che ama, della poesia che cerca. Per non spostarsi dal cuore dei suoi versi occorre l’aiuto di un’autrice molto amata da Antonella, Emily Dickinson, la quale, con l’intensità che le è propria, in una lettera indica l’unico approccio possibile – sensuale, e dunque disarmato – alla poesia: “Se leggo un libro e mi sento gelare tutto il corpo, tanto che neppure il futuro può scaldarmi, allora so che quella è poesia. Se provo la sensazione fisica che mi stia spaccando il cervello, allora so che quella è poesia. Sono questi gli unici due modi in cui la riconosco. Nessun altro”. Residenze invernali esce nel 1992, e sembra che niente lo preceda e niente lo segua, perché nella sua lingua, nel modo in cui le parole si accostano e si dispongono in versi, vibra uno spirito di necessità molo più potente della tradizione e delle influenze – comunque fortissime e fondamentali, come emergerà dalle due raccolte di saggi. Il grande senso di sorpresa e la forte commozione che coglie a leggere queste poesie credo sia dovuto alla ricerca apparentemente paradossale di una lingua che prende le distanze dalla sua eloquenza, anche solo dalla sua capacità di dire. Così come la voce narrante vuole diventare oggetto / un duro spettro / capace di fermare / il sangue del suo cuore / incerto, d’inquilino. Apparente freddezza espressiva, che in realtà è generosa offerta. La voce deve inarcarsi, diventare “cosa” e non per umiltà, ma perché solo così, curva, potrà misurare la distanza che la separa dalla terra. Anedda sembra usare una lingua sorda a se stessa, bassa, da oracolo, a volte anche violenta e dura perché duro è da sciogliere il sigillo del creato. In qualche modo è forse disumano voler sorprendere il mondo, dunque anche se stessi, nello stato di materia informe, puro scorrimento di sangue, ombra corta che muta con la luce e scompare di notte; ma se disumano è l’oltre, ciò che non solo ci trascende, ma rispetto a noi semplicemente “sta di lato”, allora – inutile negare – quel nutrimento è la forza della poesia, che solo per contrasto accede al qui, al mortale. Nella scrittura di Antonella, la terrestrità è cosa gravosa da portare, una “desolata corona di pietra”, altrove una “corona del vuoto”, ma pur sempre corona, perché mentre abbatte solleva anche dalla necessità di avere pronto alle labbra un nome per la propria pelle, limite per l’anima assetata. Come potrebbe il poeta essere ascolto puro se la sua corazza, unico scudo contro il mondo e le ferite (tra cui la bellezza) che esso incarna, non si spacca? Credo che per questo il freddo, il ghiaccio e l’inverno disegnino molti dei paesaggi della poesia dell’autrice. Perché dentro, nel vero magma dove s’impastano i versi, tutto è già stato arso, l’io ha scoperto la sua labilità, il proprio misero essere finzione di rifugio dal perennemente mutevole, dall’insensato. Vibra ogni tanto l’ala di un angelo a coprire le ossa appuntite. Ma quanti gradini di cielo hanno sceso, questi angeli fiochi, da quelli invocati e temuti da Rilke nelle Elegie duinesi! La sezione che dà il titolo al libro, Residenze invernali, davvero – come dice Emily – spacca il cervello, perché ci introduce in un luogo inconsueto, un ospedale, fuori però dal tempo e dallo spaio; familiare e lontanissimo, simile a una “pietroburghese residenza invernale”. I versi di apertura sono di meraviglia e grido: Le nostre anime dovrebbero dormire / come dormono i corpi sottili / stare tra le lenzuola come un foglio / i capelli dietro le orecchie / le orecchie aperte / capaci di ascoltare. Carne / appuntita e fragile, cava / nel buio della stanza. Osso lieve. / Così la membrana stringe / la piuma alla spalla dell’angelo. Tutto è immobile e vuoto di attese, eppure in quel mondo senza lancette la vita è tale perché non si nega la morte che la illumina. la voce narrante è viva tra i morti, morta fra i vivi perché fra quelle pareti bianche e vetrate aperte (così nelle città spagnole spalancano le chiese) il corpo è accantonato, la mente avvolta in un torpore insolitamente caldo e forse estraneo, e solo così – senza corpo e mente – la mano che sempre stringe lo scrigno del possesso può distendersi e vedere che cosa accade una volta forzata la serratura… Che tutto si dilata in spazio e, mentre sfolgora, muore, come pallida luce che è lì, ma intanto comincia il suo viaggio verso una terra lontana: Ora, prima di andare, per un attimo sostiamo silenziosi sotto la porta, lasciamo correre lo sguardo dal soffitto ai corpi. poi ci incamminiamo con sacchi leggeri sulle spalle, con lo stupore dei viaggiatori mattutini. Residenze invernali parlano con brevissimo anticipo, come aspettando la notte su una sedia a dondolo. Perché la voce è soltanto presentimento di un’ombra. Della luce non si dirà affatto perché quando scenderà sarà come una falce che non salva nulla tranne i sogni tiepidi, quel dignitoso provare a vedere, annotare ostinato e amoroso, anche quando la volontà è spenta, e dell’immagine è colta solo una scia, contorni niente. Il significato verrà sparso come cenere su un fertile campo. La si guardi, questa poesia, la si ascolti, e presto ci si rialzerà dalla sedia immemori di quel senso che prima tanto ostinatamente si cercava. Perché la frontalità non spetta alla poesia: solo l’obliquo, il trasversale, l’affondo, il passo di fianco sono le sue cifre, le sue presenze. Forse per questo nei versi di Anedda tornano così spesso due aggettivi: “breve” e “verticale”, quest’ultimo riferito soprattutto ai corpi. Perché sempre la vita è sorpresa a picco sulla terra, quasi non avesse ombra e il suolo – per un impercettibile istante – dovesse spalancarsi ad accoglierla. Dopo Residenze invernali non è facile seguire l’itinerario dell’autrice stando alle sue pubblicazioni, perché la seconda, Cosa sono gli anni, raccolta di saggi e qualche racconto, si fa attendere cinque anni, ma dopo altri quattro volumi (tra cui uno solo di poesia, Notti di pace occidentale Donzelli, 1999) seguono veloci, a distanza di un anno l’uno dall’altro. Il silenzio che permea Residenze invernali è così pregno di echi che evidentemente molto vi è germogliato e cresciuto, ma con estrema lentezza perché la sua terra era dura e gelata, rivoltata zolla a zolla. Per quanto riguarda i saggi, si possono fare considerazioni di stile estendibili anche alla raccolta più recente, La luce delle cose. Innanzitutto sembra che in questi due libri sia molto forte l’impronta lasciata da Cristina Campo, da Antonella letta a fondo e poi, come afferma in un saggio in Cosa sono gli anni, non seguita nella sua ricerca ma abbandonata a un bivio, dove la nostra ha visto che “la perfezione ha la stessa iniziale della parola peccato”, e che non bisogna perseguirla ma chinarsi sotto il fardello del tempo e consumare la vita per descrivere le cose come sono, non innalzate alla luce del rito. Questo come scelta di poetica, di diverso sguardo puntato sull’esistenza. Ma Campo ha il merito, fra gi altri, di avere inventato una dimensione del saggio la cui unica regola compositiva è di non imporsi confini. Perché così deve fare anche il lettore: assorbire a mente scoperchiata e, nella scrittura, rubare il possibile, fare proprio il diverso, fin dove porta il respiro camminare senza sosta. Le due scrittrici, certo, si differenziano sul piano narrativo che decidono di occupare: Cristina raramente scende nel seminterrato, mentre Antonella, anche quando le parole vorrebbero portarla in alto, pare caricarle in ceste e scendere in cantina, disporle ogni volta su un tavolo mentre comunque è intenta ad altro: per ricordarsi quanto il linguaggio incarni al contempo la necessità e l’inutilità dell’espressione, dell’esserci qui e ora. Forse anche per questo deve a tratti esplorare la quotidianità, il gesto usuale, il succedersi delle insonnie. Così, nelle due raccolte, protagonisti sono si i libri degli altri (e nella seconda anche i quadri degli altri) ma sempre visti di taglio, attraverso la poesia solo di Antonella, che nel parlar d’altro intravede qui e lì tracce della propria origine. Non perché le stesse cercando, ma perché fiorisce a contatto e per differenza con opere di diversa mano e tempo. Nel saggio Segni sulla terra (in Cosa sono gli anni), ad esempio, trapela il primo violento germinare di Residenze invernali. L’autrice, per anni, andando al lavoro, afferma di aver visto di sfuggita il giardino di un ospedale, osservato i familiari vicino alle camere ardenti; ed ecco che: “Dopo anni, dopo molte inutili parole, dopo un lungo ostinarsi, di colpo e attraverso quelle stesse parole, la verità di quelle persone, di quelle immagini ha trovato il suo linguaggio. (…) Inaspettatamente le parole sembravano disporsi le une accanto alle altre come le tessere di un mosaico, forse disegnato da sempre, ma solo allora svelato”. Per un poeta, leggere altri poeti significa accogliere la loro consegna e, solo a posteriori, farne tesoro o rifiutarla, non per questo schivandone l’influenza, solo variando l’angolatura del bersaglio, riaggiustandone la direzione sull’accorso del proprio cuore. Ecco allora che per Anedda, nel Novecento che muore, neanche Rilke può indicare la strada. perché, ferma restando la grandezza dei suoi versi, il trionfo della poesia sulla morte è sempre più forte della dolce sconfitta dell’umano spoglio di illusioni, e finisce per sbarrare l’accesso alla profondità. Scrivere dunque, non per “oltrepassare” ma per “restare accanto” alla poesia, all’esistenza… Questo il sentiero spianato davanti al nuovo millennio, che il secolo precedente non ha saputo percorrere: “Per il Novecento che si chiude la poesia è una terra ancora da esplorare”. Quali lanterne luci e penombre dunque hanno guidato l’autrice? molte, oltre alle già menzionate, che si è felici di ritrovare nella seconda raccolta di saggi, come amicizie amplificate e pensiero ancora più accogliente: i russi Mandel’stam, Cvetaeva, Achmatova, Pasternak, Dostoevskij, e poi René Char, Paul Celan, e le nostre Maria Zambrano e Anna Maria Ortese… Il contrasto buio (notte)/luce (giorno) in questa seconda raccolta di saggi, è assunto non tanto quale tema, quanto prato senza recinti dove tutti i vari autori letti e guardati si confrontano, e non per esprimere nulla di davvero razionalizzabile, ma per mostrare come la ricerca attraverso i secoli e i millenni, pur variando per argomenti e stili, si svolge in un regno della mente dove tutto si confonde affinché sia possibile sentire; è lì che viene svelato tutto ciò che è dato sapere, ossia che la conoscenza pura non esiste, e noi vediamo solo l’ombra che la copre come un dolce velo. Così come il vero artista – sia che si incarni in Cvetaeva, Cézanne, Paul Célan o la stessa Anedda – sa che la comunicazione profonda è sempre e comunque una sconfitta, e che di quella bisogna parlare, di quanto i destini si schiaccino, si annullino, per restare dentro l’aureola no, ma la corona di pietra della bellezza. Ecco che allora la meraviglia de La luce delle cose scaturisce dalla finezza e insieme coraggio feroce con cui l’autrice lotta contro la paralisi che spesso agguanta la mano non solo desiderosa ma anche bisognosa di creare, perché scrivere (e dunque penosamente lavorare per “essere”) passa attraverso la sparizione dell’io affinché l’altro da sé – inclusa “l’anima ammessa alla presenza di se stessa” – sia. Illuminazioni che a volte portano alle lacrime: “Così concepisco la scrittura: scrivere per sparire, perché la vita si squaderni davanti a me, senza di me, il volto finalmente più sfocato del bianco dei fogli o dell’azzurro dello schermo, il volto privato del riflesso. Un mondo dove dimenticarsi: non uno specchio ma una pietra”; e “Forse scrivere è l’esercizio di rinuncia che consente ai nostri brandelli di realtà di affiorare, forse la realtà di noi stessi appare quando rinunciamo a tutto tranne al bagliore incerto che lascia intravedere il fuoco che trascorre dalla nostra origine alla nostra morte”. Arrivare a questo traguardo che solo apparentemente vanifica ogni sforzo, rappresenta, certo, un privilegio distribuito con incredibile parsimonia, forse perché prima di brillare come dono resta avvolto in una pelle di disperazione così cedevole in ogni poro, permeabile a ogni invasione d’infinito. In questo senso, la frase che svela, il quadro che diventa crocevia d’ombra e di luce sono nient’altro che attimi di tregua per chi persegue muto, incapace di spiegare anche a se stesso, cosa spinga ad avventurarsi nella corsa sul filo del nulla. Ma, a pensarci bene, che questa sia l’arte, ossia “un rinuncia a se stessi per portare alla luce se stessi”, proprio nella tragica strozzatura di impossibilità, racchiude lo stimolo a proseguire il cammino. Dice splendidamente Antonella, nell’incanto di una sola frase riferita all’opera di Rembrandt: “A differenza dell’angelo, la luce perde se stessa, viene per chi è dietro”. Questa disponibilità – a svanire per la luce, in nome della strada illuminata – rappresenta senz’altro quella parte femminile, e materna, della scrittura, mossa dal desiderio di farsi carico della vita, del destino, della morte e dell’amore altrui. Poesia forse non è altro che assecondare quell’istinto a farsi materia che accomuna il ventre e le parole. Solo così le generazioni non solo si succedono ma, forti di più fervida vita, si tendono e si stringono nello sforzo di comunicare. Probabilmente è con questo segreto movente che Antonella Anedda non si limita “solo” a tradurre (sua è infatti la versione italiana di parte dell’opera di Philippe Jaccottet, che con il titolo Appunti per una semina è stata pubblicata dalla Fondazione Piazzolla nel 1994) ma, come si può vedere in Nomi distanti, rilegge, ricrea, presta ai testi una terza voce scaturita a volte proprio dall’incontro fortunato di una poesia del passato più o meno recente con la sua traduzione già chiusa in sé, a suo modo perfetta. La terza voce può scattare ovunque il suo balzo: da Emily Brontë, da Zbigniew Herbert, da Ezra Pound come da poeti dialettali (Giacomo Noventa e Franco Loi), perché in realtà nessuna poesia può dirsi conclusa. Anche solo perché la stessa parola nel tempo si allarga e si amplifica con il mutare del linguaggio, a seconda del tavolo su cui il libro cade, è sfogliato. A volte la terza poesia ricalca in parte l’originale, è solo “acclimatata” nel dire di Antonella. Altre è una frase, Leggermente variata, che riapre una nuova ferita, e la riscrittura è il furto che consente una nuova creazione (si veda la splendida) reinvenzione da Emily Brontë). A leggere vien da pensare che forse proprio nel tradimento estremo, quasi spudorato, più che nella versione fedelissima (come è Jaccottet nell’italiano di Antonella) dimori la traduzione. E la ragione – perlomeno mitologica – c’è. Come dice Walter Benjamin nel famoso saggio del 1923, Il compito del traduttore, riferendosi alla mistica ebraica, un tempo esisteva un solo linguaggio come un grande vaso. Poi andò in frantumi e da allora parliamo e scriviamo con schegge che lasciano sfuggire il tutto dalle fessure. Nella traduzione, grazie allo scontro/abbraccio fra gli idiomi, scocca una scintilla dell’antica lingua pura. Nomi distanti ne è la prova, ogni poesia una rotta in barca verso mari lontani dove sognare – nitidamente – la terra più vicina, spiagge, casa.
– 02/05/1997
Il lessico passionale della poesia
Che cosa sono per noi gli anni se non un precipitato di parole e di relative emozioni – sembra dirci Antonella Anedda dalle pagine del suo libro – e sebbene il suo sguardo incontri perlopiù gesti quotidiani di passanti per le sue stesse vie, non così si comporta il suo ascolto, che ha filtrato tra tutti il suono dei poeti più amati e ha accordato l’orecchio sul timbro dei loro versi: così é andata componendo “la raggiante corona delle frasi”, la timida sequenza di “rapine” delle altrui parole, e l’enorme gratitudine per chi le ha pronunciate e si ritrova a dialogare, in questo libro, sul filo di un comune sentire, indifferente allo scarto dei secoli, alle distanze che mai avrebbero permesso un incontro. Che cosa ci portano gli anni, avrebbe potuto dire Anedda, se non pieghe nella carne e fenditure nel cuore: ma lo lascia sussurrare alle figure del suo coro ideale, che hanno scelto di esporre le proprie cicatrici trasformandole in seni sulla pagina, e hanno misurato il respiro del verso sul fiato che avevano in gola, talvolta sincopando in poche sillabe tristi o felici esuberanze dell’animo, oppure scegliendo di affidarsi a distensione metriche più intonate alla pacatezza del momento. Delle parole altrui Antonella Anedda si é nutrita per scalare le vette più alte del suo sentire, se é vero – come dice – che prima di andare a un appuntamento leggeva frsi che le riempissero il cuore, forse per portarne il battito più contiguo alla mente, o per fortificarsi di fronte all’eventuale indifferenza e potersi dire che, semplicemente, “era luce che tardava”. Si é tentati di compiere, con le frasi di Anedda, la stessa operazione che lei ha osato con i suoi poeti, rubarle le parole perché talvolta é difficle resistere all’incanto dell’immagine che in esse si compone: più che prose le sue sono frammenti lirici, sospesi alla lievità di un sogno; e più che saggi questi scritti sono prove di saggezza come quelle che derivano da una consumata esperienza, oppure – come lei scrive – sondaggi sulla “terra del libro”, con la penna usata a mo’ di ramo per scoprire quant’é profondo lo strato che si offre e dov’é che oppone resistenza, quanto occorre scavare per trovare le fondamenta del senso, o l’origine di un significato riluttante a mostrarsi in superficie. “Occorrerebbe fermarsi sul ciglio di ogni verso” – scrive Anedda – esporsi fintanto che si arriva ad afferrare quel “tu” con il quale la poesia ti si rivolge, ti chiama a farne parte. E convoca sulle sue pagine parole e gesti tra lro lontani, ma tutt’altro che estranei: l’espressione della fatica che ci trascina nei “Beati” di Maria Zambrano, e la vernice che, come il tempo, trascolora dalla bambina alla madre alla vecchia nelle “Tre età” dipinte da Gustav Klimt; e ancora, “lacrime o sudore” di sfinimento sul viso di Marina Cvetaeva, tracce di una vita senza tregua, dell’eroico affaticamento da cui si origina e in cui matura l’intera sua opera. portano il segno di una stanchezza disumanante anche le parole di Simone Weil, operaia presso le Fonderie Bernard, quando scrive della sua dignità spezzata “sotto i colpi di una costrizione brutale e quotidiana”, e la santità della vecchia Pasenka descritta da Tolstoj in “Padre Sergio” é inscindibile dalla sua fatica; così come non resta che il segno della sottrazione e della perdita nella protagonista di “Mal vu, mal dit” di Beckett “trasmutata in pietra davanti alla notte”, e di scavo vivono anche le filiformi figure di Giacometti: tutte indistintamente figlie di una diversa, eppure accomunante, erosione del corpo e dell’anima in uno sfinimento senza possibile riscatto. C’é un comune lessico dell’abbandono nelle cui variazioni si ritrovano le parole del distacco, che in Amelia Rosselli descrivono “quasi una deportazione dell’anima”, e inseguono il “viaggio oltre la polvere” di Nelly Sachs, che insieme alle altre voci ebraiche di Getrud Kolmar, Etty Hillesum, Ottla Kafka costituiscono “l’onore del Novecento”, come scrive Anedda e “il prestigio del bene” come disse Simone Weil. La poesia non vive solo di atmosfere rarefatte e di materialità sublimate, ci sono versi che recano rumori e persino odori di cucine, di tepori domestici, di pentole in bollore: così é nei particolari messi a fuoco da Pasternak o dalla Achmatova, “fessure attraverso cui accogliere l’universale” – scrive Anedda; così é negli “Indizi terrestri” di Marina Cvetaeva, composti “non dopo, ma vicino al quotidiano”, sebbene la sua scrittura insegua “incandescenza di forma e pensiero”, un po’ come i colori che sfondano i confini della forma e si piegano alle correnti metropolitane, negli “Addii” di Umberto Boccioni. Ma, appunto, non di soli slanci procede il ritmo dei poeti: non quello di Wallace Stevens, sintonizzato sull’incedere incerto di un uomo già provato, i cui versi “coscientemente senili” sono scritti – dice Anedda – “dopo aver fissato bene la vanità”; né i versi di Celan che rinnegò le sue composizioni giovanili, né quelli di Kavafis nei quali risuona l’eco del suo “io non so sopportare”: versi consapevoli della loro irremediabile debolezza di fronte a un amore che si nega. Molte voci, troppe tra quelle convocate in questo libro, hanno scelto di tacere togliendosi la vita o lasciandosi morire: non ha senso azzardare una spiegazione, ma forse tra le pagine messe insieme da Anedda é legittimo cogliere un suggerimento: che esista un legame, talvolta troppo necessario, tra un corpo insidiato dalla morte e il linguaggio minacciato dal silenzio; come se la scelta di scrivere, essendo spesso prossima a un’ansia di totalità, rendesse meno tollerabile la percezione della propria finitudine.
– 06/08/1997
Prose di poetessa
Immagini nella luce livida della solitudine
Per le meritvoli edizioni Fazi di Roma, esce un libro abbastanza insolito nelle categorie correnti: si tratta di prose, dal titolo “Cosa sono gli anni”, e più specificatamente di prose lungo la linea e quasi nell’assolutezza delle prose dei poeti. Un libri insolito e sempre più raro, al punto che l’editore ha aggiunto un sottotitolo più discorsivo di saggi e racconti. L’autrice, Antonella Anedda Angioy, vive a Roma, proviene da una famiglia dell’aristocrazia sarda; ha pubblicato nel 1992 il libro di poesie “Residenze invernali” (nelle edizioni Crocetti). “Residenze invernali” e “Cosa sono gli anni” (con uno scatto di poetica) sono due titoli molto belli entro cui sembra definirsi, riconoscersi la presenza (la voce) di questa giovane figura. Sono titoli che entrano in una circolarità, in una reciproca relazione di poesia e prosa le quali diventano il segno e il sogno l’una dell’altra: il tempo e lo spazio, il presente e il passato, la bellezza e la vanità. Il punto originario della prosa, così come la intendiamo, nella sua imparagonabilità rispetto al racconto, al saggio, a un priori poetico, é l’assenza d’opera. La scrittura é possibile sullo sfondo di un’assenza di scrittura: fuori dalle categorie del linguaggio, non c’é che un mormorio ostinato che torna al silenzio di cui non si é mai linerato.Nella prosa introduttiva, “Senza recinti”, cade improvvisamente questo frammento: “Di ciò che ho letto e perfino tradotto non conservo quasi nulla. Come davanti all’amato, non é abbastanza o é troppo, come prima di un appuntamento, nello specchio non c’é che vuoto e un bagliore che é anche paura.” Scorriamo le pagine del libro avanti e indietro, lo annnotiamo di sottolineature, per ritornare sempre a questo punto, come alla cifra e all’originarietà di queste prose: la misura della scrittura e la dismisura della condizione irrapresentabile. Sono pagine, dice l’autrice, nate “nell’isola di un’isola”, scritte a memoria, con pochi libri, e ricontrollate poi a Roma nelle citazioni. Sono pagine dunque che si iscrivono in un tempo lungo, arcaico dove si adunano i segni, le tracce, le frasi più interiormente necessitate; dive ricorrono gli accenti essenziali, e forse ossessivi della parola. C’é un libro d’arte che ci attrae. E’ intitolato “Lettrici. Immagini della donna che legge nella pittura dell’Ottocento”. E’ una variante (la donna che legge) nella infinita raffigurazione femminile (la donna mentre si veste e si sveste, si lava e si specchia, sogna o dorme, mentre passeggia e conversa nei salotti, mentre lavora, mentre prega, mentre esibisce la sua bellezza o é ripiegata nell’affetto materno). Ma forse più affascinante é l’immagine della donna, senza libro, alla finestra: la nostalgia dell’assenza, di un’infelicità, l’interiorità di un tempo compatto, il luogo profondo dell’io, e quasi quella “luce rembrandtiana” di quotidiano mistero ( con un’espressione di Claudio Magris). Nell’immagine della donna senza libro, più che la storia di un linguaggio, amiamo l’archeologia di un silenzio. Le prose di questo libro dicono la vita, il senso unico e irripetibile di ogni volto, di ogni gesto, di ogni oggetto, di una pena senza nome, di una frase nella frase infinita; dicono la vita nella sua intensità che risplende dietro le parole, dietro le unità indefinite, dietro le formalizzazioni categoriali. E’ uno sguardo che, su una soglia oscillante, cerca la presenza sfuggente, tenta di ricondurla quale immagine: il tempo fitto e tramato dei libri passa attraverso le mute lettere di un alfabeto interiore. C’é l’epica degli scrittori russi, la voce della letteratura ebraica, l’orizzonte inesausto della letteratura femminile ( da Ingeborg Bachmann a Marianne Moore, da Hannah Arendt a Simone Weil, da Anna Achmatova a Marina Cvetaeva, da Amelia Rosselli a Cristina Campo, da Nelly Sachs a Gertrud Kolmar). Tutto é riportato a una cadenza di diario che non stringe l’atto della vita in una meditazione di racconto, o in un taglio critico; ma si congeda nello struggimento, nello sguardo di un incontro, nel “grigio spento” di un luogo, nella luce livida di una solitudine. Di questa scrittura primaria vorremmo sottolineare la connivenza con l’immagine. C’è nella scrittura il trascorrere dell’interiorità: l’immagine é quasi il tentativo di fissare l’atemporale, l’opacità che resiste. Il dire é portato a quella cifra di unità, dove la parola più che riassorbire il reale nel senso, riporta il senso nel respiro, nel “disegno della poesia” (Yves Bennefoy). Diventano così esemplarità di scrittura le “immagini” di Giotto, del Lotto, di Cézanne, di Klimt, di Albetro Giacometti; o il bellissimo racconto di Andrej Rubev: “Umili e regali, con le grandi ali colme di luce, i volti bruni leggermente inclinati, gli angeli della Trinità sostano alla mensa di Abramo nel sereno splendore di un miracolo domestico. Per dipingerli Rublev non dovrà che ricordare ciò che ha visto in quel giorno di pioggia: le tre creature stanche sedute a un tavolo sotto una tettoia, con i piedi incrociati e nudi, mentre in lontananza splendono i bagliori di una tempesta e lentamente cadono le prime gocce d’acqua”.
– 05/01/1997
Le sue tempie sugli anni
La necessità e il rischio della scrittura: pensare il mondo, andando in profondità
Non si può leggere d’un fiato questo libro di Antonella Anedda e poi metterlo sullo scaffale: occorre portarlo con sé, in tasca, nella borsa, tenerlo sul comodino alla sera. Perché é un libro senza trama, se non quella dell’esistenza stessa, vita il cui senso, ci sussurra l’autrice, a volte “si é mostrata nel miracolo del linguaggio”. E ancora: “Le parole condividono il destino delle cose…condividere il destino delle cose può riservare un castigo, una brutalità che investe solo chi pensa, chi scrive, chi si espone”. Così, stretta tra la necessità del pensare e del dire e i pericoli che questo comporta, Anedda compie un gesto d’ardimento ma senza alterigia: ci offre un’opportunità di condivisione, un percorso di personalissimi accostamenti, una possibilità di sosta che ha il brivido del paradosso rivelatore a fronte delle esistenze convulse che conduciamo: “non ho capito Marina Cvetaeva al mio tavolo, ma mentre facevo una fila”, racconta Anedda, “in una folla incrudelita dall’attesa”. il suo sguardo, che legge libri e mondo, e le vite dietro entrambi, si traduce in una parola nuda e bellissima che lascia spazio a chi l’ascolta: estrema rarefazione di un linguaggio distillato, senza sprechi. Parola poetica, si potrebbe dire, se ci si fermasse a coglierne “ i suoni…come punta estrema dei pensieri”. Parola del narrare di sé col/nel mondo, alla ricerca di quella finitezza, quella comprensione dell’essenziale, che sola può farci reggere il nostro essere mortali. O ancora – meglio – la ricerca di quel “varco dove poesia e prosa sognano l’una il sogno dell’altra”. Anedda traccia il suo territorio, nomina le figure con cui intesse il suo dialogo e ammette: “Questo é un libro di gratitudini e rapine”. Rapine: il “bottino” é un percorso che può portarci in poche frasi da Omero e Pasternak, dai grandi polacchi del Novecento – Hezrbert, Milosz e Szymborska – a Emily Dickinson e Marianne Moore, dalla Bibbia al Corano, da Mandel’stam a Paul Celan e poi Giotto, Cézanne, le foto della Seconda Guerra Mondiale, Primo Levi, Hetty Hillesum, Simone Weil e i russi, amatissimi, e Marina Cvetaeva, Anna Achmatova, Nelly Sachs, Costantino Kavafis. Perché scrivere implica saper “leggere”: “scrivere, cioè ascoltare, vedere e sull’udito, sullo sguardo, accatastare lavoro, contempla l’umiltà dell’errore, la fatica dell’errare”. Errare: nel territorio che occorre definire, ogni volta, a ogni nuova domanda. Il nucleo incandescente di queste domande si concentra nello scritto che dà il titolo al libro “Che cosa sono gli anni”: Anedda a questo nucleo si avvicina – e ci avvicina – per sentieri laterali, accostamenti progressivi che appaiono come il chiarore di una lampada spostata con la mano a gettare luce sugli angoli, i confini, le mura di una stanza, prima di essere posata sul tavolo e fermata per un po’: chi scrive – cioé “chi stende il suo rapporto sul mondo” – a volte coglie anche l’essenziale di una vita degna: “la necessità della modestia e il mistero del coraggio, la lotta da sostenere con se stessi per essere liberi, per essere profondi”. Ma poiché “la realtà non é tenace, ha bisogno della nostra protezione”, Anedda cerca quelle voci – molte ebraiche, molte di donne – che hanno nella poesia un “timbro materno”, voci che nelle situazioni estreme del dolore e dell’insensatezza siano capaci di far affiorare “la necessità, l’incrollabilità della protezione”. Non era stata proprio Simone Weil, ci ricorda, a dire che “l’onore del Novecento, “il prestigio del bene” é affidato a donne come queste?