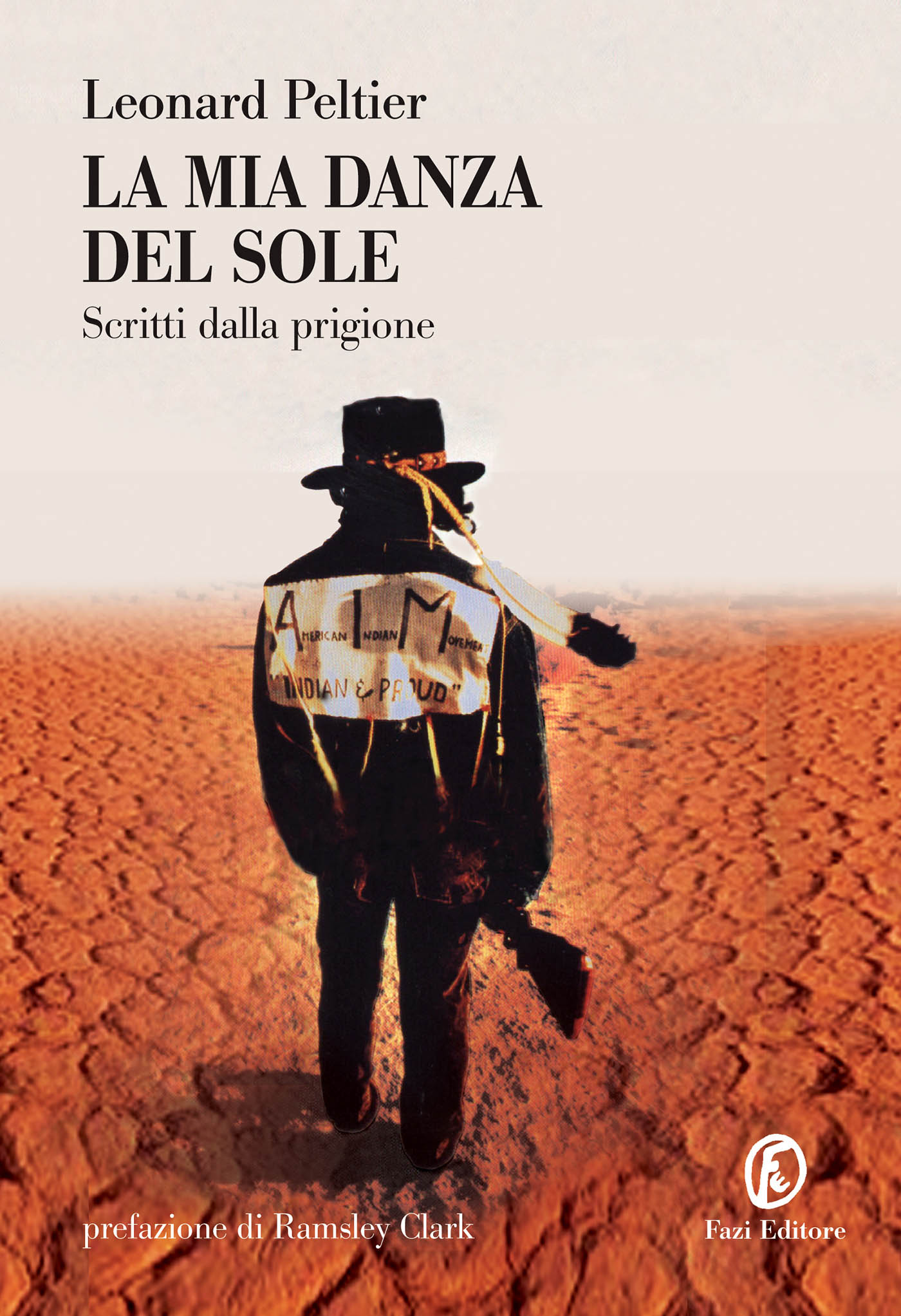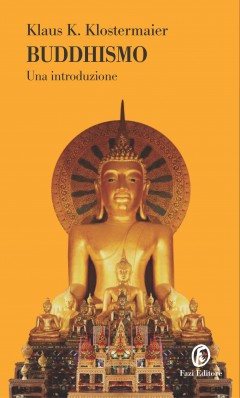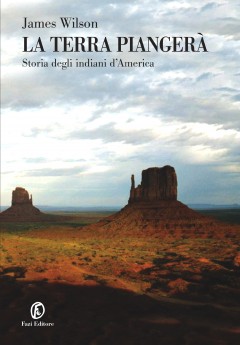Leonard Peltier
La mia danza del sole
Scritti dalla prigione
A cura di Harvey Arden
Traduzione di Giuliano Bottali e Sibilla Drisaldi
Prefazione di Ramsey Clark
Accusato ingiustamente dal governo americano – ricorrendo a strumenti legali, paralegali e illegali – dell’omicidio di due agenti dell’FBI nel 1975 (un breve resoconto tecnico della farsa giudiziaria è affidata all’ex ministro della giustizia degli Stati Uniti Ramsley Clark, autore della prefazione), Peltier, al tempo uno dei leader di spicco dell’American Indian Movement (AIM), marcisce in condizioni disumane in una prigione di massima sicurezza da quasi trent’anni. Nonostante la sua innocenza sia ormai unanimemente sostenuta dall’opinione pubblica mondiale, nonostante una campagna internazionale in suo favore che ha coinvolto il Dalai Lama, Nelson Mandela, il subcomandante Marcos, Desmond Tutu, Rigoberta Menchu, Robert Redford (che sulla vicenda di Peltier ha prodotto il documentario Incident at Oglala), Oliver Stone, Howard Zinn, Peter Matthiessen, il Parlamento europeo e Amnesty International, per il governo americano il caso del prigioniero 89637-132 è chiuso. Non sorprende dunque che Peltier sia divenuto un simbolo dell’oppressione di tutti i popoli indigeni del mondo e che la sua vicenda abbia ispirato libri (Nello spirito di Cavallo Pazzo di Peter Matthiessen), film (Cuore di tuono di Michael Apted, per esempio) e canzoni (i Rage Against the Machine hanno dedicato a lui la canzone Freedom). In parte lucidissimo manifesto politico, in parte toccante memoir, questa è la straordinaria storia della sua vita, raccontata per la prima volta da Peltier in persona. Una meravigliosa testimonianza spirituale e filosofica che rivela un modo di concepire la vita, ma soprattutto la politica, che trascende la dialettica tradizionale occidentale e i suoi schemi (amico-nemico, destra-sinistra e così via): i nativi la chiamano la danza del sole.
«Nel caso di Peltier si sono verificate enormi anomalie giudiziarie. Leonard Peltier è una persona piena di umanità e per questa regione io sarò accanto a tutti coloro che lo sostengono finché non lo vedremo libero».
Rigoberta Menchù
– 25/06/2005
Due ergastoli, una sola colpa: essere indiano
MOLTI UOMINI hanno trascorso buona parte della propria vita in prigio-ne senza colpa. In varie occasioni questo è accaduto per motivi po-litici. Uno degli esempi più cele-bri è quello di Nelson Mandela, figura centrale della lotta contro l’apartheid, che ha trascorso dietro le sbarre quasi 28 anni (agosto 1962-febbraio 1990). Un pe-riodo lunghissimo, ma che comunque non rappresenta un primato, perchè a Fort Leavenworth (Kansas) esiste un uo-mo che si trova in prigione da quasi trent’anni,. Stiamo parlando di Leonard Peltier, indiano anishinabe-lakota, che compirà 61 anni in settembre.
Il simbolo della lotta
.
Peltier è il simbolo vivente delle lotte in-diane odierne, ma il suo caso ha avuto una risonanza che va ben al di là di que-sto ambito. La revisione del suo caso è sta-ta invocata dai personaggi più diversi, da Desmond Tutu a Cristina del Belgio, da Rigoberta Menchù a Robert Redford. Quest’ultimo, in particolare, ha prodotto il documentario Incident at Orlala, dove il regista Michael Apted ha ricostruito la storia di Peltier.
L’attore americano ha sempre sostenu-to gli Indiani: non solo a livello politico, ma anche in termini culturali, tanto è ve-ro che il suo Sundance Film Festival ospi-ta una sezione dedicata ai registi indige-ni di tutto il mondo. Uno dei protagonisti della rivolta è Leonard Peltier, il cui nome è legato ad una lunga controversia giudiziaria. Leonard Peltier nasce nel 1944 nella riserva anishinabe di Turale Mountain (North Dakota). La sua famiglia è povera e conta ben 15 persone. All’età di otto anni viene strappato ai genitori e rinchiuso in una delle tante boarding schoo1s, i famigerati convitti istituiti nel 1879 c.on il proposito di “uccidere l’in-diano e salvare l’uomo”, secondo il mot-to coniato dal fondatore Richard Henry Pratt. Questa pratica ripugnante, alla qua-le forniscono un contributo determinan-te molti sacerdoti, è uno dei modi con i quali il governo federale cerca di assimilare le proprie minoranze indigene. Ter-minata la scuola Leonard si ricongiunge alla famiglia.
Turtle Mountain è una delle tre riserve–pilota che il governo federale ha scelto per sperimentare la termination po1icy con cui Eisenhower promuove l’inurba-mento degli indigeni e l’abolizione delle riserve. Nel 1968, anno centrale per tan-ti sommovimenti sociali del dopoguerra, anche gli Indiani si organizzano per lotte più radicali. In quell’anno nasce l’Ame-rican Indian Movement (Aim), animato da Dennis Banks e Russell Means. In po-chi anni il nuovo organismo si impone come il motore della nuova resistenza in-diana grazie ad alcune azioni dimostrati-ve, come l’occupazione dell’isola di Alcatraz, che si protrae per 18 mesi. L’atti-vismo continua negli anni successivi: nel 1972 l’ Aim organizza la marcia verso Washington nota come Trail of Broken Trea-ties (sentiero dei trattati infranti), per protestare contro il mancato rispetto dei 400 trattati sottoscritti dai coloni nel secolo precedente. Pochi mesi prima Leonard Peltier ha aderito all’Aim e si è trasferito nella riserva di Fine Ridge, dove lavora con Dennis Banks. È proprio qui che si svilupperà la lunga vicenda giudiziaria dell’attivista indiano.
Nel febbraio del 1973 trecento indiani, fra i quali Peltier, occupano il villaggio di Wounded Knee, situato nei pressi di Fine Ridge. Il luogo riveste un significato par-ticolare, perché è lo stesso dove si tenne il celebre massacro del 1890. La protesta degli occupanti è diretta contro la corru-zione dei capi tribali e contro la politica del Bureau of Indian Affaire. Questo en-te federale, che dovrebbe fornire assi-stenza economica alle riserve, in realtà le controlla e le conserva in condizioni de-gradate, mentre cerca di costringere gli In-diani a vendere la terra alle multinazio-nali minerarie. L’occupazione di Woun-ded Knee si protrae per 71 giorni e termi-na sanguinosamente con l’intervento del-l’esercito. Ma le violenze e gli abusi con-tinuano. Quando gli anziani della riserva chiedono la protezione dell’American In-dian Movement, Peltier si accampa nel ranch della famiglia Jumping Bull, pres-so Oglala, per poter controllare la situa-zione. Il 26 giugno 1975 due agenti del-l’Fbi irrompono nella riserva su una mac-china priva del contrassegno federale.
Ufficialmente stanno inseguendo un fur-gone perché sospettano che il conducen-te abbia rubato un paio di stivali. L’in-gresso dei due uomini scatena una spa-ratoria che richiama la presenza di nu-merosi agenti federali e poliziotti. Nel lungo scontro a fuoco fra l’Aim e le forze dell’ordine perdono la vita un indiano e i due agenti dell’Fbi. Peltier riesce a fug-gire insieme ad altre 20 persone. Qualche settimana dopo raggiunge il Canada, tro-vando rifugio in una comunità indiana si-tuata sulle Montagne Rocciose. Nel febbraio del 1976, l’attivista anishinabe-lako-ta viene catturato dalla polizia canadese. Alcuni giorni dopo, nella riserva di Pine Ridge, viene trovato il cadavere ormai decomposto di Anna Mae Aquash. Atti-vista dell’Aim,la donna aveva rifiutato di deporre il falso contro gli altri militanti, nonostante l’Fbi l’avesse minacciata di morte. Le circostanze del suo decesso non verranno mai chiarite.
Le memorie di un prigioniero politico
Nel giugno del 1977 Peltier viene con-dannato a due ergastoli: viene accusato di aver ucciso i due agenti dell’Fbi nel cor-so dello scontro a fuoco avvenuto a Pine Ridge. L’accusa si basa su una testimo-nianza poi ritrattata, ma nonostante que-sto la vicenda si trascina fino ai nostri giorni, caratterizzata dalla provata falsificazione delle prove a suo carico. Nel 2000 pareva che Clinton fosse intenzio-nato a firmare la grazia, ma l’intenzione non si è mai tradotta in pratica. Come tanti altri prigionieri politici, da Bobby Sands a Nelson Mandela, Leonard Peltier ha sentito il bisogno di raccontare la pro-pria storia al mondo esterno. Ne è uscito il libro La mia danza del sole (Fazi, Roma 2005), che Giuliano Bottali e Sibilla Dri-saldi hanno tradotto con sincera parteci-pazione umana.
La prefazione è firmata dall’avvocato Ramsey Clark, consulente di Peltier e ani-matore di tante battaglie legali che Wa-shington guarda con sospetto. Il libro si compone di 35 brevi capitoli nei quali l’autore concentra un’incredibile quantità di ricordi, riflessioni, idee. Ne emerge chiaramente l’immagine di un uomo for-te e sereno che 29 anni di prigione non so-no riusciti fiaccare minimamente. Peltier non dimentica di analizzare i contrasti so-ciali che attraversano la società statuni-tense: non solo quelli che toccano gli indiani, ma anche quelli che riguardano gli afroamericani e i latinos. Denuncia in modo pacato ma deciso il razzismo e l’in-tolleranza che segnano la federazione nordamericana: “Quando cresci indiano, impari in fretta che il cosiddetto Sogno Americano non è per te. Anzi, per te quel sogno è un incubo”. Merita un plauso l’editore Fazi, che non ha esitato a correda-re il volume con note di copertina dalle quali traspare una genuina partecipazio-ne alla tragedia umana di quest’indiano innocente.
– 05/06/1930
Sul sentiero di lacrime
– 01/07/2005
Fatti europei narrati in stile americano
I nostri giovani scrittori si stanno sempre più americanizzando. Non è una cosa riprovevole, a patto che si sappia quello che si fa, e soprattutto quello che si lascia. Per dirla tutta, la nostra tradizione. Forse è una tendenza inevitabile, e perfino inarrestabile. Ormai siamo tutti cittadini del mondo, non nel senso metafisico della parola ma proprio in senso geografico. Si viaggia molto, si visitano altre nazioni, altri popoli. Da questi viaggi nasce la voglia di raccontare. Spesso è un desiderio solo giornalistico, che lo scrittore scambia per vocazione. Ma, ripetiamo, la tendenza non è affatto da biasimare. All’Italia è sempre mancata una letteratura artigianale di buona fattura. Prendiamo questo romanzo di Fabio De Propris, Nero Istanbul. Sembra pronto per diventare una delle tante fiction che allietano (si fa per dire) le nostre serate televisive. Protagonisti di questo romanzo sono Franco e Ornella, marito e moglie. Lui è uno che consoce i misteri gaudiosi della finanza, ma ha dovuto abbassare le sue pretese. Lei è una insegnante di pianoforte a corto di clientela. Approfittando di un viaggio organizzato, si recano a Istanbul. Non hanno per niente intenzioni turistiche. Tutt’altro. Nella loro valigia c’è una sostanza proibita. Servirà per “comprare” un bambino destinato alle adozioni. Ma ecco che dal passato remoto spunta un tal Riccardo, che riconosce la coppia. Da questo momento tutto comincia a girare per il verso sbagliato, fino alla inevitabile punizione. Il romanzo di De Propris si fa leggere, è teso, ha scene drammatiche. Ma non parliamo di letteratura.
– 28/04/2005
Firenze, Kosovo, paure
All’ombra dei maestri anche sul fronte del thriller made in Italy continuano a emergere nuovi talenti. Ne segnaliamo tre che attestano con i loro ultimi romanzi di essere sul trampolino di lancio.
Il terzo giallista Fabio De Propris, 42 anni, romano, con Nero Istanbul (Fazi, 232 pagine, 14,50 euro) ci trascina in un intreccio ad alta tensione, seguendo le orme di una coppia in crisi che si accoda ad una comitiva di turisti tentando una spericolata scorciatoia verso la ricchezza.
– 09/06/2005
Le memorie di Peltier, capo sioux in carcere da trent’anni
Qualche giorno fa abbiamo intitolato, magari un po’ sommariamente, che “l’Occidente fa un po’ schifo”. E lo abbiamo fatto citando giustamente due episodi gravissimi: le violazioni dei diritti umani e della dignità dei detenuti commesse dagli Stati Uniti nella base cubana di Guantanamo, e la confessione di alcuni militari israeliani, colpevoli9 di aver ucciso a sangue freddo quindici poliziotti palestinesi, gesto che da ancora più ragione al recente atto di accusa di Edgar Morin contro l’ormai costante azione repressiva di Israele nei confronti delle popolazioni arabe. Ma l’occidente fa appunto, “schifo” da tempo, da secoli, dall’epoca delle Crociate fino alla Sacra Inquisizione, dallo sterminio delle popolazioni amerindie fino al colonialismo ottocentesco per finire alla guerra preventiva di Bush e Blair, che ha stracciato quel diritto internazionale che lo stesso Occidente si era dato dopo la Seconda guerra mondiale. Il libro di Leonard Peltier “La mia danza del sole. Scritti dalla prigione” (Fazi editore, pp. 207, euro 14.50) è l’ennesima conferma che i paesi occidentali sono stati in grado di darsi delle regole di civiltà valide solo per quelli che considerano essere i propri cittadini (ma anche in questo senso è in atto un’inversione di tendenza), mettendo ai margini tutti gli altri, uomini e donne di serie “B”. Peltier è uno di questi. La sua colpa è quello di essere stato, e di essere tuttora, uno dei capi del Movimento indiani americani, in carcere dal 1976, dunque da quasi trent’anni, con l’accusa di aver ucciso due poliziotti del’ Fbi, che il 26 giugno del 1975, all’interno di una vettura senza contrassegni, erano entrati a tutta velocità nella riserva indiana di Pine Ridge, fatta oggetto da anni di atti di violenza. Peltier si trovava lì insieme ad altri esponenti del movimento giunti sul luogo per aiutare la popolazione della riserva. Riuscì a fuggire dopo la sparatoria, ma l’anno dopo venne arrestato in Canada, estradato negli Usa e condannato in base a testimonianze che poi risulteranno false. Questo libro, pubblicato negli Stati Uniti nel 1999, è uscito dopo una grande campagna internazionale che ha coinvolto l’Onu, il Parlamento europeo, alcuni parlamenti nazionali, Amnesty International, personalità svariate come il Dalai Lama, Nelson Mndela, il subcomandante Marcos, madre Teresa, Desmond Tuto, Rigoberta Menchù, oliver Stone e Robert Redford, che sulla storia di Peltier ha realizzato il documentario Incident at Orlala, ovviamente finalizzata alla sua liberazione. Ma nella più grande democrazia del mondo, nata appunto sull’annientamento delle popolazioni autoctone, evidentemente non è possibile alcun ripensamento e dunque il caso può essere considerato chiuso.
Ma Peltier e chi si batte per la sua liberazione la pensano diversamente: “Sono ancora qui – scrive l’indiano sioux nelle sue memorie – E finche ci rimarrò, i miei amici e soci del Leonard Peltier Defence Committee (Comitato per la difesa di Leonard Peltier) continueranno a smuovere le coscienze, a raccogliere fondi e a coordinare campagne in mio nome, affinché l’America e il mondo non si dimentichino di me e del mio caso.”
Peltier parla anche delle motivazioni che lo hanno spinto a scrivere: “ho deciso che è arrivato per me il momento di scrivere, di mettere in parole il mio testamento personale – non tanto perché io abbia intenzione di morire ma perché ho intenzione di vivere. Questo è il ventitreesimo anno che passo in prigione per un crimine che non ho commesso. Ora ho poco più di cinquantaquattro anni. Sono qui da quando ne avevo trent’uno. Mi è stato detto che dovrei vivere due vite più sette anni prima di uscire di prigione nella data prevista per la mia scarcerazione: il 2041. Allora avrei novantasette anni. Non penso di farcela.”
Chi ha curato la prefazione del libro e, soprattutto, ha fatto da consulente legale a Peltier, è l’ex ministro della giustizia degli Stati Uniti Ramsey Clark: “Sono rattristato, afflitto e indignato che così tanti americani si siano dimenticati, o addirittura non abbiano mai saputo, chi è Peltier e cosa rappresenta.” Clark, noto per la sua avversione alle avventure militari del suo Paese e per la solidarietà espressa a suo tempo a Silvia Baraldini e Mumia Abu-jamal, quest’ultimo ancora in carcere, punta l’indice contro le modalità con le quali il processo è stato realizzato: “Tra le tante, troppe cose tenute nascoste in questo processo ingiusto in maniera allarmante – scrive Clark – (…) c’è la sconcertante violenza nella riserva di Pine Ridge, violenza che ha condotto direttamente agli eventi di quel giorno. Quella stessa violenza, diretta contro gli indiani tradizionalisti della riserva, che aveva già causato la più nota tragedia della vicina Wounded Knee, dopo l’assedio del 1973, ed era enormemente cresciuta tra il ’73 e il ’75.” Insomma l’America non è cambiata dai tempi del Far West e non è cambiata neanche adesso se è vero, come ha scritto recentemente su Repubblica Vittorio Zucconi, che al “pentimento” del repubblicano McCain sullo sterminio degli indiani ha fatto da contraltare la decisione di Bush di tagliare nella finanziaria 2005, 200 milioni di dollari di sovvenzioni alle tribù indigene. E intanto Peltier può anche aspettare il suo 97° compleanno.
– 03/06/2005
Amnesty e C: salvate l’indiano Leonard
“Mi chiamo Leonard Peltier. Sono un Lakota e vivo in un penitenziario degli Stati Uniti, la riserva indiana che cresce più velocemente in tutto il Paese”. Nella prima pagina del sito web “ufficiale”del detenuto appare un contatore che recita: 10.699 giorni, 22 ore, 15 minuti e 39 secondi di prigionia ingiusta. E 40 secondi. E 41. E 42… Il viso di Peltier sembra degno di un film western, di quelli politically correct, in cui i pellerossa fanno la parte dei buoni, e i visi pallidi sono massacratori.
Ma per la giustizia americana Peltier è un pericoloso assassino, responsabile della morte di due agenti dell’Fbi. E da quasi trent’anni dietro di lui si sono chiuse le porte del penitenziario di Leavenworth, in Kansas.
Non importa che contro la sua condanna si sia schierato l’intero movimento per i diritti umani, né che al suo fianco si siano mobilitate personalità di tutto il mondo. Per raccontare una versione ben diversa da quella ufficiale si è esposto anche l’ex ministro federale della Giustizia Ramsey Clark, che ha voluto firmare la prefazione al libro di Peltier, La mia danza del sole, ora pubblicato in Italia da Fazi.
Decondo Clark, quello passato alla storia come “L’incidente di Oglala”; in cui morirono i due agenti e un militante del movimento indiano, fu in realtà uno scontro cercato e calcolato dall’Amministrazione americana. Sullo sfondo c’è la repressione degli indigeni, che continua nonostante le revisioni storiche e i mille mea culpa governativi. Anche Clinton rifiutò, in uno degli ultimi atti prima di lasciare la presidenza, di concedere la grazia.
Peltier è sempre stato un militante “scomodo”, riottoso ad accettare la graduale emarginazione dei nativi americano e pronto a imbracciare le armi per difendere la sua comunità. A quel maledetto 26 giugno 1975 si era arrivati dopo ripetute provocazioni a danno di un nucleo indiano nella riserva di Pine Ridge. E Peltier, racconta Ramsey Clark, faceva parte della squadra di “autodifesa” che aveva risposto al grido d’aiuto dei residenti di Pine Ridge, tormentati da un gruppo paramilitare che si definiva Guardian della Nazione Oglala, Un gruppo che era stato rifornito di armi e incentivi dal governo Usa “per creare un ondata di violenza contro la popolazione indiana tradizionalista e i suoi sostenitori come l’American Indian Movement”, di cui Peltier era attivista.
“Si stava avvicinando la fine della guerra del Vietnam, ed erano anni di gran paranoia nei confronti di tutti i gruppi dissidenti” ricorda Ramsey Clark, rievocando anche una frase di Martin Luther king: “Il maggior fomentatore di violenza nel mondo è il mio stesso governo”. Insomma c’era chi per quel giorno aveva pianificato qualcosa, tanto che, secondo i documenti desecretati grazie al Freedom of Information Act, la legge che permette l’accesso agli atti governativi, l’Fbi aveva inviato gli agenti sul posto “prima” che qualcosa succedesse.
La dinamica dello scontro è controversa, in Rete anche i nemici di Peltier hanno pubblicato materiali a profusione: c’è una lunga dichiarazione sul perché m’uomo simbolo della lotta dei nativi americani “non deve essere scarcerato”, e c’è il fascicolo dell’Fbi con le accuse di omicidio e la ricostruzione dei fatti. Ricostruzione che Clark contesta, ed è in buona compagnia: al suo fianco lottano Amnesty Internetional, star di Hollywood, personalità come Nelson Mandela, Desmond Tutu, Rigoberta Menchu, il Dalai Lama.
L’arma che ha ucciso i due “federali”, Jack Coler e Ronald Williams, incaricati di rafforzare il controllo nella riserva di Pine Ridge, era quella di Peltier, dice l’accusa. No, le prove sono manipolate, le testimonianze false o costruite, i rilievi del laboratorio che avrebbero scagionato l’accusato sono stati distrutti intenzionalmente, replicano i sostenitori di quello che nel frattempo è diventato il detenuto numero 89637-132. A rendere la storia più drammatica c’è anche la circostanza che la riserva è poco lontano da Wounded Knee, teatro dell’ultimo massacro di “pellerossa”a opera del Settimo Cavalleggeri nel 1890.
Dopo il giorno della sparatoria nella riserva, Peltier è fuggito in Canada. Lì è stato arrestato ed estradato in Usa grazie alla testimonianza di Myrtle Poor Bear, una donna poi dichiarata mentalmente disturbata. E ora, quasi trent’anni dopo, è diventato un simbolo. Non solo per la lotta degli indiani d’America, ma anche per chi tiene duro quando tutto sembra perduto. Il prigioniero 89637-132 ha scelto la fuga attraverso la poesia, la letteratura ma anche la pittura. I suoi quadri sono figure tradizionali indiane: e sono diventati anch’essi un’icona della lotta contro l’oppressione.