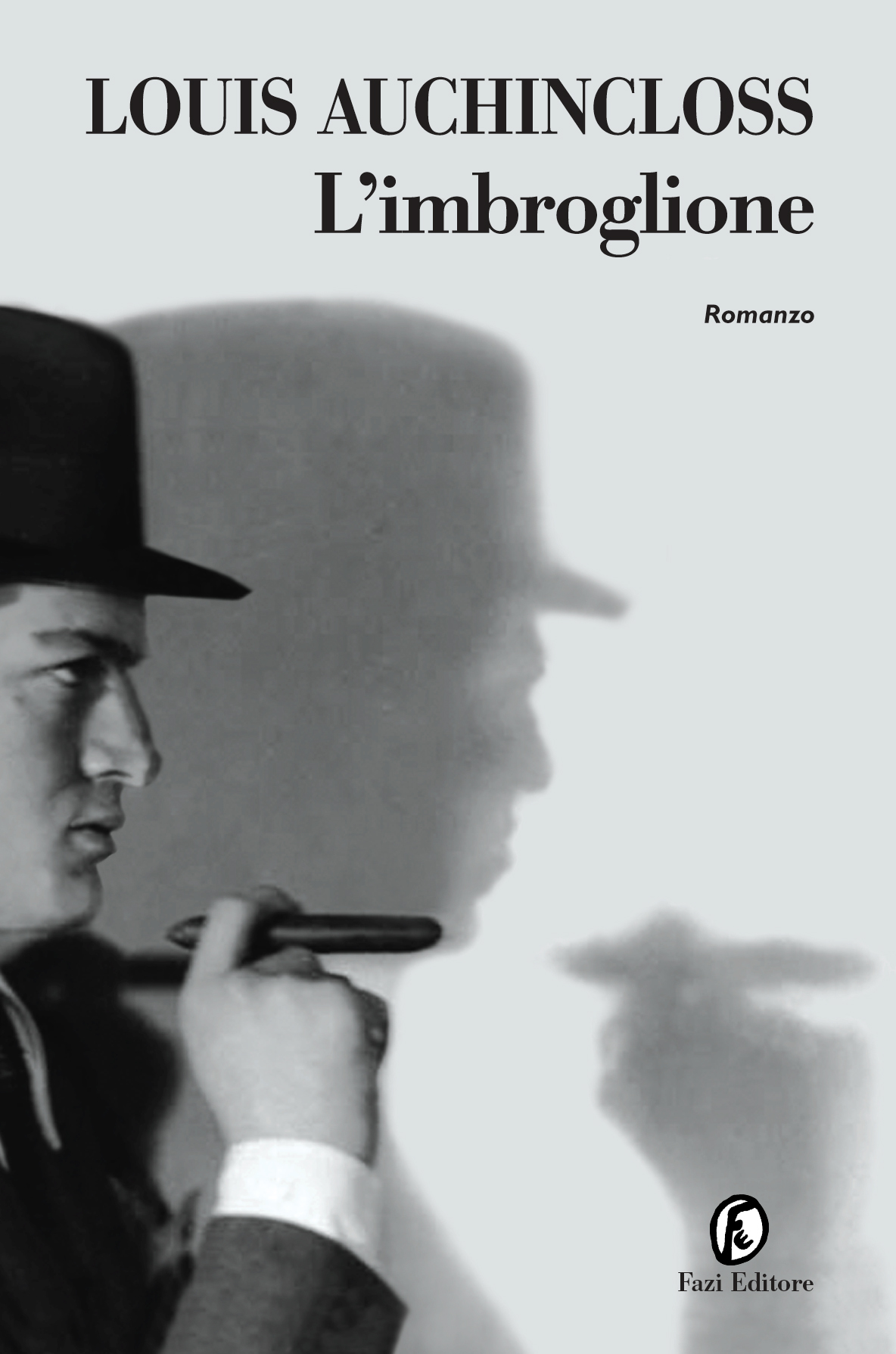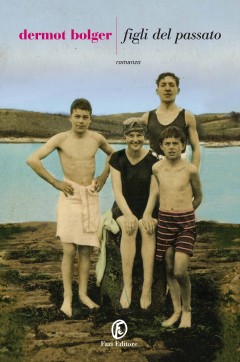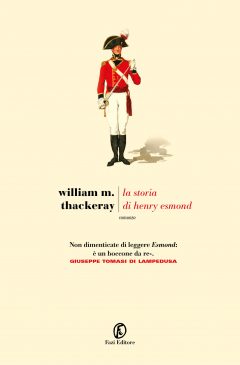
Louis Auchincloss
L’Imbroglione
Traduzione di Monica Pavani
Scritto nella forma di un racconto a tre voci che offre particolare forza e vivacità alle esperienze e ai ricordi dei protagonisti, L’imbroglione è una delle opere più significative – senza dubbio la più attuale – di Louis Auchincloss. Ambientata nella New York upper-class degli anni Venti e Trenta, tra belle ville, automobili di lusso e una morale discutibile, ma anche nella New York della Depressione e di una crisi che presto spazzerà via tutto un mondo – la vicenda ha il suo “eroe” in Guy Prime, giovane ambizioso e privo di scrupoli la cui fulminante ascesa economica e sociale si concluderà di fronte a un tribunale con l’accusa di appropriazione indebita. Un truffatore, insomma. Ma anche, e soprattutto, un “eroe” del nostro tempo. Nell’apologia di se stesso che Guy fa in una sorta di diario da trasmettere ai posteri – nel suo mettere in rilievo la contraddizione tra le severe regole della giustizia e i criteri morali più blandi ma di gran lunga più praticati, ostentati e quindi favoriti dalla società, nel perseguire a ogni costo il successo approfittando di qualunque mezzo il mondo finanziario e quello delle relazioni sociali, e perfino sessuali, mettano a disposizione – non è difficile scorgere un parallelo con certe avventurose ascese e cadute dei nostri giorni.
– 14/09/2003
Imbrogli di qualità
Innanzitutto un consiglio per godersi davvero L’imbroglione. Saltate le prime 28 pagine e andate a pagina 29. Cominciate dal primo capoverso, quando il protagonista spiega chi è George Greer, il suo futuro genero. Se l’autore avesse avuto un bravo editor, avrebbe cominciato di lì. Non capite molto? Non importa, due pagine dopo capirete tutto e vi sarete risparmiati l’inizio. Che ovviamente non va buttato via, ma letto e gustato dopo la fine. Perché è un romanzo molto piacevole e, se si rispetta questo piccolo accorgimento, lo si legge tutto d’un fiato. La “saltabilità” è un privilegio dei buoni libri. Chi di noi non ha saltellato tra le pagine di Guerra e Pace per poi gustarsi vent’anni dopo quelle che aveva tralasciato?
Anche Auchincloss ha diritto a questo privilegio. Infatti non è solo una bella storia, ma anche una testimonianza, perché l’impronunciabile Auchincloss è nato nel 1917 e quindi era nell’età più impressionabile quando ha assistito al naufragio di un mondo, quello dell’alta finanza di New York.
Di lui sappiamo solo quel che ci dice il rovescio di copertina. Che cioè ha fatto il legale per molti anni “entrando in contatto con quel mondo dell’alta borghesia e della grande finanza che ha ritratto così vividamente nei suoi romanzi e racconti di costume”. Ha scritto più di cinquanta volumi e la cosa ci fa piacere, perché le buone letture sono sempre troppo poche. Sarà vero, come dice il “New York Times” che Auchincloss è “l’erede indiscusso dell’enclave letteraria tracciata dalla gran dama delle lettere americane: Edith Wharton? “. Non lo so, ma non mi sembra così importante. La frase sembra poi pomposamente démodée. Ha il tono falso della conversazione di uno dei personaggi minori della storia, la povera, pretenziosa Bertha.
Certo, i richiami al romanzo fin-de-siècle e all’intelligencija del primo Novecento sono molteplici, ma sempre ironici. L’eroe, Guy Prime, frequenta a Parigi la casa di Paul Bourget, mediocre romanziere di successo di fine Ottocento. Il padre di Guy, specifica, gli aveva fornito il materiale per il suo romanzo sull’America, Outre Mer. E’ lì che incontra la madre della sua futura sposa, la signora Hyde, caricatura della dama colta dell’alta società statunitense dell’epoca. Ma questo lo si capirà solo molte pagine dopo, perché L’imbroglione ha una struttura straordinariamente moderna. E’ composto infatti di tre parti, di tre versioni diverse degli stessi avvenimenti, il cui senso viene di volta in volta dilatato, rovesciato e svelato dalle prospettive dei tre personaggi che si succedono: Guy, un finanziere fallito, Angelica, sua moglie e Rex, un banchiere amico di lui e amante di lei.
Il risultato è davvero gradevole in questo momento storico in cui assaporiamo particolarmente la possibilità di considerare la realtà da diversi punti di vista, apprezzandone, senza giudicare, la ricchezza. La relatività nei romanzi e nei film è sempre un ottimo segno, alla faccia di chi vuole identificarla come sintomo di vacillamento dei famosi valori. Perché la relatività è un valore in sé, una forma di conoscenza e di rispetto.
– 07/12/2003
Un anno a Wall Street
Non c’è nulla di più volgare dello snobismo americano.Esso raggiunge vertici di incongruenza, dando in pasto – per un po’ di raffinatezza presunta e importata – tutto l’impeto della schiettezza della nuova civiltà. Per questo può capitare che taluni autori americani sembrino agli europei dei sempliciotti con una potenza epica da loro perduta. La barbarie, se non altro, è insediamento di impulsi primari. Ben vengano i denigratori come Louis Auchincloss (un anno travestito da snob amato da Gore Vidal), gli eretici dell’”american dream”, anche perché ormai scarseggiano. Ora Fazi manda in libreria il primo romanzo di un’opera che conta una cinquantina di libri fra narrativa, critica, storia e biografie: L’imbroglione (trad. di Monica Pavani, pp. 320, euro 16,50). E’ uscito in America nel 1966, ma colma una lacuna importante verso un autore da noi pressoché sconosciuto.
In certi libri, la vita sembra chiara. E’ complicatissimo, a volte, il modo con cui gli uomini collidono con essa. Ma la struttura è cristallina. L’imbroglione è uno di questi libri. Protocollo dello scrittore naturalistico, cui Auchincloss si attiene scrupolosamente, è la trama delle trame: il denaro. Non è un culto, forse, ma una denuncia. Tuttavia, come capita sovente, il furore accusatorio non permette a chi lo pratica di emendarsi pienamente dai vizi di chi è alla gogna. Talché l’ostensione della miseria umana finisce con l’immiserire anche l’indicante. Niente di tutto ciò è più lontano da un’”età dell’ innocenza” di cui – con Edith Wharton – vorrebbe parlarci Auchincloss. Nel romanzo sembra esistere soltanto la finanza di Wall Street. Scopo e confine di ogni gesto umano, l’acme del mondo capitalistico rende la letteratura uno scialbo accidente. Il romanzo è un campo aperto in cui ha luogo la lotta delle furie. Le Erinni della finanza si strappano la carne di dosso vicendevolmente. Non è questa una poetica come un’altra? Ma Auchincloss ha in serbo delle sorprese: il libro è diviso in tre parti e i colpi di scena più significativi sono proprio l’attacco della seconda e della terza parte. Alla fine della prima parte L’imbroglione può essere considerato un buon romanzo di impronta naturalistica ad impianto ottocentesco: talento e perspicuità nel delineare personaggi e situazioni, piacere della lettura. Poi inizia, strutturalmente, un’altra cosa, una sorta di Rashomon delle azioni umane incrociate alle azioni di borsa, narrazione a tre voci dei personaggi principali, in cui Guy Prime, l’imbroglione, viene sorpassato dalla sua stessa storia, perché “il ventesimo secolo si è mosso più velocemente dei suoi concittadini”. Ma il suo tracollo è ben congegnato: “Questo è l’inferno del mercato: qualsiasi cosa lo influenza, e le menzogne più di tutto”. Resta da chiedersi: la mente americana è sempre a “ispirazione binaria”, come la logica dei computer di silicon Valley? Dei tanti che non sono riusciti ad essere “numeri uno” che ne è? Riparano tutti a Panama, come Guy Prime, trangugiando gin di nascosto dalla giovane moglie Carmela?
– 30/05/2003
L’America di Auchincloss
Chi ama i racconti di Edith Wharton ne ritroverà qui alcuni personaggi e certe atmosfere. Osservazione che nulla toglie all’originalità dell’autore e alla sua capacità di costruire un meccanismo narrativo molto originale. Parlo de L’imbroglione, di Louis Auchincloss, scrittore nato nello stato di New York (1917) finora inedito in Italia.
La vicenda, che abbraccia parecchi decenni, gira attorno alla figura di Guy Prime. Siamo a New York negli anni che precedono la grande depressione del ’29. La città si avvia a diventare la capitale del mondo capitalistico, presto del mondo tout court. Nere limousine si fermano davanti alle scintillanti porte girevoli dei grandi alberghi. Ne scendono dame ingioiellate, odorose di profumo francese, signori con smoking capaci di nascondere ogni difetto con il loro taglio, ambienti in cui aleggia costante l’odore di denaro. Soprattutto di questo infatti si tratta: denaro. Conosciamo Guy negli anni di Harvard. Un ragazzo ricco, ambizioso, senza scrupoli, studia con facilità il tanto che basta. Il suo amico inseparabile è Rex, di famiglia umile, viene dalla provincia, passa le giornate chino sui libri. Tra i due avviene uno scambio che salda l’amicizia e aiuterà entrambi a entrare nella vita. A un certo punto però l’ascesa di Guy nel mondo della finanza finisce davanti a un tribunale cin l’accusa di frode (titolo originale The Embezzler, il malversatore). Guy si è appropriato di certi fondi sociali che doveva tenere in garanzia; richiesto di esibirli, deve chiedere aiuto al vecchio amico Rex. Intanto però Rex è diventato l’amante di Angelica, moglie di Guy. Il che complica ovviamente le cose.
Ho dato appena un’idea dell’intreccio che è notevole (reso perfettamente dalla traduzione di Monica Pavani) ma è altrettanto importante l’atmosfera nella quale le vicende si svolgono. Affiora alla mente del lettore il nome di Francis Scott Fitzgerald: l’Europa vista dai boulevard di Parigi o di Londra, da uno yacht in crociera verso le isole della Grecia; poi le ville toscane, la costa azzurra, Biarritz. Un’epoca che finisce con la Depressione e la necessità di dare alla Borsa regolamenti più severi ma anche, nella nostra vicenda, con la rovina di Guy, costretto a fuggire a Panama per evitare il carcere.
Con una curiosa struttura, la storia è raccontata tre volte secondo la prospettiva di ognuno dei tre protagonisti. Guy, Rex, e Angelica si mettono a nudo confessando al lettore speranze e fallimenti, gioie e miserie. Se cercavate un buon romanzo di grande tenuta l’avete trovato.
– 14/04/2003
Storia dell’American way tra soldi e corruzione
Sulla New York Review of Books Gore Vidal scrisse: Auchincloss “è il solo che ci racconti come i nostri governanti si comportano nelle banche e nei consigli di amministrazione, negli studi legali e nei club”. Classe 1917, avvocato di professione e scrittore per diletto di più di cinquanta opere, Louis Auchincloss è uno straordinario cronista “di costume”, l’erede più accreditato di Edith Wharton, l’esploratore del mondo, delle vite, delle scelte morali dei Wasp con i soldi di New York.
L’imbroglione (The Embezzler, 1966) è uno dei suoi romanzi più celebri, il racconto a tre voci della resistibile ascesa di Guy Prime, dagli studi a Harvard all’entrata nel mondo della finanza di Wall Street sino allo scandalo che mette fine al suo matrimonio e alla sua posizione sociale. Narratore “sociale”, attento alle scelte morali dei suoi protagonisti, Auchincloss è anche un abilissimo costruttore di trame: la critica sociale non rallenta mai il racconto e lo sviluppo psicologico dei caratteri.
Tra vecchi domestici e vecchie zitelle, patrimoni ereditati e capitali conquistati, università Ivy League e salottini per il tè, Auchincloss (ancora in attività oggi, l’anno scorso ha pubblicato una serie di racconti che vanno da Teddy Roosevelt all’era Clinton) racconta il potere corruttore dei soldi e traccia la storia dell’American way in materia di soldi, sesso e portafoglio.
– 03/04/2003
L’imbroglione
Con in suo incipit fulminante (“Ho l’onore di essere diventato una leggenda durante la mia vita, ma non in modo molto edificante”) è finalmente in Italia (fu scritto nel ’65) il primo romanzo di Auchincloss, scrittore e avvocato dell'”upper class” newyorkese. La storia amara di guy Prime, affarista con pochi scrupoli passato dalle glorie della finanza alla fuga, è narrata da tre diari paralleli: quello di Guy, della sua ex moglie e di un suo (ex) amico. Da una utore raffinato, apprezzato persino da Gore Vidal, uno spaccato dell’America anni Venti che ricorda tanto quella di oggi.
– 01/02/2003
L’imbroglione
New York anni Venti: tra ville e automobili di lusso, Guy Prime, giovane privo di scrupoli, tenta una fulminante ascesa economica e sociale. Che si concluderà in tribunale con l’accusa di appropriazione indebita. Un truffatore, insomma, che persegue il successo attraverso il mondo finanziario, delle relazioni sociali e perfino sessuali. L’autore, che ha alle spalle oltre 50 scritti, è un avvocato dell’alta borghesia e della grande finanza americana.
– 15/02/2003
«L´imbroglione» ovvero l´arte di arricchirsi senza scrupoli
In L´imbroglione, il romanzo più raffinato e scattante del prolifico Louis Auchincloss – un romanzo o un volume di racconti all´anno partendo dal `47, senza contare raccolte di saggi e biografie – i tre personaggi chiave narrano le loro storie incrociate in una sorta di memoriali. Si tratta di Guy Prime, Rex Geer e di Angelica, moglie di Guy. Nipote di un vescovo episcopale, con studi a Harvard, Guy entra giovane nel mondo della finanza di Wall Street, analogamente al suo vecchio compagno di scuola Rex, figlio di un parroco di campagna della Nuova Inghilterra. L´arte di fare soldi domina la vita dei due e costituisce uno dei temi centrali nella narrativa di Auchincloss.
I personaggi, scrivendo agli inizi degli Anni Sessanta, evocano il momento scottante di circa venticinque anni prima, al culmine del New Deal rooseveltiano, e Guy ricorda sin dalle prime pagine lo scandalo che lo aveva coinvolto, il processo, la condanna, «ridotto a una paria perché faceva comodo a un bel po´ di persone». Guy è dunque il capro espiatorio di un mondo senza scrupoli, ma scatta qui l´altra faccia del romanzo, per così dire il filone di costume alla Henry James. Se Guy ha praticato l´appropriazione indebita, facendosi prestare forti somme da Rex per sostenere le sue avventurose operazioni, lo ha fatto anche perché la moglie Angelica, donna elegante, educata in Europa, aveva cominciato a tradirlo con l´amico, e l´inganno si era per così dire diffuso, facendo cadere in lui quel tanto di fede nei valori, nelle categorie morali, un tempo radicati e praticati. Sapremo dalle parole di Rex che Guy, scontata la condanna, è morto di ictus nel `62 a Panama dove si è ritirato, e da Angelica che, divorziata, ha sposato Rex da ormai quattordici anni, ancora amore e danaro.
Il beffardo, e se si vuole moralista Auchincloss, ci offre nel suo stile terso e irresistibile una favola moderna che esplora senza indulgenza l´ambiguità dell´esercizio del potere.
– 15/02/2003
L’imbroglione, ovvero l´arte di arricchirsi senza scrupoli
In L´imbroglione, il romanzo più raffinato e scattante del prolifico Louis Auchincloss – un romanzo o un volume di racconti all´anno partendo dal `47, senza contare raccolte di saggi e biografie – i tre personaggi chiave narrano le loro storie incrociate in una sorta di memoriali. Si tratta di Guy Prime, Rex Geer e di Angelica, moglie di Guy. Nipote di un vescovo episcopale, con studi a Harvard, Guy entra giovane nel mondo della finanza di Wall Street, analogamente al suo vecchio compagno di scuola Rex, figlio di un parroco di campagna della Nuova Inghilterra. L´arte di fare soldi domina la vita dei due e costituisce uno dei temi centrali nella narrativa di Auchincloss.
I personaggi, scrivendo agli inizi degli Anni Sessanta, evocano il momento scottante di circa venticinque anni prima, al culmine del New Deal rooseveltiano, e Guy ricorda sin dalle prime pagine lo scandalo che lo aveva coinvolto, il processo, la condanna, «ridotto a una paria perché faceva comodo a un bel po´ di persone». Guy è dunque il capro espiatorio di un mondo senza scrupoli, ma scatta qui l´altra faccia del romanzo, per così dire il filone di costume alla Henry James. Se Guy ha praticato l´appropriazione indebita, facendosi prestare forti somme da Rex per sostenere le sue avventurose operazioni, lo ha fatto anche perché la moglie Angelica, donna elegante, educata in Europa, aveva cominciato a tradirlo con l´amico, e l´inganno si era per così dire diffuso, facendo cadere in lui quel tanto di fede nei valori, nelle categorie morali, un tempo radicati e praticati.
Sapremo dalle parole di Rex che Guy, scontata la condanna, è morto di ictus nel `62 a Panama dove si è ritirato, e da Angelica che, divorziata, ha sposato Rex da ormai quattordici anni, ancora amore e danaro. Il beffardo, e se si vuole moralista Auchincloss, ci offre nel suo stile terso e irresistibile una favola moderna che esplora senza indulgenza l´ambiguità dell´esercizio del potere.
– 01/09/2002
America’s Aristocrat
It sometimes seems these days that Louis Auchincloss has been turned into a living museum piece, one of those elderly Olympians doomed to be fêted rather than read. He is president of the American Academy of Arts and Letters, an office that indicates the esteem in which he is held by his fellow writers and critics, and admiring voices seem always on hand to remind us that he is our “most distinguished and versatile man of letters” (James Tuttleton) or to hail him for the millionth time as the heir to Henry James and Edith Wharton. His acknowledged masterpiece, The Rector of Justin, is now available in an appealing new Modern Library edition, complete with a preface in which the series editors have assembled, from the yellowing pages of the daily press and the literary quarterlies, five decades worth of encomia to Auchincloss and his work.
But his new books, products of an astonishingly prolific ninth decade, issue forth into a resounding critical silence and quickly fall out of print. Changes in the exterior design of his books hint at his publishers’ declining estimate of his mass-market appeal: the 1950s Signet paperback edition of A Law for the Lion displays a lurid cover with the words “Behind the flaming headlines of a society divorce!” emblazoned across the top, but his recent books arrive in muted, tastefully world-weary covers whose designs usually involve reproductions of French or Italian painting. Loyal readers of Auchincloss have become resignedly accustomed to finding Jane Austen right after Margaret Atwood in the fiction sections of the chain bookstores. Indeed, most of his fifty-five or so books can now be acquired only by the most recondite of means (Episcopal church rummage sales are often a good bet.). Here at Yale, Auchincloss’s alma mater and the setting of much of his fiction, many of his novels have been banished to the Linonian and Brothers Reading Room (“the Green Room”), there to repose in drowsy Ozymandian splendor with the works of James Gould Cozzens and Dorothy Canfield Fisher.
This nimbus of reverent neglect threatens to obscure a body of work that is in many ways unique in American fiction. Auchincloss knows his chosen territory–the inner and outer lives of WASPy old-money New Yorkers–better than any author since Wharton, with whom he has, inexorably, been compared since the start of his career. But, though Auchincloss shares deep artistic affinities with Wharton, his vantage point is in several particulars diametrically opposite: perhaps most strikingly, he has remained in New York virtually his entire life, and thus gained a perspective on the city’s social and economic life that is simultaneously more viscerally sympathetic and more discerningly critical than that of his expatriate predecessor.
Born in 1917 into a moderately wealthy and extraordinarily well-connected and pedigreed New York family of remote Scottish extraction, Auchincloss grew up in quasi-tribal Old Guard Manhattan; the dense and tangled connections of blood and friendship that made the bustling and fast-growing New York of this era seem a closed and hierarchical small town to those born into its established elite provide a contextual backdrop for virtually all of his fiction. After Groton, Yale, law school at Virginia, and the Navy, he settled into a dual career as a writer and a partner in the trusts and estates department of a Wall Street law firm, where he worked until his 1986 retirement.
Auchincloss’s intimate professional familiarity with the byzantine legal conduits through which money is funneled from one generation to the next has left its mark on his fiction; his plots often hinge on the probating of a will or the withdrawal of principal from a trust. Ample and recurrent attention is paid to the dilemmas in which the wealthy find themselves when the time arrives to make testamentary arrangements for the disposition and distribution of their lucre. Such situations are, of course, the stuff of which daytime TV drama is made, but in Auchincloss’s work we are made to see that questions of inheritance are at bottom questions of in what form and to what degree the past is to be made real and present in our lives. He examines the fate of houses, art collections, and fortunes that have outlived their creators as a way of illuminating, on an individual and familial scale, the inconspicuous mechanics of cultural continuity and the inevitability of the disruption, for good or ill, of that continuity.
Auchincloss’s body of work is steeped in awareness of the past, filled with characters who, in a manner strikingly at odds with the cheerful indifference to history supposedly typical of our youthful land, face backwards rather than forwards. In a collection of Auchincloss stories one can expect to encounter at least one architectural preservationist, several collectors of decidedly non-contemporary fine or decorative art, probably an amateur social historian or two, and usually an elderly man or woman dedicated to guarding the memory of a parent misunderstood or forgotten by the outside world (Edith Stirling of “Stirling’s Folly,” one of the best stories in the excellent 1967 collection Tales of Manhattan, is a prime example of this last type). Auchincloss was president for many years of the Museum of the City of New York and wrote in that context that “if the past is to be saved at all in our cannibal city, which eats itself every generation, it can only be in a museum.” Or, one might add, in Auchincloss’s own fiction, a sort of written museum in which the domestic architecture and interior décor of what one character calls “the great bygone century” are characters in their own right, like the crumbling mansion in which Augusta Millinder, narrator of The House of Five Talents and historian of her Vanderbilt-esque family, lives–a house that reminds her continually of a “a past that neither of us very much enjoyed but which has now become our most distinguishing characteristic.” Auchincloss characters are often conscious that the changes pushing their settled world into modernity mark a sort of liberation, but they are also haunted by a melancholy awareness of what has been lost: as Horace Havistock remarks in The Rector of Justin, “when a civilization crumbles, it all crumbles together… Roman virtue goes out with the Roman arena. Voltaire and Watteau with the lettre de cachet.”
Havistock’s choice of illustration is typical of Auchincloss; his eagerness to ground his fiction in a historical context often manifests itself in references to European art and literature. As a boy in New York and at Groton, he wrote in his autobiography A Writer’s Capital, “drama and romance lay to the east, across the Atlantic.” His characters share his affinity for Europe and especially France. Scarcely a page of his fiction goes by without a reference to the Duc de Saint-Simon or Madame de Sévigné, Fragonard or Greuze or David. “Hephaestus,” in the 1992 story collection False Gods, culminates in a society dowager’s impassioned recitation of a long speech from Racine’s Phèdre. Bankers and Wall Street lawyers who hold forth learnedly on French academic painting are plentiful. A Writer’s Capital is primarily concerned with Auchincloss’s early struggle to balance his desire to write with the pressure he felt to enter what he then conceived of as the “real world, the man’s world” of the law, a struggle to reconcile the world of his cultured mother on the one hand, the realm of arts and letters in which he felt instinctively at home, and on the other hand what he labels in his memoir “the dark dull sea of American male life.” His Crébillon-reading stockbrokers represent, like Auchincloss’s dual career, an attempt to bridge the gulf between the “masculine” and the “feminine,” between commerce and art. Auchincloss’s tendency to associate women with artistic creativity perhaps accounts for the frequency with which his novels take women as their protagonists; from A Law for the Lion, which depicts socialite Eloise Dilworth’s divorce from her unfeeling husband and her consequent ostracism, to 2000’s Her Infinite Variety, which follows Clara Hoyt, daughter of a Yale college master, as she rises from New Haven obscurity through several marriages and her own considerable ingenuity to command a publishing empire, Auchincloss’s novels constitute an admiring chronicle of the ways in which the women of pre-feminist Old New York were able to achieve some measure of autonomy and, indeed, to take a central place in the city’s cultural and artistic life.
While Auchincloss writes with a warmth and imaginative sympathy often lacking in the work of writers with whom he is frequently compared, including John P. Marquand and certainly John O’Hara, his artistic control can seem shaky at times, particularly in his later work. As his usually admiring authorized biographer, Carol Gelderman, notes in her Louis Auchincloss: A Writer’s Life:
A perfunctoriness of treatment has marked much of the recent work… An impatience to fill [these books] out results in a thinness, a two-dimensionality. This speed affects dialogue, too. Too many characters speak like Louis Auchincloss, full of literary allusions, witty anecdotes, and old-fashioned expressions.. characters, too get compressed treatment, so that they sometimes lack flesh and blood.
But even the novels of Auchincloss’s most successful period, the years in the early 1960s when he produced Portrait in Brownstone and The Rector of Justin, are marred by transparently expository dialogue and adverb-laden prose: characters always seem to “reply testily” and “demand heatedly.”
These defects are a small price to pay, however, for the delights of Auchincloss’s authorial presence. In the introduction to Reflections of a Jacobite, a book of his critical essays which, as their collective title suggests, take as their “starting point and …common denominator” the literary criticism of Henry James, Auchincloss writes that James shows himself in his remarks on literature “a kindly guide of infinitely good manners, who is also infinitely discerning, tasteful, and conscientious.” The description is remarkably applicable to the manner in which Auchincloss himself guides us through literature and through life. Gore Vidal noted in his insightful and influential 1974 essay “The Great World and Louis Auchincloss” that “his kind of revelation demands a certain obliqueness, a moral complexity which cannot be rendered in the confessional tone that marks so much of current American fiction.” The consistency, across so many books, with which he has eschewed obtrusive self-indulgence is indeed remarkable. His heart, as a writer of fiction and especially as a literary critic, is always with the bypassed, the unjustly forgotten, the underrated. Auchincloss, Vidal writes, “has made a brave effort to create his own literary tradition–a private oasis in the cactus land of American letters.”
The critical consensus seems to be that Auchincloss’s novels and stories belong, as Newsday once remarked, to “a line of descent that begins with [William Dean] Howells and James and numbers Wharton, Marquand, and O’Hara in its lineage,” that is, to the tradition of the American novel of manners. The writers enumerated share a commitment to examining, with varying levels of literary sophistication and moral imagination, the ways in which class and wealth shape mores. James excepted, they are at their best when illuminating the means by which economic pressures inform social and individual consciousness. Nowadays, when the phrase “fiction about the rich” is chiefly evocative of tiresomely sordid stories about Nembutal-popping Greenwich matrons, it can be startling to recall the extent to which the moral ramifications of wealth attracted the attention and the thought of our best writers. Howells and Wharton, in different ways, took as their subject the convulsive consequences for the Eastern upper class of America’s transition from a sedate agrarian commonwealth to a nation flush with new industrial and commercial wealth: the fates of Julius Beaufort in Wharton’s New York and of Silas Lapham in Howells’s Boston make readily apprehensible, on the level of individual lives, the collision between the old order and the new.
But the few decades spanning the turn of the century were perhaps unique in the scope they afforded this sort of novel. As the Boston patrician Bromfield Corey tells his son Tom in The Rise of Silas Lapham, “Money is to the fore now. It is the romance, the poetry of your age. It’s the thing that chiefly strikes the imagination.” The period between the Civil War and the First World War offers, in the starkness with which the sinews of capitalism reveal themselves and in the magnitude of the accompanying social dislocation and disorientation, opportunities for the novelist of manners that cannot be matched in our era of savvy public relations and discreet offshore trusts: it is not an accident that the most compelling of Auchincloss’s family-chronicle novels, The House of Five Talents, is set primarily at the turn of the century and is based loosely on the story of the Vanderbilt clan. Auchincloss addressed the special problems the post-Gilded Age posed for the social novel in a 1961 essay on Marquand and O’Hara, “The Novelist of Manners Today.” The two writers under discussion had enjoyed great critical and popular esteem for the previous thirty years: Marquand’s The Late George Apley, an affecting if not particularly subtle “biography” of a Boston Brahmin hollowed out by rigid conformity to the strictures of family and custom, had won the Pulitzer Prize in 1938, and O’Hara’s novels, which have since slid into well-deserved oblivion, were bestsellers in the 30s and 40s. But Auchincloss points out that an era in which class boundaries, although still painfully sharp, are demarcated chiefly by differences in the sort and quantity of consumer goods purchased offers the novelist of manners “thinner material than what the Victorian writers had to deal with.”
While Auchincloss has always been at some pains to distinguish his writing from that of Marquand and O’Hara–he writes with palpable irritation of “those critics who see in my work only a superfluous echo of John P. Marquand”–his estimate of the diminished power of the novel of manners in the twentieth century is not without bearing on his own oeuvre. Perhaps it is his awareness that the glory days of his chosen form have passed that has kept him from attempting a Vanity Fair, a panoramic and multi-plotted examination of his social territory. But then again, perhaps such a project would go against his artistic grain: “the nineteenth century,” he declared in an essay on Thackeray, “…could never match the subtlety of its predecessor.” Auchincloss has written appreciatively on writers of the nineteenth century from George Eliot to George Meredith and, of course, Henry James, but his intellectual temperament seems foreign to that turbulent Romantic time: transcendental religious experience, existential dread, the exaltation of passion over intellect–all the ingredients of the Romantic mal du siècle–are strangers to Auchincloss’s fiction. As one might surmise from the list of his nonfiction works, which includes books on Richelieu, on women at Versailles, and on Corneille and Racine and a long essay on Saint-Simon, his roots lie instead in the seventeenth and eighteenth centuries, in an age dominated, especially in France, by the neoclassical ideals of order, economy, and lucidity. It is these ideals that give shape to Auchincloss’s work, and he is indeed, as Hortense Calisher has observed, a “classicist” at heart. Perhaps, then, it is his close attachment to his intellectual antecedents that explains his declining popularity: each new book arrives like a time capsule from some forgotten epoch of grace and intelligence, awkwardly out of place in the world of Survivor and Wal-Mart, tract mansions and George W. Bush. But one suspects that Auchincloss might after all be happiest joining that class of writers with whom he has always seemed most intensely sympathetic, those whose half-forgotten books stand regally if dustily to one side, waiting to offer their riches to those who will seek them out.
– 15/10/1997
Intervista a Louis Auchincloss
La maggior parte della sua produzione tratta in qualche modo dell’upper class, senz’altro il tema centrale della sua carriera letteraria. Perché questa lunga fascinazione?
Se si osserva la letteratura nei secoli si nota che il novantacinque per cento di essa tratta della cosiddetta ‘upper class’, dall’Iliade all’Odissea fino a Shakespeare con i suoi re e le sue regine. Lo stesso vale per i romanzieri del novecento. Si prenda un romanzo come Guerra e pace: i personaggi non appartengono solo alla upper class, ma alla upper-upper class che a quell’epoca governava la Russia. Eppure si riconosce a Tolstoj di aver scritto un romanzo “di mondo”. Come se Norman Mailer avesse scritto Il nudo e il morto e avesse descritto ogni marine o soldato sull’isola come un diplomato di una scuola privata del New England. Questo sarebbe di certo sconvolgente per la gente, eppure Guerra e pace è così.
Con il mescolarsi delle classi nella vita moderna siamo diventati ancora più consapevoli di esse. È uno strano fenomeno. Ma io tratto degli esseri umani con cui sono stato in contatto e che ho avuto modo di osservare da vicino. Per me il fatto che appartengano all’upper class non è una faccenda di particolare interesse.
L’idea di “espiazione” si affaccia ripetutamente nel suo nuovo libro. Ne era consapevole mentre lo scriveva?
Decisamente. I valori morali mi interessano molto, non solo emotivamente ma anche intellettualmente, e il fatto che siano così tanto parte della gente. Il protagonista del racconto che dà il titolo alla raccolta, “Espiazione”, è un uomo coinvolto in un crimine. Lui sente e sa che si tratta di un crimine. Ma il suo vero peccato non è tanto la truffa che commette, quanto il suo desiderio di essere punito. Attraverso la punizione egli vuole evitare le responsabilità verso la società e la famiglia. Preferisce andare in esilio in Europa che affrontare i suoi problemi a Manhattan.
C’è stato qualche elemento nella sua infanzia che ha innescato in lei il desiderio di diventare scrittore?
Non si è consapevoli delle cose che ci influenzano da bambini. Sarebbe impossibile distinguerle. Oggi la gente prova ad analizzare l’entourage da cui proviene e le ragioni per cose accadute, ma se si guarda ai figli di una stessa famiglia – bambini che hanno gli stessi genitori, la stessa scuola, la stessa educazione ed eppure hanno esperienze totalmente differenti e nevrosi – si comprende che ciò che influenza i bambini non sono tanto i fattori ovvi, esteriori quanto le loro esperienze emotive. Naturalmente ogni psichiatra lo sa.
La sua autobiografia del 1974,A writer’s capital termina con questa affermazione: “Così spesso le persone nascono con tutti gli strumenti di cui hanno bisogno, ma sono bloccati dalla semplice paura di utilizzarli”. Con cinquantaquattro libri alle spalle, tutti notevoli, di certo non avrà avuto questo problema. C’è un segreto alla sua prolificità?
Non credo ci sia un qualche segreto particolare, tranne che poiché ho fatto cose diverse nella vita ho dovuto usare ritagli e singoli periodi di tempo. Molti scrittori non lo fanno perché non vi sono obbligati. Possono starsene seduti in una baita di legno in riva a un lago, mettere i piedi vicino al caminetto in silenzio e scrivere. Se si può avere una situazione del genere tanto meglio, ma il vero scrittore impara a scrivere dappertutto, persino in prigione.
Io ho sempre dovuto usare ritagli di tempo. Per esempio, mi portavo dei piccoli taccuini in tribunale e se dovevo aspettare qualcosa potevo anche scrivere svariati paragrafi tutti in una volta. Grazie alla capacità di usare cinque minuti qui, quindici là, sono riuscito a sfruttare un sacco di tempo che la maggior parte della gente spreca.
Ricordo di aver assistito alle prove dell’opera una volta. Il direttore mise giù la bacchetta, i cantanti si interruppero e poi lui la riprese per continuare. Se fossi stato io a cantare avrei dovuto ricominciare dall’inizio. Ma no! Loro ripresero esattamente dalla nota su cui si erano interrotti. È la stessa cosa che ho imparato a fare con lo scrivere.
La sua scrittura è stata spesso associata a quella di Henry James ed Edith Wharton. C’è stato un momento particolare in cui ha deciso di concentrarsi sulla “novel of manners”, oppure le è venuto naturale?
Credo che sia venuto naturalmente. Per un certo periodo mi piaceva scegliere dei temi che mi sembravano importanti per la vita culturale americana e che avevo avuto modo di osservare. Per esempio, il crimine di Richard Whitney ne L’imbroglione (1966), la saga delle scuole private del New England in The Rector of Justin, e la vita di Walter Lippman in The House of the Prophet (1980). Avevo osservato quelle persone e quei fatti con i miei stessi occhi e produssi delle “novel of manners” che trattassero di loro e del nostro tempo.
Capita mai che senta il peso del paragone con scrittori del livello di James e la Wharton?
Non credo di essere assimilabile – nella mia scrittura o pensiero o la mia idea di narrativa – con il grande Henry James. Mi sembra di essere più simile a Edith Wharton, anche se non al suo livello. Scriviamo dei romanzi molto analoghi, specie per il tipo di problemi morali che ci interessano. Non credo che lo stesso valga con Henry James. Nutro un’enorme ammirazione verso la sua opera ma non imito il suo stile in nessun modo.
Il fatto di essere un avvocato come ha influenzato la sua scrittura?
Non credo che l’abbia influenzata affatto. Tranne che la pratica legale mi ha fornito tutta una serie di soggetti che non avrei altrimenti incontrato. Tempo fa ci fu un episodio che mi divertì moltissimo relativo a un memorandum che scrissi per la New York Court of Appeals nel periodo in cui Mario Cuomo era il segretario del giudice Adrian Burke. Cuomo, che allora era un ragazzo, lesse il mio memorandum, lo sbatté sulla scrivania del giudice e disse: “Chi ha scritto questo dovrebbe scrivere romanzi!”. Da allora ci ridiamo ancora su con il governatore Cuomo.
Si scrive molto sul generale declino della cultura civica americana di oggi. Per i suoi legami con istituti quali il Museum of the City of New York e l’American Academy of Arts and Letters, lei è particolarmente qualificato per parlare dello stato della letteratura e dell’arte in America, oggi. Secondo lei, le cose vanno male come molti dicono?
A me pare piuttosto che le arti stiano fiorenti. Certo, c’è una gran quantità di pessime opere proprio per questo, ma ciò vale per ogni grande epoca. Sono sicuro che c’era molta orribile arte durante il Rinascimento che fortunatamente oggi non vediamo – anche se c’è un museo a Vicenza dove si possono vedere dei pessimi dipinti di epoca rinascimentale. Fondamentalmente, però, credo che tanto più tanto meglio. La più grande minaccia all’arte, di questi tempi, è il suo prezzo. La comparsa che deve portare la lancia durante la grande marcia dell’Aidae che un tempo veniva pagata un dollaro per farlo, oggi deve avere un’assicurazione medica e un contratto, e ciò significa che l’Opera dev’essere sostenuta da moltissimi finanziamenti esterni. Non credo però che le cose vadano male come dicono. Gli artisti di livello possono passare dei momenti duri ma prima o poi vengono riconosciuti. Non si tratta affatto di una battaglia persa. Non ancora.
– 15/02/2003
Lo scrittore di Wall Street
GORE VIDAL PRESENTA LOUIS AUCHINCLOSS L´AVVOCATO SCRITTORE NATO A NEW YORK NEL `17 CHE A SUO GIUDIZIO DOPO DREISER E JAMES MEGLIO HA RACCONTATO IL MONDO DEL DENARO E L´ARISTOCRAZIA FINANZIARIA AMERICANA FRA DEPRESSIONE E NEW DEAL. TUTTI I SUOI ROMANZI SONO STORIE DI SOLDI: COME VENGONO FATTI, EREDITATI, SPESI, PERDUTI
Ho letto tutti i romanzi di Auchincloss e non riesco a ricordarne uno che non si ponga delle domande assai serie sui valori del suo «piccolo mondo». Piccolo mondo! È merito dell’astuzia dei nostri governanti e della stupidità dei nostri intellettuali (quelli della divisione libro-chiacchiera, comunque) se si ritiene che il mondo di cui scrive Auchincloss, il regno dei banchieri di Wall Street, degli avvocati e degli agenti di borsa, sia irrilevante, una raffinata enclave di gentili che va sempre più scomparendo; nella realtà, questo piccolo mondo include la classe dirigente degli Stati Uniti, fin troppo dotata di vigore e capacità di autorinnovarsi, un’oligarchia che dispone del pieno controllo della Chase Manhattan Bank, della politica estera americana e dei processi decisionali tanto del partito repubblicano quanto di quello democratico; inoltre, cosa assai «notevole», i personaggi di Auchincloss istituiscono e amministrano le varie fondazioni che finanziano quelle università in cui gli accademici possono vivere serenamente e ottusamente, come tante rane che pensano che il loro stagno sia l’oceano – o l’universo l’università.
Tra tutti i nostri romanzieri, Auchincloss è il solo a svelarci come si comporta la nostra classe dirigente nelle banche e nei consigli di amministrazione, negli uffici legali e nei club privati. E tuttavia, tale è la vastità della nostra società e la lontananza degli accademici e degli autori di libri-chiacchiera dal vero potere, che quelli che dovrebbero essere più in debito con questo scrittore non hanno idea di quale favore egli ci faccia mettendo allo scoperto e, in certo modo, tradendo la sua classe.
… Louis è stato uno scrittore fin dall’inizio: concentrato sulle parole, portato al pettegolezzo, divoratore di libri. In altre parole, una donnicciola, secondo i criteri della perdurante tirannia eterosessuale che ha pervertito in modo così completo, in un verso o nell’altro, praticamente ogni maschio del paese. I ragazzini sensibili e tondetti come Louis se la passano particolarmente male in questo mondo, ma fortunatamente, come dimostrano le sue memorie, lui alla fine è stato in grado di comprendere se stesso e la società come ben pochi degli altri ragazzini sensibili e tondetti riescono a fare. Una triste costante di ogni convegno letterario americano è lo scrittore ubriaco, molle e invecchiato che ballonzola e schiva e tira colpi a nemici reali e immaginari, felice, nella sua follia alcolica, di dimostrare al mondo intero la sua possente mascolinità.
Amando entrambi i genitori in modo più o meno uguale, Auchincloss fu capace di vedere attraverso il virile mondo della legge e della finanza; vide quel che esso fece a suo padre, che a un certo punto ebbe una crisi di nervi. Non illogicamente, «Giunsi a pensare alle donne come a una categoria privilegiata e fortunata col diritto di starsene a casa tutto il giorno sul sofà e parlare al telefono, mentre gli uomini mi parevano dei poveri schiavi condannati ad andare in centro e fare cose noiose e alienanti per mantenere le loro famiglie». Quanto a Wall Street, «non dimenticherò mai l’orrore che mi ispirò con quelle strade cupe e strette e quelle torri alte e fuligginose…». La storia della vita di Auchincloss è tutta nel modo in cui riuscì a conciliare il mondo del padre con quello della madre; come divenne un avvocato e un romanziere; come la professione legale nutrì la sua arte e, presumibilmente, viceversa, anche se non sono sicuro che vorrei affidare a uno scrittore tanto bravo l’avvio di una mia società.
Groton, Yale, la Virginia Law School, la marina durante la seconda guerra mondiale, e poi uno studio legale a Manhattan, la psicoanalisi, il matrimonio, i figli, due dozzine di libri. Adesso, giunto alla mezz’età, lo scrittore guarda indietro, a sé stesso e al nostro tempo, rivolgendo lo specchio di qua e di là; chiedendosi perché, in sostanza, da giovane gli fosse mancata la capacità di essere felice, di essere sé stesso. Con caratteristica modestia, egli minimizza lo sforzo compiuto per conciliare i due mondi per non parlare della dualità della sua stessa natura.
… La tendenza letteraria cui Auchincloss appartiene non ha mai avuto vigore negli Stati Uniti – come dimostra il saggio trasferimento in Inghilterra del suo campione, Henry James. Edith Wharton si è trasferita in Francia, ma è rimasta americana; e tuttavia, ancor oggi, non gode di maggior prestigio del pallido James. Dopo Wharton, il romanzo di costume è rimasto soprattutto nelle mani degli autori commerciali. Né Marquand, che faceva parte dell’establishment, né O’Hara, che non ne faceva parte, viene preso sul serio nel mondo degli U (romanzi universitari ndr), mentre in quello P (romanzi popolari ndr ) sono stati molto disprezzati dopo la guerra, quando i libri-chiacchiera non erano più scritti dai giornalisti a cui venivano dati volumi da recensire perché non erano abbastanza bravi per scrivere sulle partite, bensì da giovani uomini e donne che erano andati all’università, dove la tradizione moderna (sic) era del tutto esotica: Joyce e Lawrence, Proust e Kafka venivano presentati con solennità come modelli che bisognava rispettare o emulare. È pur vero che appena dopo la guerra James ebbe un rilancio, ma solo come raffinato creatore di forme: ciò che sapeva Maisie era meno importante del modo in cui lo diceva. L’inizio degli anni Cinquanta non era un buon momento per uno scrittore come Louis Auchincloss. Ma avrebbe potuto andargli peggio: almeno non ha dovuto chiedere scusa per l’appartenenza alla sua classe, visto che, nell’epoca pre-Camelot, nessuno scrittore americano aveva idea di chi o cosa fosse un Auchincloss. E tuttavia, anche allora i suoi romanzi non interessarono granché i suoi amici scrittori, né coloro che li gonfiavano con le chiacchiere, perché lui non sembrava affrontare nessuna delle cose che contavano veramente, come la guerra recente, o l’essere ebreo/accademico/di classe media/eterosessuale in un mondo che ti taglia le palle. Nessuno era pronto a dei romanzi asciutti e ironici sulla nostra classe dirigente – neppure quei ricercatori sociali che vanno sempre in cerca del vero atto di vendita degli Stati Uniti. Auchincloss, dal canto suo, non era di grande aiuto. Rifiutava di farsi pubblicità. Se i fautori dei libri-chiacchiera non avevano idea di cosa fosse Sullivan e Cromwell, non sarebbe stato lui a dirglielo. Lui si limitava a rappresentare lo studio legale in azione. E sapeva, fin dall’inizio, quel che stava facendo: «Posso affermare con convinzione di non essere mai rimasto “deluso” dalla società. È stato perfettamente chiaro dall’inizio che quel che mi interessava erano le storie di soldi: come venivano fatti, ereditati, perduti, spesi». Mai, dal tempo di Dreiser, uno scrittore americano aveva avuto tanto da dire sul ruolo del denaro nelle nostre vite. Con precisione affascinante, Auchincloss ci mostra come generazioni di avvocati abbiano mantenuto intatte le grandi fortune dell’ultimo secolo. Con risolutezza faraonica essi hanno riempito il panorama sociale americano di piramidi di denaro esentasse, per l’eterna gloria dei Rockefeller, dei Ford e degli altri. Il risultato è che la vita di ogni americano è stata influenzata dalle persone di cui Auchincloss scrive così bene.
… Louis ha affrontato questi temi in modo notevolmente accattivante, ed esagera quando scrive: «il fatto che fossi un avvocato di Wall Street, un repubblicano con tanto di tessera e un certo tipo di persona bastava perché metà della gente, in qualsiasi riunione sociale, mi ignorasse, come una specie di ornitorinco che non andava preso sul serio». Con un pizzico di scoramento, osserva: «Sono sicuro di aver letto, di ciò che scrivevano quelli che partecipavano alle riunioni sociali, molto di più di chiunque altro, sia quanto al numero dei libri che al numero degli autori». Non ho alcun dubbio che fosse così. Ma come è sempre successo negli Stati Uniti, quelli che dovrebbero leggere libri invece li scrivono. Il povero Louis, che conosceva la letteratura francese e americana, e che si teneva al corrente sugli sviluppi, doveva ora vivere in un ambiente letterario di giovani illetterati che recitavano su un palcoscenico. Sovreccitati dalla notorietà conquistata da Hemingway e Fitzgerald, avevano deciso di imitare quei «vecchi maestri». Almeno una dozzina di loro recitavano Hemingway – e ci sono svariati superstiti brizzolati che ancora lo fanno. Di certo nessuno era sé stesso – d’altronde i «sé» scarseggiano in America. Così, in un certo senso, Louis era proprio un ornitorinco in quella fattoria di finti galli. Dopo tutto, non assomigliava a nessuno scrittore famoso di cui avessimo già sentito parlare. Era semplicemente sé stesso, e quindi assai strano per i giovani contraffattori.
Copyright ©2002 La Stampa
– 01/09/1994
L’arte della narrativa
Louis Auchincloss è nato il 27 settembre 1917 a Lawrence, Long Island, figlio di un avvocato di Wall Street socio della Davis & Polk. Nel 1935, dopo essersi diplomato alla Groton School (dove è ambientato il suo più celebre romanzo, The rector of Justin), si iscrive a Yale. Lì scrive un romanzo di quattrocento pagine sull’amore, il suicidio e la vita del college modellato su Madame Bovary. Quando gli viene rifiutato dall’editore Scribners, smette di sperare in quello che , nella sua autobiografia, A Writer’s Capital, definsce “sguazzare nella letteratura” e, rinunciando completamente alla carriera letteraria, abbandona Yale al terzo anno per iscriversi alla University of Virginia School of Law. Con sua grande sorpresa scope che la giurisprudenza gli piace molto. Dopo la laurea si unisce al prestigioso studio Sullivan & Cromwell. I suoi progressi nella pratica legale vengono interrotti dalla Seconda guerra mondiale; presta servizio nella US NAVY durante le operazioni sia dell’Atlantico (dove prende parte allo sbarco in Normandia come ufficiale esecutivo a bordo di un L.S.T.) che del Pacifico. Dopo la guerra lavora come avvocato a New York, prima da Sullivan & Cromwell, e poi per molti anni con Hawkins, Delafield & Wood, dove è a capo del dipartimento ‘Trust and Estates’.
Durante i suoi anni come avvocato produce un’impressionante mole di opere letterarie: trentasei romanzi e tredici libri di saggistica. Come i suoi lettori sanno, il territorio narrativo di Auchincloss è quello della ricca aristocratizia newyorchese. È stato spesso definito come il socio-antropologo dell’upper class americana. Naturalmente, la sua opera evoca paragoni con Edith Wharton e Harry James – autori che egli ammira e di cui ha scritto estensivamente – e con autori più recenti come John P. Marquand e John O’Hara. Si può dire che Auchincloss abbia salvato il romanzo di costume dall’obsolescenza, dopo la morte di Marquand e di O’Hara.
Nel corso degli anni Sessanta Auchincloss fu molto prolifico. Scrisse cinque romanzi, tra cui the Rector of Justin, L’Imbroglione, Portrait in Brownstone, A World of Profit e The House of Five Talents (il preferito dall’autore stesso). The Rector of Justin, pubblicato nel 1964, è quello che ha avuto maggiore successo di vendite. Raggiunge la vetta delle classifiche dei best-seller dove per trentacinque settimane si contende il primo posto con Herzog di Saul Bellow. Candidato sia per il National Book Award che per il Premio Pulitzer, li perse entrambi – molto verosimilmente a causa dell’avversione dei giurati verso la fissazione di Auchicnloss con la società wasp – il National Book Award fu vinto da Herzog e il Pulitzer da Shirley Ann Grau con I guardiani della casa. Auchincloss ne è molto amareggiato: “È una sciocca faccenda mondana”, scrive a Gore Vidal, “ed è sciocco che me ne abbia a male. Però è così”.
L’opera di Auchincloss non si limita affatto alla narrativa. La sua prima raccolta di saggi critici (Reflections of a Jacobite) viene pubblicata nel 1961, primo dei suoi tredici libri di saggi. Non c’è da stupirsi se ha scritto numerosi saggi su Proust, come anche su Bourget, Corneille, Daydet, Racine, Richelieu. Fervente francofilo, una volta fu descritto come colui che sogna ad occhi aperti la corte di Versailles. Di inglesi, ha scritto su Shakespeare e i romanzieri del diciannovesimo secolo, e di americani, ha scritto di Henry Adams, Willa Carter, Emily Dickinson, Carson McCullers, Katherine Anne Porter, tra gli altri, come anche, naturalmente, Joh P. Marquand e John O’Hara.
Di sicuro la domanda che le pongono più spesso è come lei sia riuscito a scrivere cinquanta libri di piena lunghezza, svolgere con successo l’attività legale e al tempo stesso avere una vita di famiglia. Mi chiedo quale dei tre soffra di più a causa degli altri? Si spera non la legge: i suoi clienti potrebbero arrabbiarsi.
Scrivere tutti quei libri non mi è mai parso un tale trucco, anche se di sicuro non credo che potrei rifarlo, oggi, con l’enorme enfasi posta dagli studi legali sugli orari e i cartellini. Avevo uno studio patrimoniale, e i clienti in genere erano morti, cosa che aiuta, perché non sono sempre lì a farti pressioni.
E quindi non se ne preoccupavano…
Esatto, ma naturalmente i loro eredi sì, e comunque non erano loro i miei clienti. Scoprii che scrivere richiedeva capacità di adattamento –in sostanza, l’essere in grado di usare piccoli ritagli di tempo per scrivere. Molti scrittori hanno bisogno di interi giorni o notti per essere pronti a scrivere; a loro piace stare davanti al caminetto, nella totale serenità, con le pantofole e una pipa o qualcosa del genere e solo allora sono pronti.
Non riescono a credere che si possano usare cinque minuti qui, dieci minuti là, un quarto d’ora un po’ più tardi. Eppure è solo una questione di esercizio nell’imparare quel trucco. Se fossero OBBLIGATI a scrivere così, ci riuscirebbero, gli scrittori veri, cioè: io posso riprendere una frase che avevo lasciato a metà e continuare da lì. Scrivevo di notte, a volte scrivevo in ufficio e finivo per lavorare per lo studio a casa. Io e mia moglie non andavamo mai via durante i fine settimana. Non consiglierei a nessuno di adottare questo metodo, ma per me ha funzionato. Ed anche per Trollope. Non voglio paragonarmi a Trollope, ma è stato detto che lui aveva l’abitudine di scrivere dalle nove a mezzogiorno e se finiva un romanzo alle dodici meno un quarto, ne cominciava un altro. Disgraziatamente, lui raccontò tutto questo nella sua autobiografia e uccise la sua reputazione per decenni perché la gente vuole pensare alla scrittura come a una sofferenza.
Crede che scriverebbe meglio se soffrisse?
No. E credo che lo stesso valga per la gran parte degli scrittori. Credo che Shakespeare sia andato a ubriacarsi dopo aver finito Re Lear. Si dev’essere divertito un mondo a scriverlo.
Lei si ubriaca dopo aver finito un libro?
No, non io. Sono una persona molto regolare.
Ebbene, quanto l’ha aiutata l’attività legale? Poniamo il caso che lei avesse intrapreso un’attività diversa…
… come medico? No, non credo.
Forse non il medico, ma un agente assicurativo, per esempio. Mi viene in mente Wallace Stevens.
Be’, quello sarebbe stato facile, la gente delle assicurazioni lavora solo dalle 9 alle 5, almeno quelli che conosco io.
Ma nell’attività legale non le capita mai di dire: “Aha, di questo ne potrei scrivere!”?
Guardando indietro alla mia carriera letteraria i racconti sulla giurisprudenza mi furono suggeriti dalle cose che vedevo o sentivo dai personaggi che incontravo nella mia attività. Ho scritto di più dei rapporti tra gli avvocati nella loro professione che delle vere e proprie situazioni legali. Arthur Train scriveva spessissimo di questioni legali nei suoi libri, i l’ho fatto a volte, ma più spesso mi sono servito semplicemente dell’interazione tra i membri di uno studio.
Immagino che per un avvocato sia di grande aiuto…
L’unica volta in cui hanno minacciato di farmi causa fu quando i miei editori fotografarono una casa della 52° strada per la copertina di uno dei miei romanzi. Il padrone della casa si mise a dire che mi avrebbe denunciato. Ma gli fu fatto notare che l’unica cosa per la quale avrebbe potuto farmi causa in quelle circostanze era se la casa era riconoscibile e se io l’avevo descritta come qualcosa che rifletteva il padrone, tipo una casa chiusa.
Come nascono i tuoi romanzi… The Rectorof Justin, per esempio, uno dei libri più amati dal pubblico?
Era da molto che ci pensavo. Ho fatto sei anni di scuola a Groton nel Massachussets, e da sempre sapevo che avrei scritto qualcosa sulle scuole del New England. Tutti pensarono che avessi a modello Endicott Peabody di Groton, ma non era vero. Lessi le biografie di tutti i presidi più famosi della sua era, parecchi libri. Avevano molto in comune. Da questi ho costruito il mio personaggio. Fisicamente, l’ho modellato sul giudice Leonard Hand, che conoscevo assai bene e stimavo molto. Nel libro misi un sacco di detti di Hand. Gli diedi persino tre figlie, come il personaggio vero e come Re Lear; il giudice Hand diceva sempre, non ricordo quale delle mie figlie me l’ha detto, Goneri o Regan. Eppure l’unico lettore che l’abbia riconosciuto fu Archibald MacLeish, che mi chiese, “Com’è possibile che nessuno veda che in questo romanzo c’è il giudice Hand?”. Gli risposi, “Perché è un preside”. Se scrivessi un romanzo su Abraham Lincoln e gli facessi fare il dentista, potrei fargli pronunciare anche il discorso di Gettysburg e nessuno lo riconoscerebbe.
Groton come l’ha presa?
La scuola non ha gradito. Per un po’ fui tacciato di persona non grata. Ma alla fine l’hanno superata, al centennale della scuola mi hanno chiesto di fare il discorso d’apertura. Così siamo tornati in buoni rapporti.
Che ne ha pensato Endicott Peabody?
Be’, era morto.
Come i suoi clienti. E la famiglia Peabody?
Ne furono molto infastiditi all’inizio, ma alla fine ci fu la riconciliazione grazie a Marietta, ce mi disse, “Nel suo libro non ci trovo assolutamente nulla del nonno. Questo mi fa capire che la gente non lo conosceva davvero. Credono che un preside sia solo uno che alza la voce”. È vero comunque che una volta il dr. Peabody disse che se il vocabolario di un preside fosse ridotto a una singola parola, e quella parola fosse “No”, egli riuscirebbe lo stesso a fare il suo lavoro.
Capita mai che la gente venga da lei e le dica “Io mi riconosco in questo personaggio del suo libro?”.
Capita eccome, ma di solito sono così lontani dal vero da risultare ridicoli. Ricordo un importante avvocato del fisco, un uomo che prendeva tutto alla lettera, con una stupefacente intelligenza matematica, che mi accusò di averlo usato in una storia. La storia parlava di un uomo che teneva un diario con grande passione. A un certo punto, l’uomo comincia a vivere per il suo diario, impegna tutta la sua esistenza alla ricerca di elementi da aggiungervi. È il gatto che si morde la coda. Chiesi a Norris, “Per quale motivo presume di essere lei quel personaggio? Lei tiene un diario?”. Lui rispose “Certo che no!”. Chiesi “Cosa c’è dunque nella storia che le fa credere di essere quel personaggio?”. Rispose “Era il socio anziano del fisco dello studio legale”. Ecco, questo è il genere di cose in cui incorre uno scrittore.
È mai capitato che qualcuno sia venuto da lei presentando dei dati accurati?
Una volta. Il mio primissimo libro lo pubblicai con uno pseudonimo. Un uomo di nome Kenneth Pendar, oggi da tempo deceduto, si vide descritto in modo piuttosto sgradevole come protagonista; era in parte vero. Decisi che non l’avrei mai più fatto perché ferii terribilmente i suoi sentimenti, e mi senti un vero mascalzone.
Quindi è così che lavora coi suoi personaggi, di solito? Prende spunto da qualcuno che conosce e poi vi aggiunge tanti pezzetti di altre persone per renderle irriconoscibili?
Esatto. Quasi mai mi viene n mente un personaggio già completo di per sé. Gli ci vogliono dei tratti aggiuntivi che spesso prendo da persone reali. Un modo di nascondere le tracce è cambiare sesso.
L’ha mai fatto?
Sì.
Con chi?
Oh be’, non lo direi mai.
Il personaggio diventa completamente diverso, immagino.
Be’, bisogna operare alcuni cambiamenti necessari… vive la différence. Ma i tratti salienti, essenziali di un personaggio restano uguali in un uomo come in una donna.
È molto rigido nel controllo dei suoi personaggi? Può capitare che un uomo cambi e diventi donna?
Nel mio romanzo L’imbroglione il protagonista cambiava mentre scrivevo. Cambiavano le sue motivazioni. Non ero mai sicuro di averlo inquadrato bene. Ne ero sconcertato. È il mio personaggio più completo e del tutto inventato.
Le è mai capitato di conoscere un truffatore?
No, ma c’era il caso Richard Whitney. In molti dei miei libri prendo spunto dagli eventi importanti della mia stessa vita che ho potuto osservare da vicino. Quando andavo a Yale, il caso Richard Whitney fece scalpore in tutta New York, specie nell’ambiente di Wall Street. Sembrava incredibile che il presidente della Borsa di New York si comportasse a quel modo. Fece una truffa utilizzando il fondo per l’indennità della Borsa, il Trust Fund di sua moglie e altri fondi appartenenti al New York Yacht Club per un totale di 300,000 dollari. Inoltre aveva un debito di venti milioni di dollari. J.P.Morgan & Co., di cui era socio suo fratello dovevano trarlo d’impaccio, tranne che per i 300,000 dollari. Quando lo vennero a sapere però, dovettero abbandonarlo perché non potevano rendersi complici di un crimine, di certo non dopo aver parlato con i loro avvocati. Fu alquanto strano: il crimine in sé riguardava soltanto una minima parte del suo giro di soldi, eppure fu proprio quello a sconvolgere tutti i piani. Se Whitney non avesse fatto la truffa, Morgan lo avrebbe aiutato. Difficilmente, oggigiorno, una cosa del genere sarebbe in prima pagina. In quei giorni invece produsse un’incredibile ondata di shock. Non esitai a usare il caso, volevo che i fatti fossero assolutamente fedeli all’accaduto. Quando però misi i personaggi nella situazione, li inventai. Persino la famigli aWhitney lo ammise, anche se all’inizio erano un po’ a disagio. Mi obiettarono che li conoscevo tutti. Dissero, “Non farai che far tornare a galla questa miserabile storia”. Dissi “È storia, assolutamente storia”.
E l’intreccio? Quanto è importante per lei?
L’intreccio è molto importante per il tipo di romanzi che scrivo. A volte ho ecceduto con l’intreccio?. Non dimenticherò mai Elizabeth Janeway che mi diceva “Troppo intreccio fa solo un gran rumore”. Una volta ogni tanto capita che le critiche ti colpiscano al cuore, e quella lo fece con me, perché pensai che aveva ragione. Dopo quell’episodio snellii le mie trame.
Non sono certo di aver capito cosa intendesse per “gran rumore”.
Ce n’era troppo, troppo visibile. L’intreccio dovrebbe essere nascosto sotto il tappeto.
Crede sia una buona idea nasconderlo?
Se qualcuno si accorge della trama, è come un osso che spunta. Se l’osso rompe la pelle, ha un effetto molto sgradevole.
E.M.Forster elimina di colpo uno dei personaggi facendolo “spezzare in una partita di football”.
Sì, Forster fa cose del genere coi suoi personaggi.
Non dovrebbe morire naturalmente?
Se a farlo è un genio tutto funziona. Per lui funziona.
Lei però non lo farebbe.
Non oserei fare ciò che Forster fa coi suoi personaggi. A volte interviene nella narrazione e li commenta “Tizio era un vero coglione”. Si resta alquanto allibiti sentendo Forster parlare così, ma questa è una delle sue particolarità. Thackeray faceva lo stesso.
Ma la trama è fondamentale, non crede?
Be’, non lo so. Nathalie Saurrante non la penserebbe così.
Secondo lei cos’è più importante, la trama o il personaggio?
Dipende dal tipo di romanzo che si sta scrivendo e da chi è l’autore. Se il personaggio è davvero abbastanza forte non c’è praticamente bisogno d’altro. Amleto è una tragedia con una trama fittissima, eppure non ne avrebbe quasi bisogno con un personaggio così affascinante.
Torniamo un attimo indietro. Quando ha capito che voleva fare lo scrittore?
Durante il mio terzo anno a Yale scrissi un romanzo e lo spedii a Scribners. Mi fu rifiutato con una lettera molto gentile con cui mi dicevano che erano interessati a vedere qualcos’altro di mio, ma mi senti scoraggiato. Decisi di smettere di scrivere del tutto, lasciai Yale e mi iscrissi alla Law School della Universitiy of Virginia che all’epoca ammetteva studenti non ancora laureati. Mio padre disse, “Perché non finisci Yale?”. Risposi “Perché ho bisogno di cominciare subito un’altra cosa. Il rifiuto mi ha troppo ferito”. Disse “ma così dovrai passare il resto dei tuoi giorni a spiegare perché non ti sei laureato a Yale”. E aveva ragione. Lo sto ancora facendo.
Avrei fatto l’avvocato, solo l’avvocato, però mi rimisi a scrivere durante le estati. Scrissi un altro romanzo e poi lo distrussi. Lo buttai nel bidone della spazzatura. Dopo me ne pentii moltissimo. Feci come un pazzo per ritrovarlo, ma naturalmente la spazzatura era stata portata via. Il romanzo era andato. Non ho dubbi che l’immondizia fosse un luogo inadeguato. Poi cominciai a fare pratica legale. Durante la guerra scrissi un altro romanzo e lo pubblicai.
E le sue prime letture? Chi era erano gli autori che ammirava in modo particolare, chi le ha fatto pensare di voler diventare uno scrittore?
Da sempre volevo fare lo scrittore. È sempre stata una cosa molto importante per me, sin da piccolo.
C’erano degli scrittori nella sua famiglia?
Nessuno.
Ne conosceva qualcuno?
Conoscevo il signor Arthur Train. Non lo ammiravo particolarmente per il suo lavoro, ma mi piaceva moltissimo come persona. Era una grande amico della mia famiglia. Scrisse le storie su Ephraim Tutt. Oggi non le ricorda quasi più nessuno.
Però non era il suo modello letterario.
Ero un fan di Henry James ed Edith Wharton, sin da piccolo.
Ha visto il film L’età dell’innocenza?
L’ho recensito. Mi è piaciuto moltissimo. È uno splendido film. Riflette il libro in assoluto e per intero, riconosce a pieno il forte effetto della decorazione, delle case, sui personaggi. Scorsese l’ha diretto in modo da far sentire al pubblico la bruttezza dei quadri e il lusso degli interni; sono quasi dei personaggi in sé e per sé, proprio come nel libro. Edmund Wilson ha definito Edith Wharton la “pioniera e poetessa della decorazione d’interni”. Scorsese questo lo vede. È il miglior adattamento cinematografico di un libro che abbia mai visto, oltre a Via col vento che a mio parere è un grande film tratto però da un libro non così grande.
Cosa pensa degli esercizi di scrittura? Lei approva i corsi che fanno?
Non credo che lo si possa insegnare. Chi è già uno scrittore potrebbe trarne beneficio. Io non ho mai provato, e non so proprio che metodi usino, ma non credo che chi non è uno scrittore di suo possa mai diventarlo grazie a un corso.
Che rapporti ci sono tra lei e il suo editore?
Ho un ottimo editore, mi trovo molto bene con lui, ma fondamentalmente lui si limita a pubblicare le cose come gliele mando io.
Non capita che la chiamino e le suggeriscano di togliere il capitolo otto?
No, non capita.
Perché non osano?
No, credo che oserebbero, ma sono troppo impegnati con l’editing delle autobiografie di generali e senatori e altri vip. Su quei libri ci devono lavorare molto.
Si sente in competizione con gli altri scrittori?
Direi di no, no.
Le capita di provare gioia quando uno scrittore che era stato sopravvalutato riceve una stroncatura?
Non sono come Gore Vidal che ha detto “Ogni volta che un amico ha successo, qualcosa dentro me muore”, però capisco bene cosa intende.
Ha molti contatti con i suoi colleghi scrittori?
Subito dopo la guerra andavo spesso alla White Horse Tavern dove Vance Bourjaily riuniva giovani scrittori. Aveva un fiuto incredibile, perché prima o poi ogni singola persona di quelle che chiamava si fece un nome. Gli incontri però erano interminabili e la conversazione meno brillante ch ebrillante. Essendo un solerte avvocato , avevo bisogno di uno stile di vita più regolare. Quando sposai Adele lei mi disse, “Che bello, usciremo con tutti quei magnifici scrittori”. Una notte Calder Willingham telefonò proprio quando stavamo per andare a letto. Mi chiese se ci andava di uscire a bere con lui. Dissi “Be’, non credo che Adele ne abbia voglia”. “Allora perché non vieni tu solo?”. La sua idea era di star svegli tutta la notte. Dissi, “No, non posso”. Dovevo svegliarmi al mattino. Così per un po’ non frequentai molti scrittori. Crescendo, però, si calmarono un po’, quantomeno quelli che erano sopravvissuti, e potei tornare ad essere uno di loro.
Quindi secondo lei la stabilità e una vita regolare…
Be’, per me erano del tutto necessari perché stavo portando avanti due cose contemporaneamente.
Quindi, se lei dovesse costruire uno scrittore, la disciplina sarebbe un elemento fondamentale del suo equipaggiamento?
Specialmente per uno scrittore americano, sì. Peter Prescott stava scrivendo un libro sull’alcol e gli scrittori americani, e d è proprio straordinario quanti di essi fossero alcolizzati. Sinclair Lewis, Dreiser, Fitzgerald, e l’elenco è lunghissimo.
Secondo lei perché bevono tanto?
Be’, questo non lo so.
Come se lo spiegava Prescott?
Non credo abbia mai finito di scrivere il libro.
Oh oh! Forse perché gli scrittori non sono abbastanza impegnati?
Questo potrebbe essere vero. Credo che sia così durante gli intervalli. Se non stanno scrivendo, gli scrittori spesso diventano molto nervosi e tesi e poi sono inclini a sentirsi, “Oh, non scriverò mai più; non sarà mai più come prima”. E poi magari si consolano con una bevuta.
Beve di più ora che non lavora più come avvocato?
No, no, bevo esattamente come prima.
Quanto tempo passa a scrivere in un giorno?
Be’ non mi forzo mai. Se non mi va di scrivere, non scrivo. Mi sento di aver scritto abbastanza nella vita.
Quand’è che le viene il bisogno di scrivere? È come un’idea che le si affaccia nella testa?
Be’, non ha senso scrivere se non si ha un’idea di base. E deve essere l’idea giusta. L’unico libro che abbia mai letto che descrive a mio parere perfettamente la situazione dello scrittore sono i Taccuini di Henry James. Quando uscirono la prima volta, la gente era piuttosto seccata perché le sue idee focali sembravano provenire da fonti talmente triviali: a cena si trovava seduto accanto a una qualche donna che aveva litigato col figlio riguardo i mobili del soggiorno. Da lì, lui rendeva propria l’idea e cominciava ad aggiungervi elementi; l’idea cominciava a crescere. Conosco quella sensazione: all’improvviso, “Quello è mio!” Se avesse detto a qualcuno di che si trattava, gli avrebbero risposto, “Ma non è nulla”. E naturalmente è vero, non è nulla. Ma è un seme.
Il contrario avviene quando la gente dice, “Oh, ho una storia meravigliosa per te. Mio zio…”. E via discorrendo. Non riesci mai ad usarlo come materiale perché l’unica cosa interessante della storia è che è vera. Non appena la inserisci in un romanzo o in un racconto, smette di essere vera. I romanzi devono essere verosimili, e la verità non lo è quasi per niente.
Quindi le capita di ascoltare una conversazione a cena, à la Henry James, e quello diviene il seme?
Di solito si tratta di una relazione particolare tra due persone. Mi colpisce qualcosa tra una madre e un figlio, o marito e moglie, qualcosa che a me risulta insolito o interessante.
Ha mai pensato di fare un adattamento teatrale tratto da uno dei suoi libri?
L’ho fatto, e ho anche scritto delle commedie, anche se è stata fatta una produzione solo di un dramma di un solo atto. È molto meno comune per un romanziere scrivere commedie che un tempo, perché il dialogo è meno importante di quello che Elia Kazan ha chiamato “incandenza”; Che sarebbe oggi del famoso drammaturgo Galsworthy?
Lei è molto prolifico. Quanto riscrive le cose?
È variabile. The Rector of Justin, per esempio, l’ho riscritto per intero. Ma di solito trovo che quando devo riscrivere, significa che c’è qualcosa di sbagliato alla radice. La mia roba migliore di solito mi riesce bene al primo tentativo.
Da cosa capisce se funziona o no?
Oh, lo sento e basta. Una volta che lo senti, nessuno al mondo può convincerti del contrario.
Comincia da pagina uno e va dritto fino alla fine?
Oh, sì, è tutto delineato prima.
Lo prepara come si farebbe con il verbale di un processo?
In un certo senso sì. Comincio dal principio e poi dispongo le cose na dietro l’altra.
Sa già quale sarà l’ultima frase prima di arrivarci?
No, non so quale sarà l’ultima frase, però so cosa succederà.
Quando scrive considera lo stile importante?
Come disse il conte de Buffon, “Lo stile è l’uomo”.
Che significa?
Lo stile letterario riflette la personalità.
I suoi scritti sono permeati da un giudizio morale per i lettori?
Non credo, no. Non ho scritto L’imbroglione per dire alla gente di non imbrogliare.
Ha letto la recente biografia che hanno scritto di lei?
Oh sì!
Si è divertito leggendola?
Sì, è fin troppo clemente nei miei riguardi; non ha venduto molto.
Per quale dei suoi libri le piacerebbe essere ricordato?
I tre che sono appena stati ripubblicati da Galahad Books in un unico volume dal titolo Family Fortunes: The Rector of Justin, The House of Five Talents e Portrait in Brownstone. Mi ha fatto molto piacere vederli ripubblicati perché due di essi erano del tutto fuori stampa. Ero felice di riaverli.
Cosa scrive sul suo passaporto sotto la voce “professione”?
Di solito avvocato in pensione.
Punto.
Sì.
– 01/10/1998
Louis Auchincloss at 80
Louis Stanton Auchincloss was born in Lawrence, New York, in 1917 and was brought up in New York City. He has had, as I have remarked, a very long and complicated career. His family was wealthy and large—full of cousins, uncles, aunts, and in-laws. As a boy he spent his summers at Bar Harbor and on Long Island. Later he went to Groton and Yale, where he was Phi Beta Kappa and editor of the Yale Literary Magazine.
After three years in New Haven, he left Yale and entered the University of Virginia at Charlottesville, where he took a law degree in 1941. During World War II, he spent four years at sea, where he had ample time to read the great novelists of manners and to serve his own apprenticeship as a writer. After the war, he returned to New York City and practiced estate law until he retired from the Wall Street firm of Hawkins, Delafield, and Wood in 1986. Despite his devotion to his now-deceased wife, Adèle, and their children and grandchildren—and despite the years devoted to client trusts and wills, as well as to city commissions, charities, and municipal offices (he was for some time president of the Museum of the City of New York)—Auchincloss has nevertheless published more than fifty volumes of fiction, literary criticism, history, biography, autobiography, and social history. Among his many novels are The Indifferent Children (1947), Sybil (1952), A Law for the Lion (1953), The Great World and Timothy Colt (1956), Venus in Sparta (1958), The Pursuit of the Prodigal (1959), The House of Five Talents (1960), Portrait in Brownstone (1962), The Rector of Justin (1964), The Embezzler (1965), The House of the Prophet (1980), The Book Class (1984), The Golden Calves (1988), and Fellow Passengers (1989).
He has also produced a great many volumes of short stories—among them The Injustice Collectors (1950), Skinny Island (1981), Narcissa and Other Fables (1983), False Gods (1992), Tales of Yesteryear (1994)— and a great many studies in literary criticism such as Pioneers and Caretakers (1965) and Edith Wharton: A Woman in Her Time (1971). An excellent selection from his short-story volumes, The Collected Stories of Louis Auchincloss (Houghton Mifflin), was made by the author himself in 1994. It includes a number of my personal favorites, including the highly reflexive tale “The Novelist of Manners,” which makes wry, witty mincemeat of a number of Auchincloss’s negative reviewers.
The world brought to life in Auchincloss’s stories is the nineteenth- and twentieth-century life of the metropolitan rich in New York City, particularly the lives of the lawyers, bankers, trust officers, corporation executives, and their wives and daughters. As a lawyer, Auchincloss knows them in their Park Avenue apartments and in their Wall Street offices. He sees the glitter and glamour of their world, its arrogant materialism and its unexpected generosities. He knows the rigidity of its conventions— just how far they can be bent, at what point they break, just when convention may break a character. He understands what happens to the idealistic men and the unfulfilled women of this world. And he is able to tell their stories with unusual sympathy. Rarely has Auchincloss ventured from this small but exclusive world, because it is the world he knows best. For this “narrowness” he has been criticized. But if he does not write panoramic novels of the U.S.A., great fluid puddings encompassing the whole of the American scene, it is because he has learned from Henry James the lesson James tried to teach Mrs. Wharton: that she must be “tethered in native pastures, even if it reduces her to a backyard in New York.” The New York haut monde is, as it were, Louis Auchincloss’s backyard.
In telling the stories of these upper-class New Yorkers, Auchincloss continues to remind us of Henry James in the emphasis he gives to the moral issues that grow out of their social lives. Because he once called one of his critical books Reflections of a Jacobite (1961), reviewers long ago concluded that it is enough to describe him as an imitator of the master. He most differs from James, though, in the informed analysis he is able to give to the complex problems of ethics in the legal profession—a command of the world of Wall Street brokers and bankers which James himself sorely regretted not having. Auchincloss called himself a Jacobite because so much of his youthful reading was “over the shoulder of Henry James.”
To read the fiction of Proust, Trollope, Meredith, Thackeray, George Eliot, and Edith Wharton in the light of the criticism, fiction, and letters of James, Auchincloss observed, is to be exposed to the full range of possibility for the novel of manners, “to be conducted through the literature of [James’s] time, English, American, French and Russian, by a kindly guide of infinitely good manners, who is also infinitely discerning, tasteful and conscientious.” James, for Auchincloss, has been a “starting point,” a “common denominator.” But, once started, Auchincloss has always gone his own way—often qualifying and contesting, as well as defining and enlarging, the social insights of the nineteenth-century novelist of manners.
Not all of his novels are in this vein—he is fascinated by the unexhausted possibilities of the novel of character as well—but most of them hinge upon the imperatives of private morality in a world where social morality no longer, apparently, exists. In many of these books Auchincloss explores the ambiguities of selfhood, affirming, finally, the freedom and autonomy of the human personality. Most novelists of manners, profoundly influenced by the behaviorism of the naturalistic sciences (Wharton, Wells, Bennett, O’Hara, Marquand, for example), tend to believe that the personality is thoroughly conditioned by the material environment. They create character, as Virginia Woolf objected, in very close correlation to, and through descriptions of, houses, clothes, furniture, and the like. Auchincloss rejects this approach to characterization. For him, “character” or personality exists independent of the web of the material environment that surrounds it. As Ida Trask Hartley observes in Portrait in Brownstone, in describing the narrow grey limestone façade of Mr. Robbins’s house—with its “grinning lions’ heads and balconies for flowerpots supported by squatting ladies, and topped with a giant dormer studded with bull’s-eye windows”: “Nobody passing it today would believe that it had not been built by the most pushing parvenu. Yet I know how little the houses of that era sometimes expressed the souls of their occupants.”
In A Law for the Lion, Eloise Dilworth wants to find out whether there is any real “identity” beneath the various roles she has played during her lifetime—the childish niece to her aunt and uncle, the submissive wife to her indifferent husband, the taken-for-granted mother to her children. Her search for an answer leads her to reject the arbitrary manners and conventions of the social world she has been brought up in. But her losses are more than compensated for by her discovery that there is a real “self” beneath the functions imposed on her by her social existence. This kind of “Who am I?” theme is also developed in Sybil, Portrait in Brownstone, and The House of Five Talents.
A variation on it is the “Who is he?” theme developed in The Rector of Justin. In this novel, Frank Prescott, recently deceased headmaster of a preparatory school, is recreated through the differing recollections and impressions of several characters—the priggish young admirer, the irreverent daughter, the wife, the friends, the students and alumni. What the novel suggests is that we can never know what Prescott was really like because none of the narrators knew the real Prescott—he presented a different side to each of them. It might well be asked whether there was any “real” Prescott behind his various masks. The answer is yes, but we can never know him except as a composite of the limited points of view of his various biographers. Auchincloss’s dramatic technique in this “conventional novel of character” creates a built-in ambiguity comparable to that of James’s The Awkward Age or, for that matter, to Faulkner’s Absalom, Absalom!
The dominant note of Auchincloss’s fiction, at least in recent years, has been pathos rather than tragedy. Central to that pathos is the sense that his world of social privilege is dying. It should be said, however, that the class of rich and powerful families that Auchincloss writes about is not about to give up the ghost. It still controls great wealth, preserves its status in schools like Groton, Harvard, and Yale; it manages powerful institutions in commerce, government, and the arts; and it discloses itself through distinctive styles in speech, dress, and deportment.
This group is not really a class in the sociological sense, and it is not monolithic; some of the children will wind up at Amherst or Brown or may marry attractive or wealthy arrivistes. But such have always been its processes of networking, adaptation, and self-renewal. To those whose ideas are formed by the television show “Hard Copy” or “Lifestyles of the Rich and Famous,” Auchincloss’s world will hardly be visible, but that is because it shuns the kind of attention courted by the nouveaux. (It was quite an embarrassment to some members of the clan when Jacqueline Bouvier, Louis’s cousin, fell in with the Kennedys.) Moreover, although Auchincloss himself may now be eighty, and although the past that he and his parents once knew may be dissolving into a representation charged with bittersweet pathos, the group is continuously renewing itself, not disappearing. Keep an eye on his sons, and their children, and their friends. Who knows? Some of them may also turn out to be the next novelists of that world.
Despite the oft-heard complaint, then, I am not at all convinced that Auchincloss is guilty of what Edith Wharton in A Backward Glance (1934) called the tendency not infrequent in novelists of manners—Balzac and Thackeray among them—to be “dazzled by contact with the very society they satirize.” Auchincloss is fascinated by the world he portrays: he loves the details of an estate settlement as much as Thackeray loved the stylish little supper parties of Mrs. Rawdon Crawley; he is as fascinated by the complexities of a corporation merger as Proust was by the intricacies of precedence; and he is as delighted by the eccentricities of the rich as Balzac was by the spectacle of miserly greed.
But if Auchincloss loves his world, he is not taken in by it. Conscious of the moral and social incongruities between his world and that of poorer New Yorkers, he is as disturbed as anyone else that “no matter how painstakingly Proust underlines the dullness, the selfishness, and the fatuity of the Guermantes set, they remain to the end still invested with much of the glamour in which his imagination clothed them.” His love for his affluent world is one of an artist for his material, which is quite another thing from his feeling for it as a man. Every writer, he has observed in Reflections of a Jacobite, has two points of view about the society in which he lives:
that of a citizen and that of an artist. The latter is concerned only with the suitability of society as material for his art. Just as a liberal journalist may secretly rejoice at the rise of a Senator McCarthy because of the opportunity which it affords him to write brilliant and scathing denunciations of demagogues, so will the eye of the novelist of manners light up at the first glimpse of social injustice. For his books must depend for their life blood on contrast and are bound to lose both significance and popularity in a classless society.
Our awareness of this distinction between society as experienced and society as transformed in fiction ought to discourage us, then, from slighting, on the spurious ground of “political correctness,” a splendid writer who insists on exploring inequities and ambiguities from the inside of the social mechanism. If we are fully open to the literary quality of his work—to aesthetic questions of form and style—the judgment of some very sensitive critics will become irresistibly clear. I mean such critics as John Betjeman, who toward the end of his life acclaimed the clarity of the prose of Louis Auchincloss. Elizabeth Bowen called him “a storyteller with a beautifully clear and direct style—a classically good English style,” and she remarked that he is “one of the ablest story-tellers and direct psychologists using the English language.” Angus Wilson likewise defined him as “a very clever and subtle student of human social behavior”; and Anthony Burgess commended the power with which Auchincloss’s fiction “presents the real twentieth-century world, very sharply, very subtly, very elegantly.” We cannot fully understand the workings of power in the United Sates—legal, financial, and social—without attending to his fiction, as Gore Vidal has rightly observed. And recently, in Vanity Fair, Susan Cheever called Auchincloss “one of the best writers alive.” If these critics are indeed right—and they are—it behooves us to get to know even more of his work.