Prefazione di Chiara Valerio ad «Althénopis» di Fabrizia Ramondino
• Il blog di Fazi Editore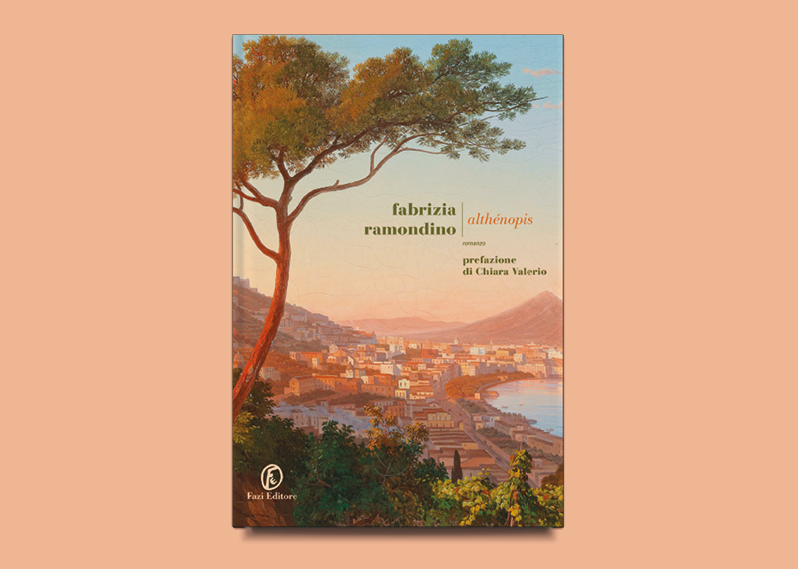
Pubblichiamo la prefazione di Chiara Valerio alla nuova edizione di Althénopis, il romanzo d’esordio di Fabrizia Ramondino.
Althénopis di Fabrizia Ramondino è un racconto familiare nel Sud Italia a cavallo della seconda guerra mondiale. Ed è il libro dei resti.
I cocci, la cacca, il piscio, le ossa dei morti. Il gesto del raccogliere i cocci, e il defecare, per gara, spregio o perché così succede, i cimiteri di esseri umani e bestie – vacche soprattutto – e carcasse di fichi d’india, simili a dinosauri. Ed è questo, perché Althénopis è il romanzo dell’infanzia, di ciò in cui essa consiste, e persiste, cioè spreco e minuzie, ammesso che abbia senso segnare una differenza, dove con spreco ha da intendersi pure raccolte e collezioni di conchiglie e brecciole, di foglie ed esplorazioni. L’ininterrotto vorticare intorno ai tavoli, le corse fino al mare, le febbri notturne, le pezzuole all’aceto sulla testa della madre che all’inizio di un capitolo sono due e alla fine della giornata marina, quando il sole tramonta accendendo di rosa i panni stesi all’aria, una montagna. La madre è sepolta sotto una montagna di garze imbevute d’aceto.
Il romanzo riguarda, come siamo abituati da ciò cui l’Ottocento europeo ha assegnato il nome di romanzo, la casa, anzi, più esattamente, le case. Come Cime tempestose, come Jane Eyre – addirittura la magione di Rochester ha una stanza segreta, murata, una casa infestata dai vivi, come più spesso accade che dai fantasmi – come L’età dell’innocenza, o Tra un atto e l’altro, come pure, da noi, Gli indifferenti – se «Entrò Carla», incipit, dove se non nella stanza di una casa – o Ferito a morte, grande romanzo althenopeo racchiuso tra il mare e un palazzo dal nome di donna. E si potrebbe continuare, tra Ottocento e Novecento, come in una agenzia immobiliare, perché di case ha bisogno la borghesia che racconta o aspira. I cocci, dunque e la casa.
Andavamo in giro per le campagne alla ricerca di un bene prezioso per i nostri giochi: i cocci colorati di piatti, di tazzine, di mattonelle.
[…]
Una volta, nella masseria di Ciccillo, con grosse pietre bianche costruimmo la pianta di una casa; con i cocci giocavamo alla cucinella, e con quelli più colorati avevamo fatto una coperta, dalla quale spuntava un piccolo melograno, a imitare la testa di un lattante.
Althénopis si apre con o su una casa che non è quella che dovrebbe essere, ma una residenza d’appoggio, agglomerato di stanze per gli sfollati, siamo, ripeto, intorno alla seconda guerra mondiale in Campania, sulla costiera, tra Napoli, Sorrento e Castellammare – che hanno altri nomi, inventati, si capirà forse perché – e poi l’entroterra, alle pendici del Vesuvio. I nomi non sono toponimi geografici, ma emotivi, sentimentali, sonori e, talvolta, pure sfottò. Si apre su una casa e prosegue attraverso stanze, affacci e dintorni per varie altre case, appoggi provvisori di parenti, zii invero, di sangue, acquisiti o solo di consuetudine, che offrono riparo, a una donna vedova – lo diventa a un certo punto, prima, semplicemente, il padre vive in un’altra casa, un appartamento, termine mesto, a Roma, impiegato presso il ministero, altra mestizia – con tre figli. Le pezze di damasco splendono nella famiglia della madre, il padre è parvenu, come si capirà abbastanza presto dalla tensione educativa, dalle punizioni grottesche – niente frutta per voi – che ingiunge ai figli.
Chi racconta la storia, si prende in carico la memoria, inventare l’esattezza insomma, è una dei tre fratelli. È colei che si fa pagare dalle amiche per i compiti, che ha i tremori notturni, che accompagna la nonna in una casa, più grande, con più maioliche e più patii, con otri alti quanto lei e, nonostante sia abituata a una serva in casa, una servetta giovane e ingenua come teatro vuole, capisce lì, nella casa della sorella della nonna e dello zio chiuso a scrivere un saggio su Proust e Croce, che esiste la classe sociale. E la classe sociale è fatta di modi e oggetti. Ma soprattutto di oggetti. Che i ricchi, anche solo gli abbienti, o gli agiati, hanno più disgusti che gusti, «che la ricchezza può raffinare, ma mai la raffinatezza produrre ricchezza». La situazione di chi racconta è ovviamente, forse amaramente ma comunque auspicabilmente, la seconda.
Scorrendo le pagine ci si accorge tuttavia che di architettura si parla, e architettura sia, ma le strutture non sono solo muri e archi e patii e maioliche e otri ma pure persone. Il primo capitolo si intitola “La nonna”. La nonna è dunque dichiarata architrave. L’architrave, tuttavia, non è affidabile, è strana, traballa. L’architrave, la nonna, non ha fatto ciò per cui è stata progettata, dagli antichi fino a sempre, e cioè sostenere il riparo, il lastrico. Alla parola lastrico – la copertura, il terrazzo imbiancato a calce o catrame – ha cambiato senso, la nonna è l’architrave rotta del lastrico sì ma in senso economico. La nonna ha sperperato, non è stata in grado di conservare le ricchezze arrivate a lei per eredità dei morti e pure dei vivi (sposata bene, ma rimasta vedova, un treno di vedove), e la nonna continua a sperperare pure mentre la famiglia vive in condizione di sfollata. Troppo olio, troppo zucchero, troppe elemosine. Spuntano nei capitoli pure gli zii – non solo lo studioso proustiano che ordina le saponette a Parigi, ma pure altri, ciascuno, ciascuna con case annessi e attitudini.
La faccenda della cacca, della merda, del piscio, riaffiora, come quella di cimiteri, ville abbandonate e ossa, per tutto il libro. Ha qualcosa di infantile e indomito, serve la cacca per gareggiare e punire, vincere e oltraggiare, ha più una forma che un odore, e già questo è sintomo che la cacca, la merda è un simbolo, più che un fatto, o forse, come dovrebbe essere sempre auspicabile, nell’infanzia i fatti sono simboli e viceversa. Probabilmente, quietamente la cacca è la vita, il detto se non proprio proverbio, della penisola sorrentina dove io pure ho passato – per via dell’origine della famiglia di mia madre – l’infanzia, è: «Roba di culo sanità di corpo». E finché si è sani è possibile agire tutto ciò che alla sanità compete. In realtà, e l’ho imparato scrivendo queste pagine, il detto corretto è: «Tromba di culo sanità di corpo» ma forse ai miei nonni e ai loro fratelli pareva troppo roboante da pronunciare alle orecchie di una bambina. Ma riprendiamo il ragionamento. La cacca è dunque sineddoche e metonimia, la parte per il tutto e il tutto per la parte. La meraviglia della vita che, in parte, coincide con la possibilità della sua marcescenza. Questione che sembrerebbe risolta o svelata nell’esergo penultimo: «Ecco, vi dico un mistero; non già tutti morremo, ma tutti saremo mutati; in un attimo, in un batter d’occhio, al suono dell’ultima tromba» (Brahms, Requiem tedesco).
Nella nostra banda Agnese faceva gli stronzi più grossi, e soddisfatta e sicura sorrideva scuotendo le trecce bionde e pesanti, come santa Genoveffa abitatrice dei boschi. I suoi stronzi erano adorni di bucce di fagioli e di ceci, perché la sua famiglia quasi solo di quello si nutriva, o di estive insalate di patate, pomodori e cipolle. Ma una volta mi presi anch’io la mia rivincita, perché scoprii nel mio stronzo un segmento di tenia, e tutti vennero a vedere come si muoveva a sdipanarsi nell’ancora fumante elemento, sollevandosi come un angelico fantasma, curioso, lustrato dall’aria. E provai una felicità indicibile nel pensare che io, proprio io, avevo dato alla luce quella pallida e mobile essenza.
[…]
La nostra irriverenza non si manifestava solo con un ostile silenzio, ma anche con atti grossolani. Accadeva ad esempio che, allontanatosi lo zio a passo lento dal villaggio per recarsi al belvedere, noi come saette corressimo innanzi, saltando di pezza in pezza, arrampicandoci lungo le rocce, per arrivare prima di lui e lordare di cacate il grazioso parapetto settecentesco, sicché egli, colmo di disgusto, volgendo intorno uno sguardo smarrito, non poteva che ritornare sui suoi passi.
Ho letto Althénopis, la prima volta, nel 1992. In primavera – o questo è il ricordo della stagione – Fabrizia Ramondino era venuta al Liceo Scientifico Leon Battista Alberti di Scauri (che allora stava sul lungomare). Era stata invitata a presentare Storie di patio, una raccolta di racconti che mi aveva, in qualche modo, turbata. Un turbamento senza nome ma che aveva a che fare con gli oggetti che addobbavano le pagine. Soprattutto un orologio in guisa di tartaruga che, ma cito a memoria, pareva, secondo la scrittrice, macinare il tempo. Uscita da quella lettura e dall’incontro con una donna sottile e tentennante nel corpo ma limpida e sferzante nella voce, che sempre fumava, avevo chiesto a mia madre se in casa avessimo altri libri, io non li avevo trovati. Mamma, pure lei con una sigaretta in bocca, si era messa a cercare tra libri che crescevano come concrezioni, in ordine rizomatico, sugli scaffali di mobili che non nascevano librerie ma erano stati colonizzati. Aveva, dopo un po’, tirato fuori Althénopis e me lo aveva allungato, un volume rilegato in verde acqua, senza sovraccoperta, con lo struzzo sul dorso che avevo già cominciato a conoscere.
Così, quando apro e comincio a leggere Althénopis, ammesso fosse primavera, avevo appena compiuto i quattordici anni, portavo i capelli lunghi raccolti in una coda bassa e in disegno tecnico, palla tamburella e latino non mi batteva nessuno. Come spesso accade, i romanzi servono o forse non servono ma così funziona – i grandi romanzi sempre, ma può capitare anche con quelli che della grandezza non hanno nemmeno l’ombra – da manuali di comportamento, galatei. Coincidendo il comportamento col modo in cui la vita si vive e dunque si racconta. E io pure, come la narratrice, non sapevo cosa dire al confessore. Certo rubavo i soldi spicci dalle tasche di chiunque, provavo trasporti coi groppi fisici che il trasporto reca seco verso altre adolescenti e sentivo di dover tacere, picchiavo (più spesso venivo picchiata, ma era la regola della lotta) le mie sorelle e uccidevo insetti, mentivo, ma ero conscia che non fossero davvero peccati, ma manifestazioni di peccati elencati nei comandamenti, in minore. Ero certa che il peccato vero fosse nella mia attenzione, nella frenesia, nel non riuscire a star ferma, nel leggere ciò che mi capitava sotto gli occhi, e chiederne ancora. Althénopis era lo specchio:
Non erano peccati di disobbedienza, come confessavo a don Candido, ma di incontinenza, anche se non sapevo dirglielo, perché non rientrava nel novero delle parole che allora conoscevo.
Sapendo da quella volta e finora – epifania, illuminazione, suggestione, emulazione? – che per tutta la vita il mio peccato sarebbe stato uno e solo uno, l’incontinenza. L’incapacità di contenere rabbia ed entusiasmi, amori e fastidi. Amen.
Tra i più sensuali, fisici, azzarderei sessuali, romanzi italiani, Althénopis squaderna la sua irrefrenabile eccitazione, proprio come Cyrano, attraverso le parole. Le parole di Althénopis toccano e si lasciano toccare. Sudano. Lemmi disinibiti come costumi abbassati nella penombra di una grotta marina che lasciano natiche poco abbronzate a brillare nell’acqua quanto lune. Il bianco anadiomene di un corpo bambino che ha già tutto. Ho impiegato molti anni a capire perché. Dapprima le ipotesi sono state anagrafiche, Ramondino nasce nel 1936, quando pubblica Althénopis, nel 1981, ha quarantacinque anni, è nel pieno delle sue forze, scrive da anni, scrive, fuma e nuota, attività che come lupo capra e cavoli paiono il titolo d’un rompicapo. Non ne ha venti e non ne ha cinquantacinque, tutto può succedere, anche il terremoto, che infatti, alla fine del 1980, aveva smosso pietre e carni. Per molti anni ho pensato questo. Nel rileggere il romanzo, ora che io pure sono nei miei quarantacinque anni, penso che il motivo di questa sensualità, il modo in cui questo libro – per utilizzare un dialogo tra Vincenzo Sanges e Leonor Fonseca Pimentel ne Il resto di niente di Enzo Striano (altro romanzo dove l’asteco chiove e la casa scorre) – «fa scorrere per il corpo umide carezze» è che è un libro di vecchi, bambini e zio Chinchino. I bambini e i vecchi si disinteressano alla forma del corpo, e non da oggi quando il benessere è termine merceologico di palestre e centri estetici, ma da sempre. I bambini e i vecchi usano il corpo, misurano col corpo ciò che possono fare o no, azzardano e falliscono, il corpo è uno strumento di piacere e possibilità, qualsiasi forma esso abbia. I vecchi e i bambini, in Althénopis, rubano le patate bollite che le suore cap’ e’ pezz’ hanno destinato ai maiali e tengono tiepide in una marmitta fuori dal cancello. A quarantacinque anni, col corpo ancora a disposizione, mi preoccupo della forma del mio corpo, e ciò è meno attraente, sottrae disponibilità e possibilità, chiude parzialmente lo sguardo dal mondo a sé. A quarantacinque anni, doveva saperlo pure Ramondino, a metà del guado, i desideri intatti da quando uno ha cominciato a succhiare e che lo rimarranno fino alla tomba, ma ingabbiati in una qualche forma sociale o culturale o in abitudini di sesso e genere, quando insomma il corpo non è più solo ciò che fa e ciò che è ma pure quello che rappresenta in base a ciò che fa o ciò che è.
«Dai, piscia!», gli chiedevamo. Lui si tirava fuori la parte* – così lo chiamavamo noi […].
* Rivivere tutti i fatti raccontati in questa storia mi è costata molta fatica. Rivedere poi il testo per adeguarlo alla memoria e al lettore ha richiesto un certo lavoro. Qui ad esempio nella prima stesura avevo scritto “cazzo”. Si trattava di un pigro indulgere alla moda, segnale anche di una certa senilità di pensiero, e oltretutto di una grave improprietà di linguaggio, perché allora questa parte del corpo, come molte altre cose, non aveva per noi un nome. Veniva infatti chiamata “il fatto”, “il coso”, o “chisto” o “chillo”. Infine era proprio “la parte” o “’o piezzo”, almeno per noi bambine, mentre il resto era il corpo. Parte quindi non del corpo del ragazzo, ma di un corpo cosmico e misterioso. A questa “parte” era associata quindi una numinosità che non può essere resa da termini come “pene”, o “cazzo”, il primo per gli ovvi limiti delle scienze esatte, il secondo perché, come tutto il linguaggio osceno, riduce la numinosità a sola forza bassa e infera, mentre l’ambiguità è una caratteristica essenziale del numinoso.
Sull’ambiguità come caratteristica del numinoso, osservazione, che pur scritta in nota è centrale, si potrebbe aprire, in questa asettica epoca di etichette – purtroppo in gran parte necessarie – una lunga discussione. Senza ambiguità non c’è sensualità e forse nemmeno sessualità, ma tralasciamo questi struggenti interrogativi e torniamo in alveo althenopeo, alla malizia, ai gesti mimati, imitati, dove ogni cosa è sempre qualcos’altro, il rapporto madre figlia, i dolci di marzapane e il prezzemolo.
E io scherzando le dicevo: «Togliti il bolero», ma solo quando eravamo entrati nel recinto delle ville, e lei si schermiva come una giovinetta col fidanzato.
Molti dei suoi amici e frequentatori della casa si drogavano; si divertiva allora a ingannarli, nascondendo fra i suoi fazzoletti e i suoi calzini bustine che imitavano quelle della cocaina, ma che contenevano solo innocue polveri o a volte più dispettosamente, polveri che facevano starnutire. Si faceva confezionare da un pasticciere suo amico cazzi di marzapane, che faceva succhiare alle amiche.
[…] quegli uomini delle famiglie meridionali che in ogni fogliolina di prezzemolo sospettano una mosca, che nel tremolio di una crema temono le sabbie mobili del sesso e bamboleggiano tutta una vita attorno al modo di cucinare della mamma, dalle cui mani soltanto, le creme, le foglioline di prezzemolo diventano fidate.
Althénopis è un romanzo con le note. Da subito esse si presentano come una chiosa ai, una declinazione dei, termini dialettali che, subito, si rivelano storpiature foniche di parole di altre lingue, francese soprattutto, ma non solo. A leggerle meglio, a leggerle tutte, le note non spiegano però le parole, ma i costumi, le abitudini, e, ancora, la classe sociale. Lontane da essere un lessico famigliare – così come nell’omonimo romanzo di Natalia Ginzburg – queste parole funzionano come abiti o aggettivi, caratterizzano chi le usa e chi non le usa, non una relazione, un personaggio. Il dialetto, si capisce, è consentito al popolo e agli aristocratici, va bene per lowbrow e highbrow, nel middlebrow il dialetto è vietato. Il padre, quando torna da Roma, quando dall’appartamento romano scende alla casa di sfollati, non vuole si usi il dialetto. Il padre educa al decoro, il decoro però, come si è detto, grottesco del parvenu.
[Ruoto]. Teglia di rame o alluminio di forma rotonda. È un vocabolo solare e festoso che andrebbe introdotto nel dizionario italiano. Immeschinisce il cibo che esce dal forno la parola “teglia”, che andrebbe però conservata per quei pasticci al forno di sapore intimistico a base di burro e di besciamella; è da escludere nel modo più assoluto invece per i timballi di maccheroni, le pizze al pomodoro, le parmigiane, le alici al gratin, le pastiere, le pizze di scarola e di ricotta.
Ruoto è sexy, teglia no. Queste parole, dunque, in nota – e in ciò sì, somigliano al lessico famigliare – denotano una appartenenza, e non a un nucleo familiare ma a una classe, a un mondo. Come, per tornare a Woolf, a highbrow e lowbrow, ma soprattutto a Tra un atto e l’altro dove i nomi di oggetti, animali e cristiani cambiano nelle stanze di Pointz Hall secondo che si stia in cucina o in salotto, secondo che si ascoltino i servi o i padroni. Si muove Ramondino, tra Woolf e Ginzburg avendo letto quasi certamente entrambe e condividendo la coscienza che le parole utilizzate o no, come i merletti dismessi o no, e certe altre stoffe e i vestiti in genere, mascherano e smascherano.
Per noi veneto significava di stirpe regale.
Questa sensualità, questa fisicità, questa ambiguità numinosa è il motivo per cui ci sono cose in Althénopis, più che in altri romanzi, che non possono essere dette, ma solo lette.
Tutte le persone che ho amato finora somigliano ad Althénopis. Ed è una strana sensazione perché sono certa di aver amato persone prima di leggere Althénopis, anche se non ne ho memoria. Nel senso che so di averle amate, ma non le ricordo. E anche quando mi sovviene un particolare, un gesto o una parola loro, un intercalare, il mio corpo lo riconduce ad Althénopis. Tutte le persone che amo si fermano davanti alle iscrizioni di marmo, alle teste di pietra incastonate nei portali dei palazzi, sui balconi, grottesche o auliche, in attesa che qualcosa o qualcuno si sveli, proprio come fa e spera la voce che porta il racconto di Althénopis. E tanto valga come postilla a queste righe. «Tutto era dunque finito tra me e loro, perché mi negavano le due uniche consolazioni dell’esistenza: la favola e il teatro».
Venezia, gennaio 2023
Chiara Valerio
