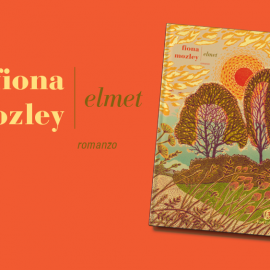Tradurre «Elmet» di Fiona Mozley
• Il blog di Fazi Editore - Parola ai traduttori
In occasione dell’uscita di Elmet, l’esordio di Fiona Mozley finalista al Man Booker Prize, abbiamo chiesto alla traduttrice Silvia Castoldi di raccontarci cosa ha significato per lei tradurre questo romanzo.
Di rado mi è capitato di incontrare un’opera di un esordiente capace di colpirmi con tanta forza fin dalle prime pagine: con il suo senso di catastrofe incombente, con la descrizione di un paesaggio rurale segnato sì dalla presenza umana, ma talmente trasfigurato dallo sguardo dell’io narrante da apparire quasi primordiale; con una scrittura che mescola registri molto diversi tra loro, e in cui spicca il contrasto tra la voce narrante, tutta giocata su uno stile lirico, poetico ed evocativo, e i dialoghi nel dialetto dello Yorkshire, la cui resa italiana ha rappresentato per me una sfida interessante.
E in effetti uno dei protagonisti della vicenda è proprio lo Yorkshire, in cui è ambientata la storia: lì si trovava Elmet, l’ultimo regno celtico d’Inghilterra a soccombere all’invasione sassone, che nella citazione da Remains of Elmet (Resti di Elmet) di Ted Hughes posta a epigrafe del romanzo viene definito una “terra di nessuno”, “un rifugio per chi voleva sottrarsi ai rigori della legge”. Ma lo Yorkshire è anche una terra “fatta di miti”: “storie lacerate che si riversavano verso il basso, marcivano, poi ritrovavano forma e riemergevano attraverso il sottobosco per rientrare nelle nostre vite.” Come quella di “Robyn Hode e il suo branco di sparuti vagabondi, che fischiettavano, si azzuffavano e banchettavano liberi come gli uccelli di cui rubavano le penne.”
È questa la materia mitica di un romanzo che si pone una doppia sfida narrativa: da un lato prendere la leggenda di Robin Hood e ambientarla nel mondo contemporaneo, e dall’altro raccontare una storia che si svolge ai giorni nostri come se fosse accaduta in un momento imprecisato della storia umana.
Ecco allora (“Little”) John, l’uomo gigantesco, il più forte di tutta l’Inghilterra e di tutta l’Irlanda, che si guadagna da vivere partecipando a incontri clandestini di pugilato organizzati dagli allibratori girovaghi della zona, e a un certo punto decide di trasferirsi insieme ai figli in un piccolo angolo sopravvissuto di antica foresta, edificarvi una casa con le proprie mani e vivere con loro in un isolamento quasi completo, cacciando con archi e frecce e raccogliendo i frutti del proprio orto.
John è un personaggio complesso, in cui convivono una potente attrazione per la violenza e un preciso senso etico, che lo porta a servirsi della propria smisurata forza fisica per riparare ai torti subiti dai deboli; il tutto accompagnato da un intenso amore per la natura e gli animali e da un legame forte e profondo con i due figli.
Tra loro, quella che gli somiglia davvero è la maggiore, Cathy, (un’inedita lady Marian, che ci regalerà un finale potentissimo), mentre Daniel, il secondogenito, è molto diverso: esile e tranquillo, per nulla incline al confronto fisico, appassionato di cucina e lavori domestici e con un’identità sessuale ancora in via di definizione. Ed è proprio Daniel (un Robin Hood a cui tocca soprattutto il ruolo di spettatore e di testimone) la voce narrante: il periodo vissuto tra i boschi e il dolorosissimo distacco finale rappresentano le tappe della sua formazione e della sua graduale scoperta di sé.
Perché in realtà, secondo la legge del mondo attuale, la terra che John ha scelto come propria dimora non gli appartiene: le carte dicono che è del signor Price, moderno sceriffo di Nottingham, il più ricco e rapace tra i proprietari terrieri della zona. Per John non ha senso “l’idea che una persona può scrivere delle cose su un pezzo di carta” e “usare la terra come vuole, oppure non usarla per niente e tenere fuori gli altri.” “Il signor Price non se ne fa niente di questi boschi. Eppure c’è un pezzo di carta che dice che questa terra appartiene a lui”.
John si richiama alla legge non scritta di un’epoca ideale e idealizzata: è lui il custode dei resti di Elmet, l’ultimo regno celtico, e con essi dell’“etica dei tempi antichi”. Lo scontro con Price è dunque inevitabile, perché la presenza stessa di John e dei figli rappresenta una sfida al potere di Price e all’ordine sociale su cui tale potere si fonda.
La lotta tra John e Price, tra l’etica precapitalista e quella (post)capitalista, si mescola infatti alle contraddizioni sociali dell’Inghilterra contemporanea: quella dello Yorkshire è un’Inghilterra rurale, povera, isolata, devastata dalla fine del lavoro e dalla proletarizzazione. Così, quando Price minaccia di scacciare lui e i suoi figli, John trova un alleato nell’ex sindacalista Ewart Royce: la lotta individuale di John sembra saldarsi con successo a quella collettiva dei lavoratori e degli inquilini vessati dal caro affitti e dalle condizioni di lavoro imposte da Price e dai suoi sodali (“Pago per vivere in una terra che un tempo era nostra, di tutti noi”, dice una degli abitanti del vicino paese).
Ma nella contrapposizione dei rapporti di potere che attraversa il romanzo esiste, oltre alla lotta per la terra, un’altra dimensione che scorre sotterranea per tutto il testo, riemergendo solo a tratti nelle parole di Cathy e in quelle di Vivien, un’amica di John, la quale rimprovera a Royce di nutrire un desiderio irrealistico per un passato che probabilmente non è mai esistito. “Non era tutto così splendido, non sempre” dice. “Quegli uomini che si riunivano con tanta naturalezza per sostenersi a vicenda tornavano a casa ubriachi e picchiavano le mogli.”
È il rapporto tra i sessi, dunque, il vero nodo irrisolto e irrisolvibile della vicenda: un rapporto di potere basato sulla pura sopraffazione fisica, e su cui la patina superficiale della civiltà non sembra avere sortito il minimo effetto. È un conflitto che monta lentamente per poi esplodere alla fine del libro, in un epilogo drammatico e privo di qualsiasi mediazione possibile. E a Daniel non resta che mettersi in cammino, alla ricerca forse di un fantasma, di sicuro di un’unità e di un’innocenza perdute.
Silvia Castoldi