Tradurre «Io odio Internet» di Jarett Kobek
• Il blog di Fazi Editore - Parola ai traduttori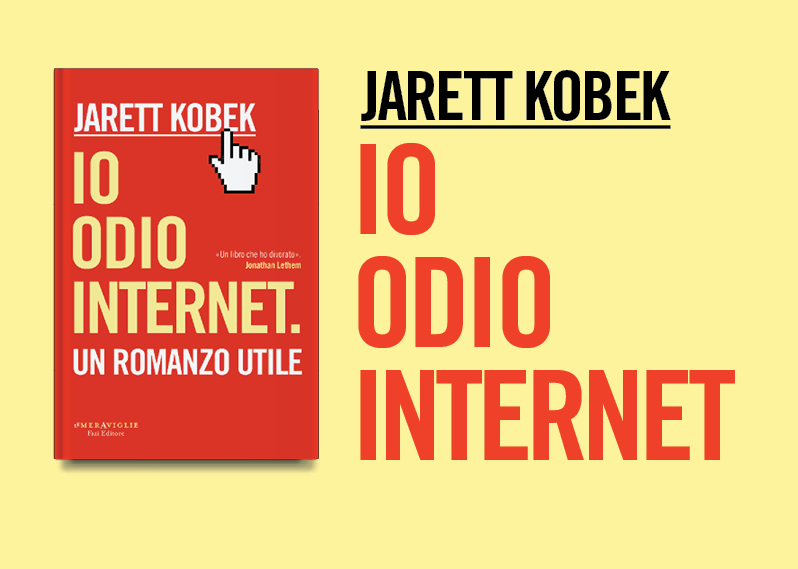
In occasione dell’uscita di Io odio Internet, abbiamo chiesto alla traduttrice Enrica Budetta di raccontarci la sua esperienza con il romanzo di Jarett Kobek.
Che quello del traduttore sia un mestiere che si sceglie solo per amore è fuor di dubbio. Tuttavia, per la mia esperienza, tradurre non è sempre sexy come si usa dire. Le figure della retorica amorosa non sono necessariamente le più adatte a descrivere il processo traduttivo, che a volte non ha proprio niente di erotico e seducente. Tra l’altro capita spesso che il traduttore (almeno questo traduttore) non sia colto da un colpo di fulmine nei confronti del testo che deve tradurre e neanche che se ne innamori piano piano. È semmai più facile il contrario, cioè che la frequentazione assidua e la conoscenza sempre più approfondita mettano impietosamente in luce difetti che a prima vista erano passati inosservati: l’equivalente letterario di un calzino bianco che fa capolino a tradimento quando la gamba dei pantaloni si solleva, insomma. Così anche libri che sulle prime sembravano gradevoli, forse addirittura dotati di un certo potenziale, finiscono per sortire l’effetto di un appuntamento al buio andato male: il traduttore scalpita, è sempre più insofferente e non vede l’ora che la serata, cioè la traduzione, si concluda. Finalmente è ora di tornare a casa.
Poi, grazie al cielo, ci sono le eccezioni e il mio incontro con Io odio Internet di Jarett Kobek è stato l’esatto opposto della situazione che ho appena descritto. È un libro che mi ha fatto mancare la terra sotto i piedi fin dalla prima lettura, smuovendo la mia indignazione, attizzando la mia rabbia e, soprattutto, facendomi morire dal ridere, perché è la disamina più esilarante e caustica, oltre che lucida e realistica, che mi sia capitato di leggere sulla cultura tecnologica e il mondo contemporaneo in generale. Mi ha aiutato a mettere a fuoco ciò che io stessa confusamente avvertivo nei confronti dei social media, per Kobek piattaforme create da nerd con l’intelligenza sociale di un dodicenne, miliardari in felpa con il cappuccio come Mark Zuckerberg, che hanno preso «l’utopia originaria di Internet» e l’hanno traviata, «trasformandola in una serie di feudi aggrovigliati che non hanno nessun altro scopo se non propinarci pubblicità». Mi ha fatto riflettere su quanto sia risibile l’idea stessa di attivismo digitale, a colpi di opinioni espresse su una «piattaforma di proprietà di un gruppo di tizi bianchi», dove «tutti fanno di tutto una crociata morale», senza che questo abbia un impatto concreto sul mondo reale, tra l’altro fingendo di dimenticare che «queste lezioni di etica» vengono «impartite attraverso computer e telefoni cellulari fabbricati in Cina da manodopera schiavile». Ho trovato geniale il pensiero che la condizione degli utenti di Internet non sia diversa da quella dei padri fondatori del fumetto americano, primo tra tutti Jack Kirby, che venivano ignobilmente sfruttati dalle case editrici per cui lavoravano: «Internet e i conglomerati di multinazionali che lo dirigono ci hanno condannati tutti al peggiore dei destini possibili. Ci hanno trasformato in fumettisti che sfornano contenuti in serie per monoliti enormi che si rifiutano di pagarci il nostro lavoro per ciò che vale davvero». E ovviamente non ho potuto che essere d’accordo su un tema forse più marginale nel libro, ma che per ovvie ragioni mi tocca da vicino: la constatazione che le prassi dell’industria americana del fumetto sono diventate il modus operandi anche di molte altre, che hanno ridotto i «creativi in generale […] a ingranaggi in una catena di montaggio», costretti a soggiacere a condizioni di lavoro umilianti da «una scorta pressoché infinita di freelance sempre pronti a offrire i propri servigi».
Queste tesi sono veicolate attraverso una scrittura che imita «la rete informatica nella sua esposizione incongruente e frammentaria dei contenuti», infarcita di giochi di parole, invenzioni lessicali, citazioni più o meno scoperte che, nella fase di traduzione, mi hanno costretto a più di qualche acrobazia, così come è stato inevitabile riflettere su come alcuni termini (penso per esempio al serbatoio linguistico del razzismo) riecheggino diversamente in un contesto storico e sociale differente da quello di partenza, rendendomi più che mai consapevole del ruolo di mediatore culturale del traduttore. Inoltre, poter essere a tratti impunemente volgare – come quando ho dovuto prestare le parole a Mehemet, il padre di uno dei protagonisti, per farlo imprecare in italiano (nell’originale, oltre che in inglese, lo fa in spagnolo e in turco) –, politicamente scorretta – per esempio nell’irridere i nuovi dei della Silicon Valley, non ultimo il defunto Steve Jobs – e sarcastica e mordace – è il caso dell’esilarante descrizione del cosplayer quarantacinquenne travestito da Thor a una convention di fumetti – è stato davvero liberatorio.
Non è stato sempre facile, ma è stato bello, tanto che con questo libro io ho smesso di guardare l’orologio: sarei rimasta volentieri a farci altre quattro chiacchiere e a bere l’ultimo bicchiere di vino, rinviando ancora un po’ il momento di tornare a casa.
Enrica Budetta
