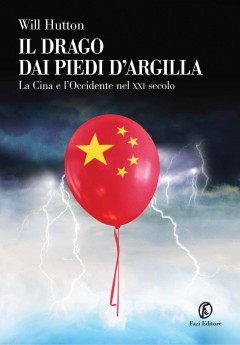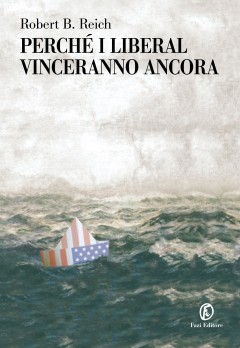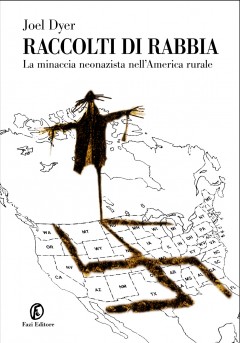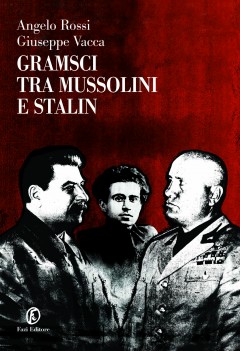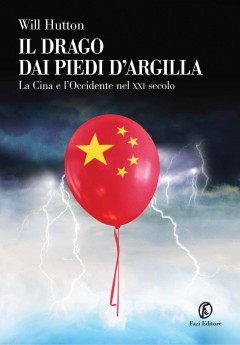
Will Hutton
Europa vs. Usa
Perché la nostra economia è più efficiente e la nostra società più equa
Traduzione di Fabrizio Saulini
Prefazione di Guido Rossi
Con un saggio di Massimiliano Panarari
«Le tesi di Hutton sono un macigno che cade nella palude delle provinciali e stantie elucubrazioni di molti nostri autoproclamati riformisti di sinistra e di destra. Il riformismo nostrano è, infatti, spesso appiattito sull’esaltazione di un acritico e malinteso trapianto di istituti e ideologie proprie del nuovo capitalismo finanziario nordamericano, che nel “dio mercato”, nella deregolamentazione, nell’unica regola posta dall’economia privata, nella privatizzazione del diritto, in cui tutto si affida alla volontà delle parti, hanno prosperato prima e sono naufragati poi con il fallimento della dittatura dei mercati finanziari. Mercati senza regole, senza freni e che obbediscono solamente alla volontà e agli interessi di individui sempre più spregiudicati. E tutto avviene in un gioco capace solo di creare squilibri difficilmente correggibili e irrimediabili ingiustizie sia a livello di economia mondializzata, sia nelle vicende di politica internazionale. La presunta razionalità assoluta dei mercati, già storicamente contestata da Fernand Braudel, sta alla base di queste nuove tendenze e costituisce peraltro l’armamentario intellettuale delle tesi più conservatrici e retrive oggi in voga negli Stati Uniti. Quelle, per intenderci, che hanno portato al fallimento di Enron, Arthur Andersen, WorldCom e via dicendo, e, mentre scrivo, al ben più grave fallimento del vertice di Cancun. […] Quella di Will Hutton è una ricerca che affonda i suoi artigli nelle più riposte radici della cultura europea. Più riposte perché vive soprattutto in quei settori che l’opinione pubblica anche colta tende a trascurare. Ed è ancora un inno all’Europa, per il quale dobbiamo essere grati all’autore, che ci ha consegnato una testimonianza di giustificato ottimismo sul nostro destino».
dalla prefazione di Guido Rossi
– 11/01/2004
Ma in Europa il contratto sociale funziona meglio
Negli Stati Uniti il 2003 è stato l’anno dei conservatori. E’ prevalsa la dottrina della guerra preventiva, che ha portato alla guerra e alla vittoria militare in Iraq e al recente disarmo annunciato dalla Libia di Gheddafi. Non solo: le vittorie di carattere: politico e strategico sono arrivate mentre continuava l’eccezionale crescita della produttività iniziata nell’economia americana in parallelo con la rivoluzione di Internet negli anni Novanta. E mentre l’Europa sembra prigioniera della stagnazione economica e politica.
Proprio in questo periodo è uscita la traduzione italiana di un libro destinato a diventare la Bibbia dei filo-europei. L’autore dei libro è Will Hutton, opinionista e intellettuale inglese di centro-sinistra. Blairiano della prima ora e da lungo tempo fautore della modernizzazione della sinistra insieme con Anthony Giddens, rettore della London School of Economics, Hutton formula efficacemente già nella prefazione l’obiettivo principale del suo lavoro: “per troppo tempo in Gran Bretagna nessuno ha difeso la causa dell’Europa. Il mio è un tentativo di colmare questa lacuna”.
Fa questo in due modi: sottolineando le ombre del successo americano e concentrandosi sugli aspetti positivi dell’esperienza europea. Negli Stati Uniti dei Neocons – sostiene Hutton – la democrazia è diventata sempre meno inclusiva e le sempre più spiccate divisioni etniche e differenze di opportunità hanno fatto perdere di vista il concetto stesso di collettività e di istituzioni pubbliche. Anche in campo economico, i successi di produttività sono avvenuti in parallelo alla distruzione di posti di lavoro e al prezzo di un ulteriore aumento di già ampie disuguaglianze distributive. Nella “vecchia” Europa, invece, imprese “sociali” come Volkswagen, Michelin e Nokia – per cui la massimizzazione del valore di Borsa delle azioni è solo uno dei vari obiettivi dell’impresa – sono riuscite a prosperare fino a diventare leader europee e mondiali. E l’europea Airbus, per il solo fatto di esistere, impedisce alla Boeing di lucrare profitti monopolistici alle spalle dei viaggiatori di tutto il mondo. Il sistema europeo ha dimostrato di poter assicurare elevati livelli di produttività, abbondante manodopera qualificata, creatività organizzativa e un’alta protezione sociale per i più deboli. Insomma, conclude Hutton, il contratto sociale europeo funziona, quello americano no.
WilI Hutton non è il solo a sostenere queste tesi: il finanziere George Soros e l’economista di Stanford Paul Krugman hanno in passato criticato il modello americano con argomentazioni molto simili a quelle usate da Hutton. E la difesa d’ufficio dell’Europa è già stata sostenuta, tra gli altri, dal giurista italiano Guido Rossi (che scrive la prefazione al libro di Hutton) e recentemente dall’economista francese Olivier Blanchard. A queste autorevoli opinioni si è aggiunta, da un anno a questa parte, l’opinione dei mercati finanziari, dove l’euro continua ad apprezzarsi nei confronti del dollaro.
Nel complesso, il libro di Hutton non contiene tesi davvero originali (ma non era questo lo scopo del libro, del resto), ma ha il pregio di riprendere, documentare in modo efficace e mettere insieme una varietà di argomentazioni già discusse in ambiti disciplinari più specifici. Vale dunque senz’altro la pena di leggerlo. Se, a partire dalle sue tesi, si possa concludere che tutto vada bene per l’Europa, rimane una questione fortemente controversa, specie avendo in mente le attuali difficoltà dell’industria europea e i recenti insuccessi nel processo di integrazione.
– 03/04/2004
Per non andare verso il modello americano
La Statua della libertà, di spalle, più massiccia di quanto ci appaia di solito, sembra impugnare la fiaccola come una spada sguainata. Di fronte ad essa la Torre Eiffel e il campanile del Big Ben si stagliano sullo sfondo di un cielo livido e incendiato. La cifra figurativa della copertina di Europa vs. America. Perché la nostra economia è più efficiente e la nostra società più equa (a cura di Massimiliano Pananari, con la prefazione di Guido Rossi) riflette bene la metafora agonistica scelta per il titolo dell’edizione italiana di questo volume di Will Hutton, già destinato a diventare un classico nell’analisi delle relazioni internazionali in questo inizio di secolo.
Per rendersi conto del calibro scientifico dell’autore è sufficiente leggere la densa nota bio-bibliografica di Massimiliano Panarari in appendice al volume. I lettori di “Reset” hanno già potuto avvicinare il suo pensiero grazie alla traduzione di Global Capitalism, un testo sull’americanizzazione dello spazio globale steso da Hutton assieme ad Anthony Giddens e uscito con il numero 61 (luglio-agosto 2000) di questa rivista: già all’epoca le strade dei due massimi teorici della Third way laburista si erano divise, peraltro, con il progressivo smarcamento di Hutton dagli indirizzi di un blairismo da lui ritenuto sulla china dell’abbandono della vocazione fabiana ed egualitaria della sinistra britannica in favore di un’acquiescenza fattiva nei confronti degli interessi delle grandi corporation e delle sirene del neoliberismo d’Oltreatlantico.
Europa vs. America si configura innazitutto come un appello rivolto alla Gran Bretagna perché si svincoli dal sostegno indiscriminato al Washington consensus e dall’acquisizione pura e semplice del modello economico e sociale americano, per riconoscere piuttosto la propria naturale vocazione europeista. Ma sarebbe fuorviante limitare a questo un libro che si distingue per un impianto analitico di vastissimo respiro. L’autore, cresciuto alla scuola del neocontrattualismo di John Rawls e sostenitore di un’idea positiva dello Stato come attore imprescindibile della redistribuzione del reddito e delle opportunità sociali, ci guida infatti in un lungo percorso attraverso le origini storiche e ideali di quelli che allo stato attuale si presentano non soltanto come due modelli contrapposti di produzione di valore e di risoluzione dei conflitti, ma come due vere e proprie antropologie, come “due Occidenti” affacciati sullo scenario mondiale di una crisi i cui contorni ci sembrano sfuggire. Dall’esame delle radici del dogma peculiarmente americano della proprietà privata a quello delle ragioni della vittoria della concezione neoliberista della missione dell’impresa come creazione esclusiva di valore azionario, dalla parabola del progressismo americano dalla guerra civile al suo tramonto negli anni del Vietnam alla lucida descrizione dell’allargamento della forbice della diseguaglianza negli Stati Uniti, sino all’indagine sul paradigma industriale europeo, sull’integrazione della Ue e sul ruolo dell’euro, Hutton ci conduce all’ammissione di uno stato di fatto di drammatica semplicità: “Il mondo è a un crocevia. Gli Stati Uniti, l’unica vera iperpotenza mondiale, sono schiavi dell’ideologia conservatrice e delle sue risposte particolaristiche alle questioni economiche, sociali e di sicurezza” (341).
Nessun pessimismo apocalittico, tuttavia. La tesi di fondo del volume è che “non possiamo tutti conformarci ai principi del conservatorismo americano. In altre parole, il mondo ha bisogno di organizzarsi secondo un diverso sistema di valori e una leadership che dimostri una maggiore generosità e più rispetto delle diversità di quella rappresentata dalla destra americana. L’unico blocco che dispone di sufficiente forza politica ed economica per perseguire questo obiettivo è l’Europa” (32-33). Conclusione di questo dissimulato sillogismo, l’Europa ha la “responsabilità globale di porsi come contraltare agli Stati Uniti nella costruzione di un ordine mondiale più illuminato e progressista” (ibid.) – una sorta di nuovo white man’s burden in chiave democratica e riformista.
La via d’uscita da questo paradigma di conflitto perenne – improntato alla griglia binaria amico/nemico nella lettura della complessità e sostanziato dalle impressionanti capacità d’intervento militare americano – può essere imboccata, secondo Hutton, soltanto con il rovesciamento dell’odierno equilibrio di rapporti tra le due sponde dell’Atlantico. L’Europa, cioè, anziché omologarsi agli imperativi del conservatorismo e di Wall Street, deve porsi a polo d’attrazione in grado di resuscitare l’antico spirito liberal degli Stati Uniti, oggi impotente di fronte all’offensiva globale della destra.
– 21/04/2004
Europa e Usa poli della sfida
UN TEMPO appariva obeso, ora rischia di diventare anoressico. Una dieta ferrea, messa a punto nel corso degli anni Ottanta, ha ridotto sin quasi ad annullarlo il peso dello Stato in economia. Erano le scelte politiche dei governi a scandire le regole in molti settori strategici prima della rivoluzione imposta da Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Poi si è sperimentata una regola opposta, privilegiando la dinamicità privata. Il mercato, promettevano gli esperti, avrebbe garantito ai cittadini maggiore efficienza e minor costo. Un’ottima idea o, invece, una scommessa rischiosa? A larghissima maggioranza gli studiosi che hanno offerto un bilancio dell’esperienza liberista lodano le linee generali del progetto, ma sottolineano i pericoli legati ad una sua applicazione troppo rigida. Precisando che se lo Stato non ha più alcuna ragione per ricoprire un ruolo dominante nei comparti industriali, è invece decisivo mantenere il controllo pubblico nell’ambito dei servizi.
Trasporti, sanità, welfare e istruzione, rileva il britannico Will Hutton nel volume Europa vs Usa (proposto pochi mesi fa in Italia da Fazi), offrono agli utenti risultati di gran lunga migliori se continuano ad essere gestiti dai governi, mentre le privatizzazioni di questi settori si sono rilevate spesso fallimentari su entrambe le sponde dell’Atlantico. Dello stesso avviso è Paul Krugman, docente di economia a Princeton, che nel suo ultimo libro ( La deriva americana , tradotto ora da Laterza) sostiene che le teorie care ai fondamentalisti del mercato hanno fatto soprattutto crescere i profitti delle grandi imprese, senza produrre risultati concreti sulla qualità delle prestazioni erogate ai cittadini e sui conti pubblici.
Un eccesso di liberismo, avverte infine Anthony Sampson in un saggio appena uscito a Londra ( Who Runs This Place? The Anatomy of Britain in the 21st Century , edito da John Murray), ha provocato danni che vanno riparati in fretta. Senza cadere nella tentazione di riutilizzare antiche ricette ormai fuori tempo, ma trovando un efficace punto di sintesi in grado di garantire il dinamismo del sistema imprenditoriale e l’efficienza dei servizi. Con un “rapporto virtuoso tra pubblico e privato”.
– 01/04/2004
Nostalgie liberal
Difficile oggi immaginare un libro più controcorrente di quello scritto da Will Hutton, giornalista e commentatore inglese di formazione economica, attivo in istituzioni e centri di ricerca, sodale di Anthony Giddens ai tempi in cui questi elaborava l’agenda del New Labour di Tony Blair. Hutton prende infatti di petto quelle che di solito sono considerate come verità assodate del senso comune contemporaneo, come la capacità degli Stati Uniti di generare una crescita economica ben più elevata di quella europea, il declino del nostro modello sociale a fronte della vitalità di quello americano, il legame naturale che induce il Regno Unito a ricercare la collaborazione con gli Usa, allontanando il paese dall’area dell’euro. Per il suo passato e la sua cultura, Hutton è tutt’altro che pervaso da un sentimento antiamericano. Ma non lo convincono i capisaldi della rivoluzione conservatrice realizzatasi negli Stati Uniti durante l’ultimo quarto di secolo. A suo giudizio, la sconfitta della tradizione liberal (che ricostruisce geneticamente in alcune fra le migliori pagine del libro) ha finito col produrre una società intrisa di disuguaglianze, alla lunga in grado di ripercuotersi sul tasso di efficienza dell’economia americana. In parallelo, Hutton sostiene che gli inglesi hanno sbagliato a seguire le orme dei governi d’oltreoceano, allineandosi alle loro politiche internazionali e sociali. Meglio sarebbe per loro volgersi all’europa e aderire ai principi che Jacques Delors (il vero eroe positivo della storia che delinea Hutton) ha indicato nella sua opera di costruzione di uno spazio continentale integrato riuscito soprattutto nella parte in cui ritrae il volto dell’america di fine Novecento, il libro di Hutton è più debole nella difesa di un’Unione europea ormai distante dalla traccia di Delors. Ma merita di essere letto per la ricchezza degli spunti critici che dissemina e per la tesi della necessità di un nuovo contratto sociale e istituzionale.
– 07/12/2003
Che disastro se l’America non è progressista
Sono due modelli antitetici. Il primo teorizza la supremazia dell’individualismo, prevede la tutela della libertà di commercio e dei diritti di proprietà, il secondo privilegia l’interesse pubblico, la coesione sociale, l’importanza delle politiche di welfare. Tra la visione del futuro messa a punto nel cordo degli ultimi anni a Washington e quella che, invece, trova sostenitori nelle capitali del vecchio continente Will Hutton non ha dubbi. Il progetto di cui di discute a Parigi, a Berlino o a Londra, afferma, offre maggiori garanzie di promuovere una crescita economica capace di garantire uno sviluppo più equilibrato, sia sul piano interno che internazionale. Lo studioso britannico – firma di punta del Guardian e dell’Observer e, insieme ad Anthony Giddens, tra i principali teorici della Terza Via blairiana – spiega in dettaglio i motivi della sua scelta in Europa vs Usa (Fazi, 413 pagine, 23.50 euro), un denso e interessante saggio che esce in Italia accompagnato da una nota introduttiva di Guido Rossi e da un profilo dell’autore a cura di Massimiliano Panarari.
Avversario dell’unilateralismo e del pensiero dei neocons che piace alla Casa Bianca e a gran parte dell’amministrazione repubblicana, Hutton sostiene che “non può esserci un ordine planetario autorevole senza l’America”, ma aggiunge che “senza un’America più progressista non può esserci alcuna stabilità di questo genere”. Servirebbe, dunque, una gestione politica meno dogmatica per guidare i processi economici, i rapporti tra gli Stati e la lotta al terrorismo. A giudizio di Hutton, un contributo di fondamentale importanza potrebbe venire dall’Europa, che nel corso dell’ultimo mezzo secolo è riuscita ad ottenere ottimi risultati grazie al dialogo continuo tra le imprese e i governi, decisivo per garantire la pace sociale e per offrire opportunità agli strati più deboli della popolazione.
Perché questa strategia trovi anche a Washington un’accoglienza favorevole, sottolinea Hutton, è indispensabile che negli Usa torni ad acquisire forza e consenso, prima delle elezioni presidenziali del 2004, l’anima “liberal” del Paese. Con un democratico alla Casa Bianca al posto di Bush i rapporti tra le due sponde dell’Atlantico potranno migliorare, i rispettivi modelli avranno minori difficoltà ad integrarsi, afferma lo studioso. Che, concludendo la sua analisi, avverte: “Il rapporto tra Europa e America costituisce il fulcro dell’intero ordine mondiale. Se viene gestito in modo efficace, può rappresentare una grande forza virtuosa. In caso contrario può essere la fonte di danni incalcolabili”.
– 20/12/2003
Hutton, teorico della Terza Via, vorrebbe un altro Blair
Roma _ Fare o non fare prigionieri. Pruderies per ondivaghi o pavido conigliume? A questi generi non appartiene di certo Will Hutton, l‚opinionista politico economico dell‚Observer e del Guardian, già teorico della Terza Via blairiana che pensò con l‚amico Anthony Giddens a favore dell‚ex amico Tony Blair.
Le amicizie, come l‚amore, finiscono. Non fanno eccezione le relazioni politiche: come le foglie, ai primi rigori del gelo, cadono. Hutton spiega al Foglio perché, oggi come oggi, condivide con se stesso la sua britannica attitudine di fare prigionieri: „Insisto. Fare prigionieri significa credere nel confronto‰. In poche parole, l‚accusa di Hutton a Blair è di essersi piegato come un giunco alla politica estera imposta dall‚altra sponda dell‚oceano, mentre avrebbe dovuto agire molto più in sintonia con l‚antico e nobile spirito guerriero che c‚è in ogni vero British, salvandosi meglio la faccia.
Hutton, che attualmente dirige la Work Foundation di Londra, un pensatoio di politica internazionale molto in, ha appena pubblicato in Italia „Europa vs. Usa‰ (Fazi Editore), dove vs sta per versus, con tutta l‚aria di voler fare discutere.
„Nessuna politica, nemmeno di sinistra, può stare solo sulle difensive. Nei paesi teocratici, la secolarizzazione è vista come il nemico e la democrazia è aspramente combattuta. Allo stesso tempo, però, non dobbiamo rinunciare all‚idea che anche quei paesi possano attraversare un cambiamento storico. Solo che occorre comprendere che chi si assume questo compito, deve accettare il fatto che ci vorrà moltissimo tempo. Sono convinto che anche per i paesi islamici ci sarà una fase di cambiamento che potremmo chiamare di nuovo illuminismo‰.
Hutton non è dunque del tutto contrario al ruolo che il Regno Unito ha avuto nella guerra contro Saddam, ma non ne condivide il come. Afferma, infatti, che: „Gli interessi britannici e quelli americani sono esattamente gli stessi. Non si può accettare, però, che il modello di giustizia sociale sul quale si era fondata l‚ascesa di Blair sia stato necessariamente accantonato per assecondare, senza appello, la chiamata alle armi di Bush‰. E‚ su questo „necessariamente‰ che Hutton mette i puntini sulle i: „La caratteristica irrinunciabile che possediamo noi europei sta nell‚arte della mediazione. Sacrificare questo significa rinunciare a noi stessi, alla nostra tradizione illuministica‰. Sono solo sfumature? „Ci sono valori comuni a tutto l‚Occidente: la certezza del diritto, la democrazia, la tolleranza religiosa, l‚idea che il mercato e il profitto siano le migliori precondizioni per un‚economia forte, ma il neoconservatorismo americano è troppo ideologico‰.
Quel vs che Hutton mette fra Europa e America, però, sembra una guerra di civiltà. Ne vale la pena? „La mia insistenza sull‚esigenza di fare prigionieri si rivelerà giusta soprattutto in campo economico _ sottolinea Hutton _. Faccio un esempio. La Airbus, che rappresenta la massima espressione dell‚approcio europeo alla produzione tecnologica in fatto di aeromobili civili, ha superato la crisi grazie a un consorzio di paesi che hanno appoggiato un piano di sussidi di stato a lungo termine. Fattori che per noi sono la quintessenza dell‚idea d‚impresa nel Vecchio Continente. Un‚idea di „public‰ ovviamente criticata dai neoconservatori americani che la ritengono protezionistica, oltre al fatto che, necessitando di un piano di lunga durata, non permette di conseguire rapidamente il big business. Dopo l‚11 settembre, però, è entrata in crisi la Boeing, che veniva sostenuta da Washington attraverso la lobbing degli appaltatori. Un meccanismo di sovvenzioni pubbliche considerato legittimo negli Stati Uniti e che non prevede di dover sottoscrivere un piano di ristrutturazione d‚impresa, poiché i loro mercati finanziari non lo accettarebbero mai. Con l‚11 settembre il Congresso ha firmato un accordo che prevedeva a fronte di 20 miliardi di dollari, l‚affitto all‚aviazione militare americana di cento nuovi jumbo 767, altrimenti invendibili. Quello che dico io è che la Boeing è un cliente del governo tanto quanto lo è l‚Airbus. Però la Airbus, a differenza della Boeing, non accusa sbalzi di produzione a causa dei tagli imposti da Wall Street‰.
Il consorzio europeo che sostiene l‚Airbus con risorse finanziarie a lungo termine guarda ai profitti con una prospettiva trentennale e non triennale. Secondo Hutton, quindi, è stata data la priorità alla costruzione degli aerei, alla conquista del mercato, alla soddisfazione del cliente, e non al pagamento dei dividendi. In economia, dunque, vince Prodi su Bush? „Oggi la Airbus è il primo costruttore di aerei al mondo. E‚ provato: il sistema funziona meglio‰ sornioneggia Hutton.
– 08/02/2004
POLITICA USA E GUERRE DEL FUTURO
Del volume: Europa vs Usa – Perché la nostra economia è più efficiente, la nostra società più equa – è autore Will Hutton. L’editore è Fazi. Consiglio la lettura di questo libro. È proprio indispensabile leggerlo. Chi non lo legge sa poco o vuol sapere poco dei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Esistono saggi a riguardo, ad esempio quello di Kupchan, ma Hutton è più articolato e con passione di europeo. Hutton, dati alla mano, e mi dispiace di doverne parlare stringatamente, mostra che la prosopopea dell’economia americana nei riguardi dell’Europa è un falso. È un falso la maggiore produttività, un falso il maggior benessere, un falso la disoccupazione minore. Non posso, ribadisco, riferire quel che Hutton mostra, il lettore provveda da sé. Hutton ritiene che l’Europa ha un modello economico non solo efficiente ma anche socialmente più garantivo. E questo perché in Europa, lo dice Hutton, la massimizzazione del profitto non è arrivata agli strenui degli Stati Uniti, ove essa porta, per avere ampi spartizioni di utili e di vantaggi a breve termine, a nessun riguardo per il futuro e per i ceti deboli. Hutton è assolutamente a favore della moneta europea unica e ritiene addirittura che questa moneta europea unica quanto prima sostituirà il dollaro con ripercussioni sulla potenza degli Stati Uniti devastanti. Ma è sul sociale, sul fatto che l’Europa rispetta ancora il sociale che Hutton si dimostra brillante e veritiero. Una società che rovina il sociale è una contraddizione in termini. Una società in cui l’individuo non ha alcuna protezione dalla società ma deve rincorrere un posto di lavoro di qua e di là, deve provvedere alla salute o non provvedervi, addirittura, ebbene una società del genere per Hutton è un disastro che prima o dopo avrà ripercussioni capitali per tutto il mondo. Questo è il senso del libro, in ultima analisi: che il modello americano porterà prima o dopo a guerre, solitudine, tensioni sociali insostenibili, crollo dell’economia per eccesso di utili che finiranno con il necessitare di bilanci alterati o di un’alterazione dell’economia. Lo sguardo che Hutton ha verso l’Europa forse può anche essere troppo benevolo. Ma nella comparazione tra Europa e Stati Uniti, e Hutton fa questa comparazione con dettagli minuziosissimi, non c’è proprio da dubitare.
– 03/02/2004
Il giornalista britannico Will Hutton afferma il primato del modello economico europeo su quello statunitense
Europa versus Usa
È un atto di fede e d’amore, un orgoglioso segno di appartenenza ed un confortante messaggio di speranza quello che Will Hutton lancia dal suo ultimo saggio, Europa versus Usa. Perché la nostra economia è più efficiente e la nostra società più equa (Fazi editore, pp. 413, euro 23,50). Il severo Financial Times ha definito Hutton quale il miglior giornalista del centro-sinistra d’Inghilterra. Promotore del programma del New Labour all’avvento dell’èra blairiana, salvo distaccarsi dal premier per la di lui eccessiva accondiscendenza alle idee neoliberiste, presidente della Work Foundation, pensatoio dove si incontrano le istanze dei manager e quelle dei lavoratori loro dipendenti in nome della dignità del lavoro britannico, il giornalista britannico lancia un grido d’allarme contro la deriva neoliberista che si è impossessata dell’economia e della politica degli Stati Uniti. E traccia una disamina lucida ed originale del modello europeo e di quello statunitense, per affermare il primato del primo sul secondo. Hutton è allibito dalla sudditanza del pensiero economico e politico europeo e in primo luogo britannico, alle teorie, o meglio, ai falsi miti, del monetarismo e del neoconservatorismo d’oltreoceano. Il saggista non si limita a guardare al presente, ritorna al passato, consapevole degli immensi meriti degli Stati Uniti per la causa della democrazia. Ripercorre le vicende che hanno portato agli accordi di Bretton Woods, quando ancora infuriava la guerra contro il nazismo, fino allo sganciamento della parità dollaro-oro, con i conseguenti dissesti sui mercati mondiali. Prende in esame gli anni della deregulation e ne sottolinea l’apparenza più che la realtà autentica dei trionfi economici.
Viene all’oggi e stigmatizza i punti deboli dell’economia degli Stati Uniti, le paurose contraddizioni di quel sistema, le disuguaglianze sociali, le sperequazioni dilaganti.
Uno dei principali motivi della fragilità odierna degli Stati Uniti è per Hutton la dittatura della borsa. I managers badano soprattutto a rendere soddisfatti gli azionisti con lauti dividendi. Tutto ciò che conta è che i titoli si apprezzino, il resto viene dopo. L’obiettivo viene spostato dal lungo periodo al breve e, quel che più rileva, dalla produzione alla finanza. Così ad essere trascurato è quel che gli addetti ai lavori chiamano il core business , l’attività vera e propria dell’azienda.
Generalmente il primo passo compiuto dai managers è ridurre i costi del personale, tagliare posti di lavoro. Poi si passa a ridurre l’investimento nella ricerca. Sul medio lungo periodo l’azienda non potrà che restarne danneggiata.
L’esempio che adduce il giornalista inglese è quello dell’americana Boeing, la cui concorrente europea è la franco britannica Airbus. Per anni gli utili degli azionisti della Boeing sono cresciuti costantemente, ma a forza di tagli l’azienda aereonautica americana si è trovata letteralmente in ginocchio, addirittura impossibilitata a proseguire la produzione.
Di segno completamente opposto è la storia dell’Airbus, attuale leader mondiale della produzione aeronautica. Nasce nel 1967 da un consorzio pubblico franco britannico germanico. Ovviamente i capitali impegnati sono notevolissimi e dopo breve tempo la Germania si stacca dall’iniziativa. Ma sul lungo periodo arrivano i frutti ed oggi Airbus domina incontrastata la scena mondiale.
Ecco dunque un esempio di fallimento della politica neoconservatrice, per non parlare delle acquisizioni selvagge compiute solo per conferire maggior valore ai titoli o della devastante privatizzazione compiuta nel campo delle telecomunicazioni in cui un solo nome dà la misura del disastro: Enron. A smentire la tesi della superiorità delle imprese americane su quelle europee Will Hutton spiega tre casi: Volkswagen, Michelin, Nokia.
Per passare al campo sociale, ai detrattori del Welfare europeo bisogna far presente che negli Stati Uniti, il Paese maggiormente all’avanguardia nel campo della medicina nel mondo, 43 milioni di cittadini sono sprovvisti di qualsiasi forma di assicurazione sanitaria. E che dire dei numeri della popolazione carceraria americana? Gli Stati Uniti danno il 5% della popolazione mondiale ed il 25% della popolazione carceraria del mondo. Per Hutton, ora, c’è bisogno dei valori fondanti dell’Europa. Ne ha bisogno la Gran Bretagna, che al di là della lingua comune agli Usa è parte dell’Europa Unita, ed il mondo. E’ necessario dare alla globalizzazione i contenuti del Welfare, non quelli dell’iperliberismo neoconservatore. Il Fondo monetario internazionale deve cessare di essere la longa manus del Tesoro americano, con le sue direttive monetaristiche, che hanno “strangolato” Estremo Oriente ed Argentina nel momento in cui erano più deboli. Il primo a dirlo è il suo ex numero due, Joseph Stiglitz, premio Nobel per l’economia. Per Hutton insomma più Europa significa più giustizia sulla Terra.
– 17/12/2003
Parla Will Hutton, in Italia il suo ultimo libro. Il fiato corto del liberismo
Della critica al modello di società americana, al primato assoluto
dell’impresa, ha fatto un cavallo di battaglia militante e teorica – anche se in lui resta ferma la fede che da qualche parte possa esistere un capitalismo più equo e giusto. E’ nei paesi europei che Will Hutt – osservatore politico-economico ed ex teorico deluso della Terza Via blairiana, a Roma per promuovere il suo ultimo libro Europa vs. Usa (Fazi Editore, pp. 413, euro 23,50) – vede la via a un economia capace di coniugare efficienza ed equità.
Il modello americano di società è basato sulla preminenza del profitto individuale rispetto agli interessi della collettività. La tesi, da lei sostenuta, è che proprio questo modello comporterebbe, nel lungo periodo,effetti fallimentari per l’economia. Perché?
Ci sono alcuni settori dell’economia americana che funzionano, come le nuove tecnologie informatiche o la difesa – campi che godono degli investimenti del governo. Sarebbe troppo semplicistico parlare di un fallimento totale.
Però esistono vere e proprie falle in altri settori. Nei rami della produzione automobilistica, aerospaziale, nell’industria farmaceutica e così via, si registra un forte calo. Qui l’economia statunitense è in grave deficit. Nel libro cerco di contrastare quell’idea dominante nel senso comune secondo cui in America andrebbe tutto bene, mentre in Europa tutto male. Degli Stati Uniti si ha un’immagine di onnipotenza, mentre si ignora che l’Europa è, per molti versi, più avanzata degli Usa sul terreno
economico. Molte società americane come la Ford sono in una cattiva situazione, non sono produttive, gli operai lavorano in condizioni disumane – tant’è che rischiano il fallimento. Per indice di produttività Francia, Germania, Nord Italia, Danimarca e così via, sono ai primi posti. In questi paesi ci sono più investimenti, un modo di lavorare più razionale, una
cultura diversa. L’Europa è più produttiva rispetto agli Stati Uniti. Ma non lo dice nessuno.
Però anche in Europa, negli ultimi anni, molti governi si sono convertiti al modello americano, abbandonando un modello di civiltà costruito sul welfare e il keynesismo. Perfino le socialdemocrazie tradizionali – pensiamo ai laburisti britannici – hanno ceduto alle sirene del liberismo, pensando così di favorire il progresso. A cosa è dovuto questa forza seduttrice del conservatorismo made in Usa?
Tutto è partito dal fatto che i neoconservatori hanno vinto in America la battaglia intellettuale e, da lì, hanno esportato la propria ideologia nel resto del mondo. Il consenso internazionale si è spostato molto a destra, mentre le forze progressiste della sinistra si sono attestate su posizioni difensive. I valori storici della sinistra – la centralità dei sindacati, l’intervento regolativo dello Stato sul mercato – sono stati messi in secondo piano. Il mercato ha sbaragliato qualsiasi elemento che potesse
limitarne l’azione. E’ ora, quindi, che le sinistre di governo riprendano una battaglia culturale contro il neoconservatorismo. Uno degli effetti più negativi della globalizzazione, a mio avviso, è il tentativo di smantellare i sindacati – che sono una forza fondamentale del progresso sociale nella società capitalistica. Ma, ancor più sconcertante, è che i sindacati non
abbiano ancora sviluppato una linea politica all’altezza dei tempi, capace di contrastare le teorie neoliberiste. Non sono in grado di distinguere tra le varie forme di capitalismo. Dovrebbero ripudiare, a mio avviso, il modello americano, ma essere pronti, nello stesso tempo, al dialogo con le forze del mercato più progressive. Invece, hanno sbagliato nel rifiutare qualsiasi forma di capitalismo. Questo li ha portati all’impoverimento culturale e politico, li ha ridotti a forza marginale.
Lei invoca una battaglia per un capitalismo più equo. Ma è proprio vero che nel capitalismo ci sono margini per un progresso sociale nell’interesse della collettività? E non sarà che il neoconservatorismo è figlio del capitale?
Ci sono tendenze diverse nel sistema capitalistico. Da una parte, c’è il capitalismo americano che considera i lavoratori variabili dipendenti, semplici strumenti per raggiungere il fine del profitto. Dall’altra, c’è il capitalismo europeo consapevole della necessità di dialogare con i lavoratori e di fare concessioni eque. Queste due forme di capitalismo sono spesso in lotta tra loro. Personalmente sono convinto che il neoconservatorismo non possa funzionare, la sua visione del mondo è ripugnante, oltre che fallimentare. Ma sono anche convinto che il capitalismo non sia necessariamente brutale e selvaggio. Un capitalismo più
equo e giusto è possibile. La sinistra marxista non ha avuto la sottilezza di cogliere queste differenze all’interno del capitalismo.
L’Europa non riesce a darsi una Costituzione politica. Certo, non gioca un ruolo positivo la Gran Bretagna, da tempo impegnata nella “Terza via” blairiana e nell’alleanza a spada tratta con gli Usa…
Si, è vero, ma anche Francia e Germania hanno responsabilità pesanti per non avere rinegoziato il patto di stabilità. L’Inghilterra non capisce l’importanza della Costituzione, non avendone una propria, eppure può ancora giocare un ruolo positivo. Blair è pronto a discutere di una difesa comune europea. Questo sarebbe un passo importante.
– 21/12/2003
Europa batte Usa
In un saggio di Will Hutton la contrapposizione tra il modello europeo, che ha prodotto una società più equa e un’economia più efficiente, e quello statunitense da non imitare
L’economia statunitense è più forte e competitiva. La mancanza di controllo e di interferenze da parte dello Stato favorisce sviluppo, crescita e competitività. La forte mobilità sociale consente a chiunque di avere la possibilità di arricchirsi e di essere felici. La mancanza di vincoli nel mercato del lavoro, fa sì che vi sia occupazione per tutti. Il nuovo capitalismo finanziario nord americano, che vuole come unica regola, appunto, la mancanza di regole, confidando nella presunta razionalità del mercato, sembra definitivamente aver preso il sopravvento su quella forma di capitalismo europeo, di stampo “socialdemocratico” , al quale si sono rifatti per anni i governi, conservatori e non, del Vecchio Continente. La presunta supremazia del modello Usa, infatti, è vista sempre di più dagli europei come un modello da imitare in tutto e per tutto, come l’unica strada da seguire per continuare a crescere e a essere competitivi. Un modello che piace non solo ai conservatori, ma anche ai riformisti nostrani “spesso appiattiti sull’esaltazione di un acritico e malinteso trapianto di istituti e tecnologie” d’oltreoceano. In Italia, ma anche nel resto dell’Europa, Gran Bretagna in testa, si sta progressivamente abbandonando quella che era, per radici culturali e per storia, la propria individualità in campo economico e, soprattutto, sociale, per rifarsi a quanto avviene negli Stati Uniti, i quali vedendo nell’Unione europea un potenziale rivale geopolitico, hanno tutto l’interesse a ostacolarne l’economia e soprattutto la coesione, preferendo trattare con i singoli Stati. Con la conseguenza di un idebolimento della stessa idea politica di Europa, come hanno dimostrato le divisioni all’interno dell’Unione sulla guerra all’Iraq o il recentissimo fallimento della Conferenza intergovernativa, con il mancato accordo sul testo della Convenzione.
Eppure il modello Usa, tanto ammirato, decantato e scimmiottato è tutt’altro che migliore. Anzi, in un serrato paragone tra gli effetti della cultura europea e quella conservatrice dominante in America, a risultare vincente sarà proprio la nostra con una società più equa, ma anche con un’economia più efficiente. Questo quanto emerge da un corposo e approfondito saggio di Will Hutton, opinionista politico-economico britannico, principale teorico, assieme ad Anthony Giddens, della Terza via, e attualmente direttore della “Work Foundation”, uno dei maggiori “pensatoi” del Regno Unito. Hutton, europeista convinto, mette in guardia contro le insidie recenti che arrivano dall’America e che minacciano di bloccare la crescita e l’integrazione dell’Unione: prima fra tutte “il rifiuto dell’approccio alla solidarietà sociale, alla promozione di un capitalismo equo e a un’idea vitale della collettività” a favore di un’economia di mercato costruita sulla falsariga di quella statunitense, “caratterizzata da imprese sempre più spregiudicate e preoccupate di compiacere i mercati finanziari, dedite esclusivamente alla crescita del profitto degli azionisti quale unica misura del successo di un’azienda, in assenza di una benché minima rete di sicurezza sociale”. In realtà la produttività americana non è molto più elevata di quella europea e, rispetto ad altri indicatori chiave, gli Usa si comportano molto peggio dell’Europa, essendo “in realtà, una nazione attraversata da gravi problemi economici e sociali, il cui modello di democrazia (i voti e le cariche pubbliche divenuti sempre più oggetto di compravendita) costituisce un’offesa ai suoi stessi ideali fondamentali”. A questa cultura Hutton contrappone un bagaglio di alternative che hanno radici profonde, sviluppatesi nel cristianesimo e nei principi collettivi del feudalesimo, e che si sono sviluppate sulla spinta del socialismo democratico che ha generato, anche tra i conservatori, un’intolleranza verso la disuguaglianza. Tutte le nazioni europee, nonostante, le loro differenze, hanno alla base “l’idea di un contratto sociale” condiviso. Diversa la storia, tutta individualista, dei coloni d’America, per i quali l’unica cosa che contava era la proprietà, la terra, fuggiti da uno Stato che voleva la sua parte, e che, una volta conquistata l’indipendenza, hanno messo in piedi una costituzione dove non si parla di doveri reciproci, ma si punta alla tutela dei diritti di proprietà. La società giusta per gli americani è quella che concede a tutti un’opportunità, ma non interviene a monte o a valle nella distribuzione di rischi e ricompense. E così gli Stati Uniti non si sono preoccupati dell’ accrescimento del divario tra ricchi e poveri (il 20% degli americani più ricchi guadagna nove volte di più del 20% più povero e la percentuale dei poveri, pari al 19,1% è la più alta di tutte le nazioni industrializzate), del moltiplicarsi delle differenze sociali, di un abbassamento del livello dell’istruzione pubblica (che di fatto rende impossibile una mobilità delle classi sociali), di un sistema sanitario che va sempre più deteriorandosi (la mortalità infantile è del 10 per mille, il doppio di quella giapponese, e 12 milioni di ragazzi sono privi di qualsiasi assistenza sanitaria), di una popolazione carceraria che ammonta a oltre cinque milioni di persone. Ma questo modello si è rivelato anche un fallimento dal punto di vista economico con le imprese americane che non cercano più di innovare o costruire, ma mirano solo a creare valore attraverso l’ingegneria finanziaria.
Attenzione però, pur ribadendo e sottolineando la bontà del modello europeo, il libro di Hutton non è affatto antiamericano, né il suo autore può essere tacciato di antiamericanismo. Anzi, come lui stesso sostiene, è un convinto fautore del modello “liberal” e non a caso in tutti i momenti chiave del XX secolo i democratici si sono trovati al potere. È il caso del New Deal degli anni ’30, dell’America che ha aiutato l’Europa nella ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, di quella degli anni ’60 che fece approvare il “Civil Right Act” che fece di fatto perdere definitivamente ai democratici voti e preferenze negli Stati del Sud. Quello che critica fortemente è il modello introdotto da Reagan, e portato avanti dai suoi successori, con la breve parentesi di Clinton, troppo debole al congresso per poter invertire la tendenza.
E sostiene fermamente che un’Europa unita politicamente e economicamente ha ancora molto da insegnare e può rappresentare “il migliore esempio delle virtù di un sistema pacifico di governance multilaterale”.
– 17/12/2003
Usa, l’ora della politica
«Dopo la cattura di Saddam si torni al multilateralismo ed entri in campo l’Europa»: parla il politologo inglese Will Hutton
«L’America è la società più ineguale di tutto l’Occidente industrializzato», pensa Will Hutton, docente alla Manchester University Business Scholl e noto giornalista e opinionista poltiico ed economico. Dopo avere ispirato la “terza via” del laburista Blair, oggi ha preso le distanze dalla poltiica britannica troppo vicina agli Usa. Ed è del parere che l’Europa debba prendere posizione contro il concetto americano di globalizzazione, ponendosi alla guida di un nuovo ordine internazionale che si ispira piuttosto al “multilateralismo”, perchè il Vecchio Continente ha ancora tanto da insegnare al nuovo, sulle idee, sui valori, sulle politiche sociali concrete. Ieri a Roma Will Hutton ha presenziato alla presentazione della traduzione italiana di Europa vs. Usa, un dettagliato e documentato saggio, pubblicato da Fazi Editore.
Professor Hutton, pensa che la cattura di Saddam Hussein porterà un cambiamento nella politica Usa verso l’Iraq?
«La mia preoccupazione è che la cattura di Saddam tenti Bush a proseguire nella sua politica unilaterale, la stessa politica che finora ha giustificato l’invasione. Ma tuttavia può esserci anche un’altra possibilità, cioè che l’amministrazione Usa si adoperi, attraverso il settore moderato della politica americana, per un nuovo approccio alla questione. Entra qui in gioco anche la variabile delle elezioni presidenziali del prossimo anno, che possono portare a cambiamenti negli approcci. La mia speranza è che appunto possiamo vedere qualcosa di diverso, che dopo le armi entri in campo la politica, ma adesso è ancora presto per dirlo e occorrerà aspettare: lo sapremo nei prossimi due mesi».
Perchè l’Unione Europea nel suo insieme, finora non è riuscita a modificare l’approccio politico Usa?
«Dobbiamo dire, per spiegarlo, che abbiamo assistito negli ultimi cinque anni ad un sostanziale cambiamento nel centro di gravità politico, segnato dall’avvento del neoconservatorismo. Negli ultimi trent’anni le idee e i valori conservatori hanno preso il sopravvento ed abbiamo assistito alla crisi dei valori e dell’esperienzaliberal, come l’abbiamo conosciuta in Europa. Inoltre è cambiato il centro di gravità internazionale: le aziende dominano il mercato, lo Stato è visto come un nemico del progresso, la mentalità degli affari domina anche all’interno dei rapporti interpersonali. Il senso comune è del tutto influenzato dalle multinazionali e la tradizione europea, quella che ha dato vita allo Stato sociale, è oggi sulla difensiva».
In che modo l’Europa può svolgere un ruolo diverso?
«Il capitalismo strettamente di mercato interpreta la realtà soltanto nei termini di compravendita e sottopone ogni elemento ed ogni rapporto a questa logica. Il capitalismo europeo è invece fondato sul dialogo con le parti sociali, mentre al contrario un’economia strettamente di mercato rischia di non prendere in considerazione gli aspetti sociali, che invece sono fondamentali. Tale considerazione si trova invece nella dottrina cattolica, ad esempio nella Rerum novarum di Leone XIII, che è un documento importantissimo ed attuale. Ecco allora che è necessario un capitalismo basato sul dialogo, in sintonia con i valori del contratto sociale che invece oggi i neoconservatori tendono a negare».
Dunque a suo avviso esiste, può esistere una terza via?
«Può esistere, a patto che ci sia coerenza. E’ un po’ quando se si va in chiesa a pregare e poi, una volta usciti, ci si comporta in modo del tutto diverso. E’ necessaria una coerenza che porti all’adozione di politiche sociali, anche quelle proprie del cristianesimo, all’interno del mondo del mercato. Penso sia possibile, perchè credo possa darsi una sintonia sui valori».
Come vede il futuro delle giovani generazioni in questo contesto?
«Sono ottimista, anche perché lo sono di natura, anche se sembrano piuttosto legati ad una visione individualista piuttosto che altruista. Si impegnano sui temi dell’ambiente oppure sui temi della critica alla globalizzazione e devono ancora imparare a collegare tra di loro le diverse tematiche. Ma sono ottimista. Dovranno riscoprire anche le loro radici europee, le loro radici culturali, il ruolo delle Chiese. C’è oggi troppo individualismo, che ma forse non piace neppure a loro».
– 17/12/2003
Ma gli Usa hanno capito che costa molto caro fare la guerra da soli
ROMA – “E’ una partita lunga quella tra Stati Uniti ed Europa. Se guardiamo agli eventi di questo weekend – il fallimento della Conferenza intergovernativa e la cattura di Saddam – è facile dire che l’Europa è perdente. Ma se usiamo una prospettiva più lunga, con uno sguardo anche ai mesi passati, molti degli obiettivi europei sono stati raggiunti: anche gli americani hanno imparato la lezione in Iraq”. Per William Hutton, politologo ed economista di estrazione liberal ed ex direttore del settimanale The Observer , dagli eventi di questi ultimi giorni il Vecchio continente non esce con le ossa rotte come sosteneva ieri sul Corriere l’ideologo dei neocons, Richard Perle. Le sue tesi molto filo europeiste sui rapporti tra le due sponde dell’Atlantico, in parte controcorrente nel new labour di cui è stato uno degli ispiratori con Anthony Giddens, le ha scritte nella sua ultima fatica che significativamente si intitola “Europa vs Usa” (Fazi Editore). Professore, lei dice che l’Europa ha raggiunto alcuni suoi obiettivi nel confronto-scontro sulla guerra in Iraq. Quali?
“Tanto per cominciare, gli americani hanno capito a loro spese che andare da soli in Iraq è stato costoso, in termini di dollari e di vite umane dei loro soldati, e dunque che internazionalizzare la ricostruzione non è soltanto questione di dare legittimità all’operazione ma anche di renderla meno costosa”.
L’americano Michael Walzer, pur critico con l’unilateralismo di Bush, sostiene che gli europei sono stati troppo ambigui sull’Iraq.
“Non direi. Gli europei hanno fatto bene ad andare in piazza contro una guerra fatta fuori dalla cornice internazionale. Non sono in discussione le responsabilità di Saddam, ma il fatto che con questa guerra si è fissato il principio che se un Paese pensa che un altro può essere pericoloso nel giro di una decina di anni, è suo diritto invaderlo. Questa è la legge della giungla”.
La politica europea delle ispezioni, della cautela risultati non ne aveva dati.
“Prendo atto con piacere che ieri per la prima volta Bush ha chiesto per Saddam un processo che sia legittimato sul piano internazionale. Qualche mese fa aveva detto invece: prendetelo vivo o morto. Mi sembra un cambiamento importante dal punto di vista politico e filosofico”.
Che cosa pensa dell’ipotesi che Francia e Germania, per il loro atteggiamento nella guerra, possano venir emarginate dagli appalti per la ricostruzione?
“Sarebbe un errore fatale. Questa guerra al terrorismo sta avvelenando i rapporti internazionali. Sarebbe meglio se gli Stati Uniti fossero più generosi, così come è stata la Francia che ha accettato di cancellare il debito iracheno. Ma i conservatori, per definizione, non sono generosi: per questo l’unico modo che hanno gli europei di trattare con loro è quello di fissare una posizione comune e poi di attenersi fermamente a questa. Non c’è alternativa, anzi c’è una prima occasione in cui l’Europa può mostrarsi unita: la visita di questi giorni di James Baker”.
Da quando i Paesi della Ue hanno alzato bandiera bianca sulla Costituzione sembra più difficile che il Vecchio continente possa ritrovare un’unità politica di intenti.
“Non mi sorprenderebbe che qualcuno abbia brindato a Washington: dalla caduta del muro di Berlino gli americani vedono l’Europa in termini competitivi e i conservatori la vorrebbero balcanizzata invece che integrata. Certo anche l’Europa ha imparato molto in questi mesi. Spero che Francia e Germania abbiano capito che l’integrazione deve essere condivisa da tutti i Paesi e non basta un’idea imposta da Parigi e Berlino. Spagna, Gran Bretagna, Polonia e Italia invece la smettano di considerare la Ue come una mucca da mungere”.
Ci sono ancora possibilità che l’Europa allargata sia più integrata?
“Sono molto preoccupato e anche moderatamente ottimista. Quello che è mancato in quest’occasione all’Europa è stata la visione. E’ necessario che intellettuali, scrittori, leader politici ragionino sul concetto di Europa, sul fatto che non è che ci si può relazionare all’Unione soltanto in termini di dare e avere, condizionati dai titoli dei giornali nazionali, ma che in gioco c’è molto di più”
– 17/12/2003
Le derive dei continenti
Il “capitalismo relazionale” europeo alla prova della sfida tra il vecchio continente e gli Stati uniti. Un’intervista con lo studioso Will Hutton, in Italia per presentare il suo ultimo libro “Europa vs Usa”
Will Hutton è un pentito della “terza via”. Ideatore con il rettore della London School of Economics Antonhy Giddens del modello del third way, tanto in auge alla fine del decennio scorso, oggi spara a zero contro il sistema economico e sociale degli Stati uniti e la politica di Tony Blair. Nel suo ultimo libro (Europa vs. Usa. Perché la nostra economia è più efficiente e la nostra società più equa, Fazi, pp. 416, € 23,50), traccia un’analisi impietosa del capitalismo americano e, soprattutto, ribalta l’immagine di un’Europa incapace di elaborare un modello alternativo. La ricerca di Hutton – che oggi dirige la Work Foundation, uno dei maggiori think tank britannici – è una disanima approfondita e articolata del funzionamento del sistema d’impresa europeo e di quello statunitense: secondo l’autore la dimensione sociale del primo rappresenta un punto di forza e un elemento di superiorità rispetto al secondo.
Sabato scorso, con il mancato accordo sulla Costituzione, è stato il giorno del fallimento dell’Europa. Domenica, con la cattura di Saddam Hussein, quello del trionfo degli Usa. In che misura questi due eventi sono destinati a mutare il contesto internazionale e le relazioni transatlantiche?
Penso che sia l’Europa che gli Stati uniti debbano trarre una lezione da quanto accaduto in questi giorni. Prima della cattura di Saddam Hussein, la stessa America era profondamente divisa su questa guerra, sia per il suo carattere illegittimo dal punto di vista del diritto internazionale che per i suoi costi elevati. Se la guerra del golfo del 1991 era stata sponsorizzata per l’85% da altri paesi, quella di quest’anno è stata interamente finanziata dagli Stati uniti. Un elemento, questo, che ha provveduto a sviluppare negli Usa un forte desiderio di “internazionalizzare” il dopoguerra. Credo che all’interno dell’amministrazione figure come il segretario di stato Colin Powell e la consigliera alla sicurezza nazionale Condoleezza Rice siano destinate ad acquisire sempre maggiore potere. Mentre il segretario alla difesa Donald Rumsfeld e il vice-presidente Dick Cheney perderanno influenza.
Paradossalmente, quindi, la cattura di Saddam non è una vittoria dei neo-conservatori…
In questa vicenda irachena, i neo-cons hanno commesso troppi errori. È stata la loro strategia a dettare le linee guida del comportamento dell’amministrazione prima, durante e subito dopo la fine del conflitto. Sono loro che hanno spinto affinché venisse smantellato l’esercito iracheno e fosse promossa la ricostruzione dell’Iraq secondo i principi del libero mercato. Sono stati loro a lasciarsi trascinare dalla guerriglia in uno scontro che ha subito trasformato le truppe Usa in un esercito occupante. Oggi Bush ha due opzioni davanti a sé: internazionalizzare il conflitto oppure continuare in questo modo. La nomina dell’ex segretario di stato James Baker a inviato speciale per l’Iraq sembra indicare che il presidente si stia muovendo, sia pur cautamente, verso la prima direzione: Baker è il classico esempio di diplomatico repubblicano della vecchia scuola. Oggi (ieri, n.d.r.) è a Parigi, nei prossimi giorni andrà a Londra e Berlino.
Come ha influito l’atteggiamento tenuto sinora
dall’amministrazione Bush sulla politica europea?
La radicalizzazione dello scontro tra le due sponde dell’Atlantico ha spostato diversi equilibri. Penso ad esempio al mio paese: oggi nessun primo ministro si metterebbe nella situazione in cui si è messo Blair in Iraq. Se gli americani dovessero andare a fare la guerra in Iran o in Corea del Nord, il Regno unito non li seguirebbe, a meno che non ci sia un chiaro mandato delle Nazioni unite. E c’è di più: dopo l’esperienza irachena, i britannici per la prima volta hanno avviato un serio dialogo con i francesi e i tedeschi su un progetto di difesa comune.
Il fallimento della Conferenza inter-governativa di sabato a Bruxelles e l’imminente ingresso nell’Unione di dieci nuovi membri, per lo più favorevoli agli Stati uniti, non rischia di minare alle radici questo processo di integrazione politica?
Devo ammettere che ho qualche difficoltà a capire la fretta con cui si è proceduto all’allargamento. Personalmente, avrei optato per un percorso più graduale: prima un accordo di associazione; poi, di qui a dieci anni, una piena integrazione. Se è difficile trovare un accordo in un’Europa a quindici membri, è praticamente impossibile raggiungerlo in una a venticinque. Detto questo, in tale congiuntura anche i grandi paesi devono fare qualche passo indietro. Prendiamo il patto di stabilità: io credo che la Germania e la Francia abbiano fatto bene ad abbandonarlo, ma abbiano sbagliato a scegliere di non rinegoziarlo. Sorge spontanea una domanda: l’asse franco-tedesco sta promuovendo una reale integrazione europea o piuttosto difende i singoli interessi francesi e tedeschi? Io credo nella seconda ipotesi. Questo atteggiamento rischia di alimentare il forte nazionalismo persistente in tutti i paesi europei, ben rappresentato peraltro a livello politico da movimenti come “Forza Italia”, “Madre Polonia” o il Front National in Francia.
L’Europa è sotto il fuoco dell’ideologia neo-con, che si esprime attraverso i think tank e una forte presenza nel sistema dei media americani. Di che armi ci si può dotare sull’altra sponda dell’Atlantico per far fronte alla violenza di questi attacchi?
Credo che questa battaglia debba essere combattuta con strumenti di tipo culturale. L’ideologia neo-conservatrice negli Stati uniti non si è diffusa per caso. È il risultato di un’immensa elaborazione intellettuale, che ha avuto inizio venticinque anni fa. In Europa non c’è nulla di tutto ciò: non esistono think tank continentali. Ma noi europei dobbiamo capire che non faremo nessun progresso finché non capiremo che dobbiamo esaltare i nostri valori comuni.
Quali sono questi valori comuni?
In Europa esiste un tipo di capitalismo del tutto originale, cui corrisponde un modello di società altrettanto peculiare. Il nostro è un “capitalismo relazionale”. Le regole che reggono la grande impresa e le forme del contratto sociale sono simili. O meglio, il “capitalismo relazionale” è parte integrante del contratto sociale di stampo europeo. Nel capitalismo di stile americano, invece, tutto è negoziato e regolato dal mercato. Il modello statunitense discende da una concezione radicale dell’individualismo e del libero mercato, la cui idea di fondo è che ogni forma di tassazione e di regolamentazione sia un vincolo insopportabile per il proprio progetto di vita e di sviluppo. In Europa esiste tra le parti sociali un rapporto più saldo, che finisce per vincolare anche le scelte aziendali: gli obblighi che le imprese sono tenute a rispettare le indirizzano verso un modello che, rispetto a quello americano, è più sostenibile sia per i loro dipendenti che per l’ambiente. Credo che ci sia bisogno di rafforzare l’iniziativa intellettuale per rendere più espliciti questi valori comuni.
Ma tutto ciò non appare in contraddizione con la filosofia che muove la Commissione europea, molto attenta a promuovere un modello di mercato simile a quello degli Stati uniti?
C’è un tentativo da parte della Commissione di creare un mercato di capitali di stile americano e con regole tipicamente americane. In questo momento, però, alla Commissione sono al vaglio ben altri problemi, come il rapporto con i governi nazionali, che stanno ridimensionando il suo ruolo. Credo che bisogna trovare un equilibrio istituzionale per cui l’azione della Commissione non sia percepita come un’ingerenza. Deve essere in grado di produrre un’azione che valorizzi la tradizione istituzionale europea e, al tempo stesso, non lasciarsi irretire dal capitalismo di stampo americano.
Eppure quello promosso da Bush sembra più un enorme sistema clientelare che una moderna economia di mercato…
Effettivamente esistono delle tensioni all’interno dell’amministrazione Bush tra i conservatori “libertari”, i neo-conservatori e gli eredi del vecchio capitalismo corrotto. L’idea che accomuna tutti è che il privato sia moralmente superiore al pubblico, perché le aziende sono più efficienti dello stato: chi agisce con la logica e i metodi del big business all’interno delle istituzioni non può che promuovere il bene comune. Secondo quest’idea, lo stato può arrogarsi il diritto di affidare i contratti secondo scelte arbitrarie, come è avvenuto in modo scandaloso in Iraq con la Halliburton. La stessa ideologia di fondo anima Berlusconi in Italia: è convinzione del vostro primo ministro che le sue televisioni siano uno strumento per promuovere il bene pubblico.
Lei, uno degli ideatori del modello della terza via, oggi scrive che “il progetto politico alla base di quell’esperienza era destinato al fallimento”. Perché questo cambiamento di giudizio?
La “terza via” era un tentativo di conciliare il capitalismo americano con il contratto sociale europeo. Ma i due sistemi si sono alla fine rivelati incompatibili. È per questo che ho assunto un’attitudine critica nei confronti del modello. Nel 2000 ho scritto un libro a quattro mani con Anthony Giddens (On The Edge, Random House). Si trattava di un dialogo, in cui io rappresentavo in qualche modo la voce critica della “terza via”. Ho infatti notato che i suoi sostenitori avevano finito per importare alcuni tratti del modello del capitalismo americano in Europa, aumentando la flessibilità nel mercato del lavoro e indebolendo i sindacati. Ma chi indebolisce i sindacati mina l’esistenza stessa della sinistra, che al suo interno deve avere forze sociali progressiste. Senza un’organizzazione rappresentativa forte della working class è impossibile avere un capitalismo relazionale e risulta difficile per la sinistra mantenere un reale ancoraggio alla società.
Libri dello stesso autore