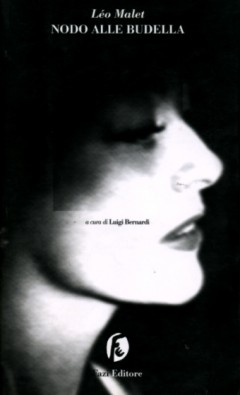
Frederic Prokosch
I sette in fuga
Con un saggio di Gore Vidal
Traduzione di Lucia Olivieri
Pubblicato nel 1937, I sette in fuga rappresenta il capolavoro di un autore americano da riscoprire, ammirato da scrittori quali Thornton Wilder, Albert Camus, Marguerite Yourcenar, Pier Vittorio Tondelli e Gore Vidal, che firma una introduzione all’edizione italiana.
Cina, anni Trenta. In seguito ai conflitti, nascenti e in corso, che attraversano l’Asia Centro-orientale, su ordine delle autorità sei uomini e una donna si trovano costretti ad abbandonare la città di Kashgar e si uniscono a una carovana diretta a est. La loro unica colpa è quella di essere stranieri: tutti europei, di sette diverse nazionalità, parlano lingue differenti e alcuni non si conoscono tra loro. Inizia così un viaggio che in breve divide questo gruppo così particolare di persone, conducendo ogni personaggio ad affrontare inevitabilmente il proprio destino. Layeville, Goupillière, Wildenbruch, Olivia, Serafimov, Von Wald, De La Scaze – sette come i peccati capitali – saranno tutti assorbiti man mano dalle immense distese della Cina, il cui paesaggio è destinato a divenire il vero protagonista del romanzo.
Nato da un sogno dell’autore, I sette in fuga è considerato il capolavoro di Prokosch, autore amatissimo dalla Yourcenar (che si preoccupò di tradurlo in Francia) e da Pier Vittorio Tondelli, il quale intraprese una sorta di pellegrinaggio nel sud della Francia per poterlo incontrare e intervistare. L’incontro non avvenne a causa della morte dello scrittore americano e il racconto di questo viaggio venne poi pubblicato su Panta con il titolo Il viaggio a Grasse.
«…solo una cosa importa agli occidentali come voi e i vostri amici. Il desiderio dell’annientamento. Segreto, sottile, travestito in migliaia di fogge bizzarre e stravaganti, si nasconde sotto terra come un serpente, volge il suo sguardo dall’alto delle nuvole come un’aquila, mormora dalle profondità marine o dal fondo di una prigione. Ma sia che vesta i panni degli aviatori, dei marinai, delle spie o dei martiri, alla fine, è sempre la stessa cosa. È lì. È il mondo. È così, lo so».
– 25/02/2003
I sette in fuga
Straordinario e ammaliante viaggio attraverso i sentieri dell’Asia di sette europei, tutti di paesi diversi, espulsi dalla favolosa Kashgar come stranieri sospetti e riuniti per caso in una carovana. In questa peregrinazione tra memorie antiche e vicende inaspettate ognuno dovrà fare una scelta interiore, verso la morte o la vita. Il capolavoro dello scrittore nato in Usa ma di origini ceco-sudete. (o.p.)
– 05/01/2003
Parole e note
E’ una vecchia querelle: è utile alla comprensione di un artista la conoscenza della sua biografia? In un libro-intervista, Il velo dell’Ordine, il grande pianista austriaco Alfred Brendel assume una posizione drastica: sarebbe stato meglio se nella vita quotidiana i grandi artisti fossero rimasti anonimi come Shakespeare. Secondo Brendel, l’opera va decifrata dall’interno. Da qui l’accusa feroce al mitico Glenn Gould che scelse l’approccio opposto, l’illuminazione dall’esterno, e finì col “maltrattare spaventosamente” i compositori. Giudizio discutibile, ma ciò che affascina è la vastità delle problematiche affrontate da Brendel, tale da rendere il libro appassio-nante per chiunque, non solo per i melomani. L’approfondita analisi dall’interno consente di alleggerire il peso dei cliché accumulato dal tempo. Persino in un monumento come Beethoven, l’idolo venerato da Brenden, si riescono per questa via a cogliere modulazioni che sfuggono all’eroismo onnicomprensivo dell’ultimo movimento della Nona o il Coro dei prigionieri e l’ultimo atto del Fidelio. Troppo spesso si dimentica che la tavolozza espressiva di Beethoven è di una ricchezza straordinaria. Include il comico, persino lo spiritoso. Si fanno tante scoperte, piccole e grandi, condivisibili o meno, nel corso della lettura. Ma non c’è dubbio che la parte più interessante del libro sia quella in cui Brendel cerca di spiegare l’ordine che sovrintende la complessità della scrittura pianistica. In ogni capolavoro c’è un lato anarchico, capriccioso, che raramente traspare dietro la regolarità formale. In Mozart la forma è un abito magnificamente tagliato su misura. Non qualcosa di rigido, un corsetto, bensì un velo. E Brenden, poeta oltre che pianista, sa bene che la dialettica ordine-caos muove anche la letteratura. L’istinto induce a violare le regole eppure il nostro orecchio (o il nostro occhio) percepisce un ordine sostanziale.
Tra i due mondi, quello delle note e quello delle parole, la distanza a volte è breve. Un bellissimo romanzo del 1937, riedito e passato inosservato, I sette in fuga, dell’americano Frederic Prokosch, conferma l’affinità di fondo tra le due arti, in un’alternanza di coralità e assolo che mai si sottrae a un occulto principio ordinato-re. I primi attori sono sette europei co-stretti dagli eventi politici a rapsodiche peregrinazioni. Partiti dal centro dell’Asia, attraverso sabbie e nevi, inse-guono il miraggio di Shanghai. Non tutti raggiungeranno la salvezza. Del resto per ciascuno di loro il punto di arrivo ha un’importanza relativa. Già esuli dal pro-prio mondo, vedono in questo viaggio un’occasione per esplorare se stessi. Tema abusato. Ma se analizziamo il romanzo dall’interno scopriamo che il segreto della sua bellezza sta nello schema strutturale, una sorta di opera lirica. L’uomo, nomade ed effimero, e la natura, stanziale ed eterna, incommensurabilmente remota, si avvicendano sul proscenio scambiandosi i ruoli di protagonista. E il linguaggio, affabulatorio, plasmato da una raffinata sensibilità ritmico-musicale, impreziosisce il gioco contrappuntistico. E’ utile sapere che Prokosch nella vita era un bibliofilo noto per le sue falsificazioni? No. Per questo, pur senza sposare la rigida tesi di Brendel, ci sembra alquanto deludente la biografia di Chet Baker, il trombettista jazz divenuto leggendario negli anni Cinquanta, firmata da James Gavin. Che sia ben scritta e scrupolosamente documentata è fuor di dubbio. Ma, chiuso il volume, resta la domanda: invece di raccontare per tre quarti del volume la lunga notte di un mito, con i dettagli più agghiaccianti della sua dipendenza dall’eroina, non sarebbe stato più stimolante avvicinarci al mistero di quella sonorità insieme pura e struggente per la quale Baker fu soprannominato “l’angelo del jazz”? .
– 30/11/2002
Tra gli esotici e caduchi rumori d’Oriente l’identità si dissolve
Arabeschi di parole si estendono come una dolce coltre di neve in un lirismo suggestivo. In grado di sedurre e trasportare. Lungo i sentieri millenari di un’Asia immaginaria. I sette in fuga, capolavoro dello scrittore statunitense Frederic Prokosch, affascina per la capacità di tornire ritratti e diffondere caduchi rumori. Sette stranieri, sette europei espulsi dalla meravigliosa Kashgar e riuniti dal destino in una carovana. Una fuga disperata da un Paese travolto da una sommossa militare e strangolato dalle pressioni degli eserciti cinesi e sovietici. Le loro strade ben presto si dividono. Per lambirsi nuovamente. Lungo la Via della Seta, le fiabesche montagne del Tibet, il pietrisco del Gobi, in serai o bordelli ognuno va incontro al proprio destino. La scelta del cammino da compiere non è dettata da valenze fisiche o morali, ma segue una pulsione interiore. Nel loro percorso perdono le tracce di ciò che sono stati, si dileguano dal loro passato. Per riscoprirsi. E il paesaggio della memoria, nel momento della rivelazione, si sovrappone e tracima nel presente. Il nitore delle immagini conferisce al romanzo, edito nel 1937, un’aura di perennità. Siamo di fronte, come direbbe Italo Calvino, a un “continente dell’altrove”. Epico e perciò immutabile. Un modo di narrare – forgiando nuovi universi – che ha influenzato gran parte della letteratura latinoamericana contemporanea e che ha ricevuto il plauso di artisti quali Albert Camus e Marguerite Yourcenar. Una scrittura opulenta. Che sconfina nel barocco. Con forti richiami al simbolismo e qualche languido accento neoromantico. Forse dettato dalla passione di Prokosch per Friederich Holderlin, di cui è stato instancabile traduttore. L’autore, nel 1983, dal suo rifugio di Grasse, pochi anni prima di morire, nega ogni addebito con le correnti novecentesche. Afferma: “Ma quando cerco di definire il significato nascosto de I sette in fuga, esso mi sfugge di mano come una goccia di argento vivo”. In questo viaggio verso il proprio inconscio, vi sono anche baluginii autobiografici. Come la Cambridge dell’inglese Layeville, ucciso dall’accidia che morde la società.
È un Oriente scevro di misticismo, in cui si assiste a una decostruzione lenta del reale. Il divario tra sfera umana e ferina spesso sfuma: l’istinto degrada, la natura si finge “tribale”. C’è un unico sottile anelito di salvezza, come mormora il personaggio di Serafimov: “Qualunque cosa, ricordate, è degna di essere perdonata. Qualunque cosa, qualunque. Poiché ogni cosa, malgrado le apparenze, sgorga dall’amore”.
– 09/11/2002
“I sette in fuga” di Frederic Prokosch: anni Trenta
“In una notte settembrina, fonda e senza vento, ventidue uomini e una donna bellissima attraversano il greto di un fiume in secca sulla pista che da Kashgar conduce a oriente, verso Aksu. Uno dietro l’altro, i quindici portatori procedevano faticosamente tra massi, guidando muli e i cammelli carichi di bauli imbrattati e logorati dalle intemperie”. Alla faccia di qualunque nemico del “romanzesco”, le prime righe dei Sette in fuga di Frederic Prokosch (traduzione di Lucia Olivieri, con un saggio di Gore Vidal, Fazi, pp. 405, euro 16.50) hanno tutta l’aria di una poetica in miniatura. Sbandierata con orgoglio, nel 1937, dallo scrittore sulla soglia dei trent’anni. Il polpettone, speziatissimo, è servito: e la quantità, come vogliono le regole, non sarà inferiore alla qualità. Il viaggio di quei ventidue uomini, c’è da sospettare senza bisogno di altri indizi, non sarà una scampagnata. Ma su una cosa possiamo addirittura giurare: quella “donna bellissima” nel cuore dell’Asia, costretta ad abbandonare Kashgar alle prime luci dell’alba, circondata da tanti maschiacci nostrani e locali, ne passerà di tutti i colori – e altrettanto certamente, ne farà passare agli altri. Piantata lì, in mezzo alla frase di apertura, è un’ottima esca: e inoltre semplicissima, come tutte le esche davvero ottime. L’inenarrabile casino che aspetta, uno per uno, i sette fuggitivi, unito alla sistematica rotazione dei punti di vista, scoraggia ogni tentativo di descrivere questo libro a partire dalla trama. La quale, del resto, è incontestabile: come in ogni parto di una rigorosa Poetica dell’Arbitrio. Nello scrivere I sette in fuga, Protosch sembra alludere, implicitamente, a certe condizioni essenziali, e nello stesso tempo circostanziali, del leggere romanzi vasti, complicati, ambientati in terre lontane. Oggi come negli anni trenta. Suggerisce insomma notti insonni, e piovose, o lunghi viaggi in aereo, periodi di convalescenza o gravi delusioni sentimentali…
Confesso di non essere il cliente ideale per questa merce spiccatamente narrativa. Prokosch scrive benissimo, si può dire che non sbaglia una frase: e ne deriva, all’intero congegno, un clima di perfezione che può risultare estenuante. Già due anni prima dei Sette, Prokosch, con Gli asiatici, si era inventato, romanzescamente, un Oriente in cui non aveva mai messo piede concretamente. E anche il lungo romanzo, scriverà molti anni dopo, “era nato a Cambridge durante l’inverno, mentre avevo davanti agli occhi le braci del mio caminetto che splendevano come le montagne dell’Himalaya alla luce dell’alba”. Nel 1983 Prokosch ristampò (con una prefazione molto sorniona) I sette in fuga, e Gore Vidal gli dedicò una bellissima recensione – è il saggio ripubblicato ora nell’edizione Fazi -, che è anche un ritratto a tutto tondo dell’impeccabile ed elegante apolide di origini ceco-sudete, figlio di un insigne linguista, nato nel Winsconsin nel 1908, con alle spalle un’infanzia che “assomiglia in modo sorprendente a un romanzo di Mark Twain”.
Da molto tempo, ormai, Prokosch viveva in Costa Azzurra, a Grasse, nella villa dove nel 1990, a pochi mesi dopo la morte di Monsieur, come tutti lo chiamavano lì, Pier Vittorio Tondelli andò a ficcare il naso per una specie di “intervista impossibile” che è uno dei suoi racconti più belli (si intitola Viaggio a Grasse e si trova adesso in L’abbandono). Non gli aprirono nemmeno le porte della villa, e non gli restò che aggirarsi nel giardino e sbirciare dalle finestre un paio di stanze, troppo scure anche per rubare una fotografia – tutte restrizioni che, come a volte accade, finiscono per rendere Tondelli straordinariamente penetrante. Come Gore Vidal, anche Tondelli, più che di qualunque romanzo di Prokosch, era innamorato dell’autobiografia, Voci, uscita in America anch’essa nel 1983 (e poi pubblicata in Italia da Adelphi). E in effetti Voci è il capolavoro di questo scrittore “fuori canone” in senso assoluto, impeccabile e profondo ospite della vita, imperterrito collezionista di voci e caratteri irripetibili. E nell’autobiografia torna più di una volta il ricordo dei Sette in fuga, che piacevano a Queneau, che ci vedeva “come un ventaglio” la mentalità europea “contro lo sfondo di neve e ghiaccio dei deserti del Sinkiang”, e a Margherite Yourcenar, che lo aveva anche tradotto in francese, per poi perdere il manoscritto durante l’occupazione tedesca di Parigi. Quando finalmente esce da Gallimard una nuova traduzione, Prokosch la manda a Colette, nell’imminenza di una visita. Alla fine della conversazione, che ovviamente è sublime, Colette non si ricorda più chi è quello strano visitatore che non ha domande da fare. Prokosch le ricorda, allora, di averle inviato qualche giorno prima i Sept fugitifs. “Sì, ricordo”, dice allora Colette, ormai “fragile” ma ancora perfida: “quel libro sul deserto e le montagne dell’Asia. Piuttosto intrigante. A lei è mai capitato di fuggire attraverso la Cina?”. No, risponde “col tono di chiedere scusa” l’impavido Prokosch, che ha appena incassato quel terribile piuttosto intrigante, è capitato ai miei personaggi, “Sei uomini e una bella donna. Nel cuore della notte. Nel cuore dell’Asia!”, esclama allora Colatte. “Nel pronunciare la parola Asie – annota Prokosch – la voce si fece sommessa, simile al ronzio di un insetto. Sembrava che Colette si fosse trasferita nel deserto del Gobi”.
Ecco qualcosa che l’autore degli Asiatici e dei Sette in fuga, che guardando la brace del suo caminetto di Cambridge immaginava le cime dell’Himalaya, poteva capire fin troppo bene. Perché i nomi, non sono solo i sostituti delle cose, così come le cose e le esperienze, d’altra parte, non sono solo i presupposti dei nomi che le definiscono. No, esiste una linea di confine più sfumata, e ci sono dei nomi, soprattutto alcuni nomi – come “Asia”, o “Himalaya”, o “Sinkiang”…- capaci di contenere e moltiplicare la forza delle cose, nomi che vibrano e risuonano nello spazio della mente con lo stesso spessore e la stessa vastità di ogni esperienza possibile. In questo senso, l’Asia di Prokosch sembra fatta della stessa sostanza (per nulla “inautentica”) della Malesia di Emilio Salgari o dell’India di Abraham Yehoshua. Quello che offrivano le relazioni di viaggio e gli atlanti confrontati a Cambridge non era né più “vero” e né più “falso” di quello che aveva da offrire l’effettiva fuga dalla Cina suggerita dalla maliziosa Colette.
In ogni caso, in gioco è la nostra vita: che a sua volta, in ogni caso, è un’illusione. Semmai, se c’è della “falsità”, essa non può essere imputata al giovane scrittore che sverna a Cambridge, ma al peso delle “religioni” letterarie che dominano in quegli anni trenta, in quell’epoca di rappel à l’ordre prima della catastrofe: a partire dalla fiducia (che noi oggi possiamo tranquillamente definire “cieca”) nelle risorse cognitive dello stile, e nel potere di rappresentazione offerto dalle strutture del romanzo. La visita di Tondelli alla villa sprangata di Grasse, allora, potrebbe essere intesa non solo come l’ultimo omaggio a un “grande minore” del passato, ma anche come una sottile allegoria. Come quella casa, infatti, anche una certa maniera di “essere moderni” può apparirci un luogo ammirevole, tanto degno di un pellegrinaggio quanto definitivamente impraticabile: del quale, ormai, sarà solo possibile spiare qualche dettaglio, deformato dalla penombra, da una finestra malchiusa.




