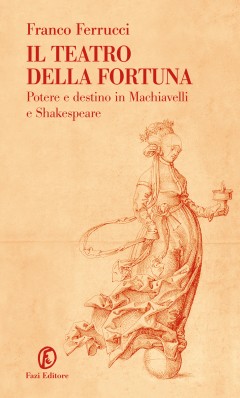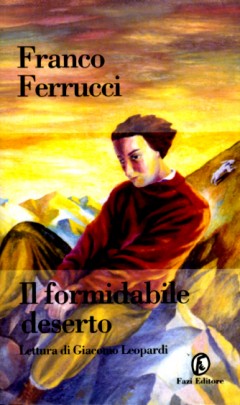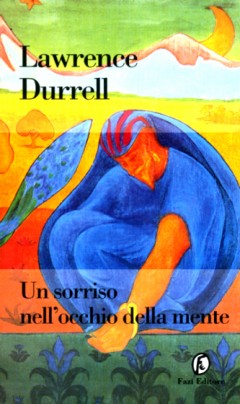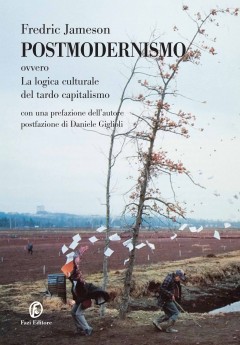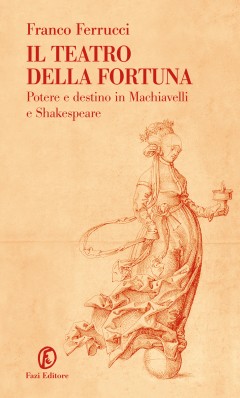
Franco Ferrucci
Le due mani di Dio
Il cristianesimo e Dante
“Le due mani di Dio” è un’immagine di Bernardino da Siena che riassume la fusione cristiana di monoteismo biblico e di politeismo pagano. Il cristianesimo non ha soltanto ospitato innumerevoli ricordi della religione classica, ma ha elaborato un autonomo politeismo che ancor oggi convive con il suo mai rinnegato monoteismo. La Commedia di Dante è la più alta testimonianza di tale fenomeno, e aiuta a capire l’inquieta natura della fede che l’ha ispirata. Del resto, la cultura pagana sopravvive tenacemente nel linguaggio e nelle visioni di oggi; infatti la doppia pianta dell’Occidente – la versione cristiana del giudaismo e del classicismo – non ha cessato di produrre frutti. Il suo talento è l’innesto.
– 02/05/1999
Guarda chi si rivede, Ferrucci…
DANTE E CRISTO. Doveva essere solo un articolo sull’uso del materiale mitologico pagano e cristiano nella “Divina Commedia”: è diventato un libro su Dante e sul Cristianesimo. Questo il percorso seguito da Franco Ferrucci per “Le due mani di Dio”, titolo che riprende un’immagine di Bernardino da Siena e che ben sintetizza, secondo l’autore, la saldatura cristiana di monoteismo biblico e politeismo pagano. Ferrucci, infatti, non si limita alla critica letteraria: il suo intento è una ricerca filosofica generale, incentrata sulla tesi secondo cui la contaminazione di cristianesimo e paganesimo avrebbe fatto della cultura cristiana la più ricca esperienza di pensiero e di arte della storie umana. Uscirà a fine maggio da Fazi che, in autunno, pubblicherà anche una nuova edizione – una riscrittura totale – del “Mondo creato”, uscito nell’86 da Mondatori e tra i libri di narrativa italiana più venduti negli Stati Uniti.
– 12/03/1999
L’opera di Dante non cessa di ispirare saggi alla fine del millennio
Grande testimone della civiltà
Nuove biografie e saggi critici sulla “Commedia” ripropongono la figura del sommo poeta come una fonte inesauribile di insegnamenti spirituali. La sua cultura era quella di un letterato immerso nella crisi del Medioevo, ma la portata delsuo pensiero arriv
Nella notte tra il 7 e l’8 aprile del 1300 – l’anno del primo Giubileo, dunque il primo Anno Santo – Dante Alighieri inizia il suo viaggio ultraterreno. E’ un uomo conosciuto in tutta Firenze per la vastità e la profondità della sua cultura, e un’opera come la “Vita Nuova” ne ha segnalato le originali qualità di intellettuale, capace di cogliere e rappresentare, con intensità d’accenti, non solo le cifre sentimentali ma anche quelle sapienziali e spirituali dell’Amore. Ma Dante è anche un “cittadino” che ha avuto ed ha responsabilità politiche; e che, svolgendo i suoi uffici, si è andato via via sforzando di superare le perverse logiche di parte – la sua è quella dei guelfi “bianchi” – in nome della “patria”. Che, ai tempi suoi, si chiama Firenze, la città che lo ha visto nascere, stringere amicizie, contemplare con amoroso sguardo Beatrice, la donna del “saluto” e della “salute”: Firenze che è, poi, una tradizione, uno stile, una cultura, un costume, un’eredità di affetti e di valori da riattivare. Ma la “patria” di Dante si chiama anche Chiesa, come custode e testimone eroicamente “pacifica” e spiritualmente “povera” del Verbo di Cristo; e si chiama, infine, Impero, come spazio politico universale, equilibrata e giusta sovranità, garanzia di ordine e stabilità, proiezione terrena di una gerarchia celeste che non può essere messa in discussione. E che, invece, subisce ogni sorta di attacco: perché le “parti” – siano rissosi comuni o orgogliosi regni – si ribellano al “tutto” in una spinta centrifuga che le vede non solo lacerare il tessuto unitario della Cristianità, ma lacerarsi esse stesse nelle lotte di fazione. Quanto alla Chiesa, davvero par che molti dei suoi rappresentanti, e proprio quelli che maggiormente dovrebbero guidare e orientare un già frantumato “popolo di Dio”, vogliano usurpare ruoli e funzioni che loro non competono, accecati da smanie temporalistiche, e cioè da una vera e propria libidine di potere, che spingono il Papato a mettere in discussione l’autorità imperiale. Il poeta e cittadino Dante Alighieri, che d’improvviso si trova nella “selva oscura” in una notte che pare non aver fine, alle soglie del suo trentacinquesimo compleanno e con un affanno che sempre più gli grava addosso, minacciato com’è dalle tre fiere, simbolo di peccati privati e pubblici ad un tempo; l’uomo Dante Alighieri che è, sì, un intellettuale di prestigio e indubbiamente un “magnanimo”, ma si porta dietro tutte le debolezze di chi, per l’appunto, ha smarrito “la diritta via” ed avrà bisogno del sostegno, prima di Virgilio, poi di Beatrice, per percorrere la strada della conoscenza e quella della purificazione, e rendersi quindi degno di contemplare Dio; questo “testimone” di una crisi esistenziale ed epocale, che ci insegna, dopo aver tutto sperimentato sulla pelle e nell’anima, a “restaurare omnia in Christo”, è tanto vivo, a settecento anni di distanza dall’inizio della sua “avventura”, che rileggerlo non solo significa sempre riscoprirlo e attingere a un’infinità di cose nuove e meravigliosamente “inattese”, ma vuol dire anche misurarsi con la “verità” dell’umano itinerario nelle sue modalità personali, nei suoi “esempi” storici, nei suoi significati eterni. Ecco, dunque, che, a nostro avviso, chi “interpreta” Dante, chi talvolta dedica gran parte della sua vita di studioso o addirittura tutta la sua vita a leggere e a rileggere Dante, convincendosi che “quel” tesoro è inesauribile, non può se non essere mosso da una grande “vocazione”: perché l’Alighieri esige amore e attenzione, diciamo una tale capacità d'”ascolto” che possa esprimersi non soltanto in elevata sensibilità critica, ma in una sorta di “accordo intellettuale”. Dante, “rivoluzionario” perché “restauratore”, ci sfida all'”adesione” e alla “condivisione”: e cioè “provoca” la critica, a meno che essa non intenda essere mèra, ancorchè rispettabile, filologia, all’incontro/scontro con una visione del mondo. Ed è chiaro che da un’impresa del genere è facile uscirne con le ossa rotte, per quanto si possa esser paludati di accademica rispettabilità e ben protetti dietro i nostri strumenti esegetici. Sia lode, dunque, a chi scrive di Dante, impegnandosi non solo a ritornare con più puntigliosa acribia su documenti e commenti, ma ad “imparare”. Il che vuol dire “saper leggere” e dunque essere in grado di “ordinare”; ed anche “azzardare”. Ci piace segnalare, a questo proposito, tre saggi: “Dante” di Enrico Malato (Salerno Editrice, pp. 420, £. 39.000); “Le due mani di Dio” di Franco Ferrucci (Fazi Editore, pp. 178, £. 25.000); “Il ritorno di Beatrice” di Corrado Bologna (Salerno, pp. 147, £. 24.000). L’opera di Malato è frutto di oltre un trentennio di ricerche e di studi, e gliene va dato ampio riconoscimento, perché il suo “Dante” è una biografia “completa”. Il poeta viene collocato in uno “spazio” e in un “tempo” che da una parte si fondono su precise coordinate storiche e geografiche (l’ambiente di Dante, la “sua” Firenze, i suoi rapporti con l'”attualità” ecc. sono ricostruiti con dovizia di dati e di argomenti); dall’altra – e qui appaiono luminosamente persuasive le pagine dedicate al “conflitto” tra l’Alighieri e il Cavalcanti per quanto attiene alla materia d’Amore e quelle volte ad “esplorare” tutta la produzione dantesca, ridisegnandone, all’occorrenza, contesti e circostanze – “spazi” e “tempi” sono quelli di un artista che intende parlare “dell’eternità”, avendo “l’eternità” come interlocutore. Insomma, se Dante è “testimone di un’epoca” e la sua cultura, la sua “ideologia”, le sue scelte personali, il suo sistema di valori ecc. nascono “dentro” quel Medioevo che va a pezzi, “dentro” quella Cristianità alla quale lui cerca di dare la sublime ancora di salvezza dalla “Commedia”; è altrettanto innegabile che quel suo messaggio è destinato anche a “noi”, ed è per questa problematica “attualità” che noi, lettori, “scopriamo” o, fecondamente, “ci interroghiamo”. Dante “ci parla”: e non è far esercizio retorico il riconoscere che dobbiamo “ascoltare”. Se Malato è un professore come ce ne dovrebbero esser di più e nei Licei e nelle Università, Franco Ferrucci è scrittore appassionato e genialmente “sovversivo”. Questo “suo” Dante, questa “sua” “Commedia”, che in qualche modo mettono in discussione il sistema di valori e il Dio veterotestamentari e saldano il magistero di Gesù Cristo piuttosto che al “Padre Padrone” biblico agli dèi e alle memorie del paganesimo, ci hanno fatto pensare agli scritti di Simone Weil sulla Grecia e le intuizioni precristiane, e al dibattito appassionato, che la scrittrice ebrea sostenne nel corso della sua esistenza, “bruciata” dall’ardore morale e conoscitivo per difendere le “ragioni” di un Cristo non immemore – anzi! – della tradizione pagana. E’ “scandaloso” affermare che il cristianesimo, con le figure dei Santi e della Vergine Madre, si colloca in un firmamento “monopoliteista”, e che la “Commedia” è la più alta testimonianza di questa “visione”? Può darsi, ma la ricchezza di intuizioni e di suggestioni di cui è carico il libro di Ferrucci impongono, in ogni caso, uno stimolante “confronto”. E che dire della “Beatrice” di Corrado Bologna? Questa straordinaria figura di Donna-Madonna è giustamente intesa come una presenza costante nell’opera dantesca. Beatrice “è” anche dove appare “assente”; “è” anche quando Dante pare dimenticarla e lei invece vive “tra le righe”, in attesa di riemergere in luminosa pienezza. Bologna indaga sull’apparente scomparsa, sulla contrastata e trepida attesa, sullo splendente ritorno nel canto XXX del “Purgatorio”, laddove l’amorosa vicenda si riapre per svolgersi in un crescendo di luce, di cielo in cielo.
– 03/01/2000
Spirito cristiano e nostalgia classica
Il titolo dell’ultimo saggio del Ferrucci, autore anche di opere di narrativa pubblicate dallo stesso editore, è ricavato da un’immagine con cui san Bernardino da Siena allude alla particolare fusione, attuatasi nel cristianesimo, tra monoteismo ebraico-biblico e politeismo pagano. Nel cristianesimo, infatti, confluiscono innumerevoli ricordi della religione classica tanto da farlo approdare a quello che l’autore arditamente definisce “monopoliteismo”. Il cristianesimo assorbe entro di sé il paganesimo per proteggersene, ma così facendo gli garantisce vita eterna sotto la sua egemonia. I risultati artistici ebbero tutto da guadagnare da tale incrocio: il politeismo pagano che era estremamente propizio alla fioritura creativa, assai più del monoteismo veterotestamentario. In effetti, ogni grande momento creativo dell’Occidente, da dante al Rinascimento, allo stesso Romanticismo, così imbevuto di nostalgia greca oltre che lo spirito cristiano, ha coinciso con un consapevole ritorno ai classici. E se è vero che la letteratura moderna è una filiazione geniale del cristianesimo, una delle nostre più alte opere poetiche cristiane, la “Divina Commedia” di Dante Alighieri, dimostra con esemplare chiarezza come paganesimo e cristianesimo non si siamo mai separati: la straordinaria forza del poeta fiorentino è di far convivere nel suo poema gli elementi più disparati in una simbiosi di classicismo, filosofia e teologia, il tutto trasfuso da una fervida immaginazione e da una poesia sublime. Il sottotitolo del presente volume: “Il cristianesimo e Dante”, intende proprio riferirsi a questa comune perduranza di ricordi pagani, e anche se l’insistere sulle frequenti analogie tra religione cristiana e tradizioni precedenti può essere da molti ritenuta oggi un’osservazione basata sul pregiudizio, Dante sa bene quale sia la fonte di ciò che scrive e lo comunica al lettore. Anzi, la venerazione per l’antica Roma è uno dei segni più forti del classicismo dantesco. “Le due mani di Dio” è un saggio, non del tutto semplice, d’interpretazione letteraria e di riflessione filosofica e religiosa, con spunti di grande interesse (l’evoluzione fino al diavolo cristiano, l’autoironia di Dante, l’idea di nobiltà e di immortalità) e con una accurata bibliografia essenziale in appendice.
– 02/05/1999
Dante. Il Paradiso non può attendere
La vicenda di quest’estate sulle ceneri di Dante perdute e ritrovate (e inesistenti, in quanto ceneri) ricorda quei racconti sulle sacre reliquie di cui è ricca la letteratura comica, e in particolare la novella di frate Cipolla, scritta da quel Giovanni Boccaccio che peraltro era un devoto cultore di Dante: apprestandosi ad estrarre da una scatola una penna d’uccello per offrirla alla venerazione degli ingenui abitanti di Certaldo come penna dell’arcangelo Gabriele, quel frate, per la burla di due buontemponi, trovò al posto della penna dei carboni, che comunque fece passare per quelli della graticola su cui fu arso san Lorenzo. Non so se i media avrebbero ugualmente gioito se dagli anfratti della Biblioteca Nazionale di Firenze fossero sbucate fuori per essere esposte al pubblico, anziché quelle improbabili ceneri, delle autentiche carte dantesche. E’ certo comunque che la curiosità per beffe alla frate Cipolla è oggi molto maggiore della disponibilità a leggere Dante, ad ascoltarne la lingua, a riconoscervi uno dei fondamenti essenziali della nostra identità (la Commedia, del resto, è stata già quasi completamente espulsa dalle nostre scuole). Eppure a questa diffusa indifferenza pubblica si oppone una vivacissima serie di studi danteschi (con un vero e proprio boom negli Stati Uniti d’America): e qui da noi sono appena usciti due libri importanti, molto diversi tra loro, ma entrambi di grande interesse. Il libro di Malato è un ricco e ben articolato manuale, che offre al lettore, con grande precisione e perspicuità, tutti gli essenziali dati storici e filologici, collegandoli all’individuazione di alcuni nodi cruciali e ad una chiara proposta interpretativa. Malato si ricollega alla grande tradizione storico-filologica, che ha dominato nella critica dantesca italiana, su una linea Auerbach-Contini: in questa linea egli sceglie una strada originale, mettendo al centro della sua interpretazione il rapporto tra Dante e il «primo amico» Guido Cavalcanti. Al di là del grande rapporto d’amicizia tra i due, già la costruzione della Vita nuova indicherebbe un forte dissenso da Guido, la cui canzone dottrinale Donna me prega sarebbe una vera e propria risposta al «libello» dantesco: ma poi l’intera Commedia si concepirebbe come una «resa dei conti» con Guido, come mostrerebbero non solo alcuni passaggi che hanno già prodotto interminabili discussioni, ma anche alcuni punti nodali del poema sacro (come i suoi canti centrali, XVII e XVIII del Purgatorio). Questo rapporto conflittuale con l’amico non costituisce comunque un semplice caso di «angoscia dell’influenza», ma tocca il significato globale dell’esperienza amorosa, che sorregge e motiva tutta l’opera di Dante: alla nozione cavalcantiana della natura irrazionale e incontrollabile dell’amore, questi oppone già dalla Vita nuova, ma svolgendola poi in modi diversi, l’idea di un amore sostenuto dal «fedele consiglio de la ragione». L’amore così diventa la chiave suprema della conoscenza, su cui si regge l’intera esperienza intellettuale e la vita stessa del cosmo: ma nel contempo mantiene le sue radici terrene, come mostra in primo luogo la soluzione inaudita di fare di una donna come Beatrice l’immagine dei valori supremi della fede. A parte i dubbi che si possono avere su alcuni punti particolari del rapporto Dante-Guido, da questo punto di vista l’opera di Dante assume un rilievo fondante per tutta la tradizione occidentale: nel senso di una parallela razionalizzazione e assolutizzazione dell’amore, che sola ha aperto la strada a Petrarca e a tutta la successiva poesia d’amore. Il libro di Ferrucci si svolge dal suo canto in una scrittura saggistica, che tocca con sprezzatura degna di un romanziere di valore (come del resto è l’autore), una fitta serie di richiami storici, culturali, antropologici, che riguardano l’intera storia del cristianesimo e la questione del rapporto tra cristianesimo e paganesimo. Anche qui l’opera di Dante si pone come fondante per l’intera tradizione occidentale, e non solo per il suo orizzonte letterario: in essa trova una sintesi risolutiva quella spinta del cristianesimo a conciliarsi e ad integrarsi con il paganesimo che sarebbe inscritta nei suoi stessi caratteri originari. L’immagine delle «due mani di Dio» (che l’autore ricava da Bernardino da Siena) indica la coesistenza, nel cristianesimo, del «monoteismo della Persona divina» e della «frantumazione politeistica» degli angeli, dei demoni, del santi: per spiegare tutto ciò, Ferrucci adotta il termine di monopoliteismo, ad esso riconducendo tutta una serie di paradossi, di compromessi, di contraddizioni, di saldature tra unità e molteplicità, a cui Dante darebbe pieno riconoscimento, concreta vita fisica nella Commedia. Come si vede, si tratta di una prospettiva molto audace, specie se rapportata all’ossessivo insistere di tanta critica (specie negli Stati Uniti d’America, dove Ferrucci insegna) sull’organicità dottrinale e sul rigore teologico e allegorico, sui fondamenti patristici e/o scolastici della Commedia: ma questa prospettiva rende comunque conto, molto meglio di quella critica teologico-allegorica, di certe scelte e invenzioni assolutamente inaudite di Dante, di cui la consuetudine o la consacrazione confessionale hanno fatto dimenticare la portata (primo fra tutte il fatto, ben poco conseguente con qualsiasi punto di vista «ortodosso», che il poeta stesso si arroghi il privilegio di compiere il viaggio ultraterreno, arrivando, da vivo, fino alla diretta visione di Dio, e per giunta accompagnato da una donna conosciuta sulla terra, che per di più era stata moglie di un altro!). Molti sono i punti in cui, nella sua sfida poetica, il Dante di Ferrucci viene a rendere più vivo e a consegnare a tutta la cultura moderna questo orizzonte del monopoliteismo: così nel legame tra fede e visione estetica, in quello tra immortalità dell’anima e immortalità dell’opera, nell’affermazione di un’idea di originalità individuale, nella figura del diavolo come matrice della rappresentazione moderna del male, nel metodo ironico e nel senso della contraddizione, nell’irruzione del realismo, nella stessa visione della femminilità poetica, ecc. Questo Dante al crocevia tra valori cristiani e modelli pagani chiama insomma in causa quasi tutti i fondamenti essenziali dell’immaginario, della filosofia, dell’intero quadro della cultura moderna, di una cultura che per molti tratti è ancora la nostra: lungi dal rimanere chiuso nella distanza siderale di una astratta categoria di Medioevo, sembra ancora coinvolto nella situazione e nel destino della civiltà occidentale. Insomma, «perché non possiamo non dirci danteschi»: con un implicito, pressante invito a tornare a leggere e interrogare Dante, anche per capire noi stessi, a non accontentarci di scatole di ceneri, a non finire come i certaldesi beffati da frate Cipolla.
– 02/05/1999
La terrestrità e il divino nell’Alighieri
Nel suo appassionato percorso dantesco Franco Ferrucci ci aveva dato con Il poema del desiderio (edito nel 1990 da Leonardo) una lettura del padre della letteratura italiana che ne coglieva, attraverso la Vita nuova e soprattutto la Commedia, la capacità di costruire una nuova poetica fondata su una forte dialettica tra indicibilità e necessità del dire, tra classicità e fede religiosa, tra poesia umana e ispirazione divina, tra narrativa e teatralità, tra controllo dei desideri ed eros indomabile. In questa immagine di Dante egli individuava con sicurezza la nascita della letteratura moderna. Ora Ferrucci ritorna sul suo autore in un saggio (di imminente pubblicazione presso l’edi-tore Fazi), che fin dal titolo ispirato a una predica di Bernardino da Siena – Le due mani di Dio – dichiara la centralità di un paradosso vitale che è stato proprio del Cristianesimo e del suo massimo cantore: il fatto cioè che esso, contrapponendosi in maniera netta all’Ebraismo, si assesta. Almeno a partire dalle grandi dispute tra Agostino e Pelagio, come pieno recupero del paganesimo, creando una sorta di monopoliteismo (così lo chiama Ferrucci) in cui convivono, necessitati, lo spirito di una religione assolutamente trascendente e l’umanizzazione – la terrestrità – del divino con la presenza di divinità minori (i santi, gli angeli, la Madonna) e la possibilità di raccontare e descrivere persino il luogo di Dio. Molte delle osservazioni di Ferrucci (al centro: il recupero di immagini, riti, valori pagani nel Cristianesimo; I’inti-ma passione per la classicità di Dante) sono già state acquisite dalla critica dantesca – né so personalmente giudicare quanto siano teologicamente corrette. La novità del suo discorso sta piuttosto nel fervore con cui l’autore inserisce Dante nello sviluppo storico del Cristianesimo, come centro addirittura del grande compromesso con la visione pagana del mondo, e nel cammino della cultura occidentale, dall’antichità fino ai giorni nostri (espressa nella clausola “perché non possiamo non dirci pagani”). Nel ripercorrere canti ed episodi del poema questo animato quadro di riferimento consente comunque a Ferrucci di cogliere alcuni nessi che pongono Dante al centro della nostra cultura e ne segnano la straordinaria modernità e di offrire precisazioni e riletture stimolanti. Così nei versi dedicati a Paolo e Francesca avverte l’idea di un amore come divinità malefica e rilegge il celebre Amor ch’a nullo amato amar perdona nel senso che “chiunque riama sarà punito da Amore”. Cosi sente nel canto di Capaneo (XIV dell’Inferno) l’emblema dell’intera Commedia nella figura del gigantesco eroe bestemmiatore di Giove. E rileva ancora lo straordinario rovesciamento della concezione figurale tradizionale nella presenza di Catone come custode del Purgatorio. O sente nell’invocazione ad Apollo che apre il Paradiso ben più che un banale gioco allegorico-metaforico, individuando in essa “il dramma culturale e creativo di cui Dante è lo stupefacente protagonista”. O, ancora, ricostruisce la complessa filiazione culturale e religiosa pagana delle figure femminili della Commedia (Matelda, Beatrice, la Madonna), forse con qualche forzatura (Matelda = Mater Idaea), ma anche con affascinante penetrazione. Dante stesso viene riconosciuto come eroe cortese, come santo, come il poeta che trascrive l’arte poetica di Dio, persino come il rivale del Cristo, in quanto nuovo messia. Un’opera quindi che appare particolarmente sollecitante nella sua capacità di cogliere attraverso Dante un processo millenario nella cultura europea.
– 02/05/1999
Dante tra Giove e Jeova
Per gli inglesi l’autore del Paradiso Perduto si chiama Milton, per i tedeschi il Faust è opera di Goethe, soltanto per noi italiani il poeta della Commedia è Dante e basta. Ma dove nasce questa preferenza per il nome a discapito del cognome? La domanda è meno ingenua di quanto potrebbe sembrare, specie se a porsela è Franco Ferrucci, raffinato italianista da tempo trapiantato negli Stati Uniti oltre che autore di pochi, importanti romanzi. La sua prova narrativa più ambiziosa, Il mondo creato, verrà presto presentata in nuova edizione dall’editore romano Fazi, che l’anno scorso aveva pubblicato un notevole saggio leopardiano di Ferrucci (Il formidabile deserto) e ora manda in libreria Le due mani di Dio, uno studio su “il cristianesimo e Dante” che riserva più di una sorpresa. È in questa sede che Ferrucci si pone la questione del “Dante e basta”, risolvendola con un triplice riferimento. A essere contraddistinti dal solo nome proprio sono infatti gli auctores dell’antichità, primo fra tutti quel Virgilio che Dante elegge a guida del suo itinerario oltremondano. Ma anche i santi non hanno alcun bisogno di cognome. Anzi, iniziano a diventare santi proprio quando, come Francesco d’Assisi si spogliano dell’appartenenza alla famiglia. Gli eroi dell’epopea cavalleresca medievale, invece, il nome proprio se lo conquistano con le prodezze di cui si rendono protagonisti. Come fa Dante, appunto, con il suo viaggio e il suo poema. Ciò che interessa, a Ferrucci, è la complessità dell’intreccio fra eredità classica e cultura medievale o, meglio, fra politeismo pagano e monoteismo cristiano. La sua convinzione – senz’altro discutibile, ma motivata con estrema competenza e aderenza ai testi – è che la religione di Dante sia in realtà un “monopoliteismo”, l’adorazione di un Dio unico e inaccessibile che si rende visibile all’uomo attraverso una molteplicità di volti. Ed è per questo che, nell’interpretazione di Ferrucci, la tradizione del paganesimo antico non viene respinta, ma inglobata da Dante, il quale nel sesto canto del Purgatorio arriva a chiamare il Dio cristiano «sommo Giove / che fosti in terra per noi crucifisso», con un impressionante cortocircuito fra il signore del pantheon grecoromano e il Jeova biblico. Scrive Ferrucci, riassumendo la tesi portante del suo libro: «[…] senza il paganesimo alle spalle, il cristianesimo non sarebbe riuscito a trovare le immagini adeguate -e forse neppure il sentimento appropriato – per avvicinarsi al divino». Si tratta, inutile nasconderselo, di una prospettiva che può suscitare controversie, ma che pure conduce spesso a risultati di estremo interesse. Molto convincente, per esempio, l’analisi della coppia Matelda-Beatrice come espressioni complementari (Venere e Minerva, la bellezza e la sapienza) della Gran Madre, quella Mater Idaea da cui, tramite La città di Dio agostiniana, deriverebbe l’altrimenti inspiegabile nome di Matelda. È un Dante diverso da quello che siamo abituati a pensare, questo di Ferrucci, e non soltanto perché con il suo capolavoro indirizza verso un Dio che – come nella citazione di Bernardino da Siena che dà il titolo del libro – pare contraddire se stesso a seconda che adoperi la mano destra per dispensare misericordia o la sinistra per punire. È un Dante diverso anche perché, come argomenta con finezza Ferrucci, si rivela imprevedibilmente disponibile all’ironia e all’autoironia. Una caratteristica che spiega, se non altro, l’ammirazione del modernista James Joyce per il medievalissimo autore della Commedia.
Libri dello stesso autore