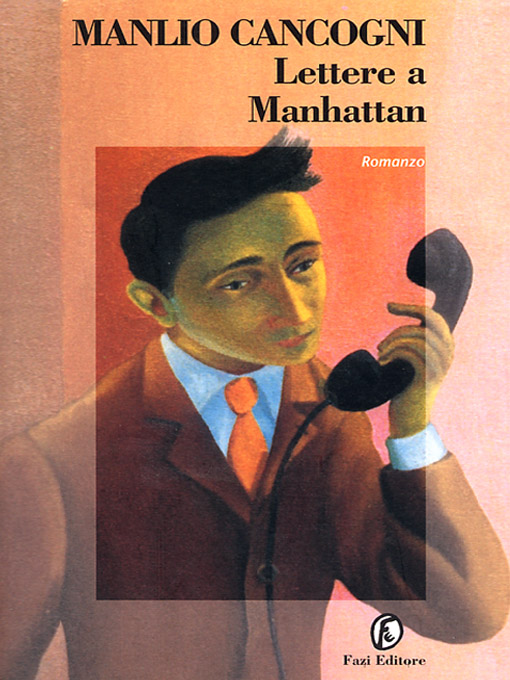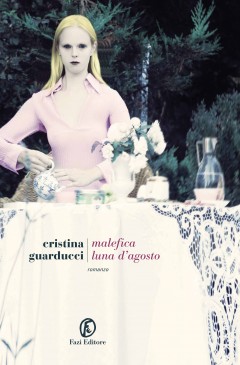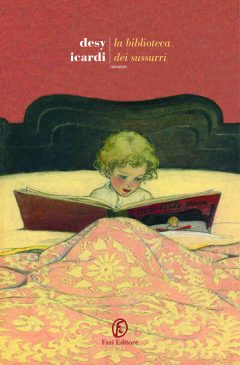Manlio Cancogni
Lettere a Manhattan
Lettere a Manhattan è il primo nuovo romanzo pubblicato da Cancogni dopo oltre dieci anni. La storia, che si svolge tra New York e il Connecticut, vede le imprese di due amici impegnati in una sgangherata tournée teatrale. Le avventure di Titus e Phil si tingono di giallo col procedere del racconto: c’è davvero in atto una macchinazione della mafia cinese per tenere lontano da Little Italy Titus e il suo progetto di diffondere di nuovo nel quartiere, attraverso il teatro, la madre lingua italiana? Oppure è solamente un’esagerazione morbosa, una fantasia frutto della mente esaltata del protagonista? Cancogni ci lascia col fiato sospeso, fino alla fine, quando Titus verrà colpito a tradimento durante una sconclusionata performance nelle strade di New York. Lettere a Manhattan è un romanzo lirico e drammatico, sospeso in una forza religiosa eppure venato di grottesco, il capolavoro della letteratura italiana di fine millennio.
Uno strano don Chisciotte si aggira per New York: vuol salvare la lingua italiana. Un nuovo romanzo di Manlio Cancogni
Little Italy tutto è perduto
Titus, originario della Lucchesia, con una faccia che ricorda Spencer Tracy, riscopre la nostra lingua e tenta di convincere gli altri emigrati ad ascoltare brani dei nostri classici. Ma la ricerca dell’identità perduta si rivelerà del tutto impossibile.
Uscirà fra pochi giorni presso l’editore Fazi un nuovo romanzo di Manlio Cancogni. S’intitola ‘Lettere a Manhattan’ (pagg. 140, lire 20.000) ed è forse uno dei libri più felici di questo scrittore e giornalista ottantunenne. Felice per freschezza d’inventiva, per semplicità di stile. E per l’argomento. Da molti anni Cancogni si divide fra la Versilia e gli Stati Uniti, dove viveva una sua figlia e ora abita un suo nipote. Vi ha lavorato come giornalista. Vi ha tenuto corso universitari. Vi possiede una piccola casa. In questo suo lungo racconto, parla dell’America da italiano. Ha trovato, anzi, il modo di unificare i suoi due connotati: quello di nostro connazionale e di periodico residente oltre Oceano. Il luogo ideale in cui si svolge il racconto è Little Italy, il quartiere degli immigrati nostrani dei primi del secolo. Una plaga decaduta di New York, odorosa di miseria ereditaria, risuonante di uno slang che sta a metà fra un inglese corrotto e un italiano dimenticato. Un quartiere nel quale la presenza dei nostri semiconnazionali viene insidiata, casa dopo casa, dall’invadenza dei cinesi. Chi conosce Cancogni sa che nulla potrebbe immaginarsi più lontano di lui dall’eloquio in uso in questa nostro patetica “piccola patria” piantata al centro di una metropoli lontana: dagli stanchi rituali che vi si praticano dalle sgualcite retoriche che, qualcuno continua a coltivarvi. E tuttavia, per un prodigio dell’inventiva, ‘Lettere a Manhattan’ lascia nel lettore una sorta di nostalgia storica. Quella che ne vien fuori è un’elegia di Little Italy. Cancogni è noto per gli intrecci “a due” dei suoi racconti. Il tema dell’amicizia percorre la sua narrativa, da ‘Azorin e Mirò’, un piccolo classico giovanile da poco ristampato, a ‘Il genio e il niente’ fino, appunto, a ‘Cos’è l’amicizia’. ‘Lettere a Manhattan’ si muove su quella stessa scìa emotiva. Due compagni d’infanzia, little italiani purosangue, di casa entrambi a Mulberry Street, allevati fra Canal e Huston, Lafayette e la Bowery, partono insieme per la guerra di Corea, ne tornano, coltivano un’inclinazione comune: quella teatrale. Phil la vive come un dilettante, e se ne distacca presto, preso da un lavoro di rappresentante. Titus persevera: diventa un “monologhista”, uno di quegli “artisti itineranti” che, soprattutto in passato, si esibivano qua e là per gli States, in cantine, piccole sale, circoli di amici, aule scolastiche. I due sono diversi. Phil, meridionale, sentimentale, è legato ancora alla patria di origine. Titus, italiano di Lucchesia, temperamento fiero fino all’arroganza, con una faccia che ricorda Spencer Tracy, è conquistato alla mitologia yankee. È tutto “Stars and stripes”, ha dell’Italia un ricordo angusto: un “paesuccio”. Ma poi, di ritorno dalla guerra, avviene la metamorfosi. Il monologhista Titus riscopre l’italiano come lingua e gli italoamericani come “genus” e di entrambe le cose diventa un propagandista. Con alterna fortuna, e fra l’attenzione ansiosa di Phil, degli altri “vecchi di Little Italy” e delle loro consorti, si dà a recitare in italiano brani dell”Adelchi’ e dei ‘Promessi Sposi’, canti danteschi ridotti in pillole. Vuol riportare in onore fra gli Italiani d’America, la lingua dei classici, sovrapponendola al loro sdrucito idioma ‘déraciné, mutando “il fango in oro”. Nata come un puntiglio, l’idea diventa una missione. Una ‘performance’ nel cuore di Little Italy, a Broome Street, sembra un trionfo, ma poi il progetto, perseguito con fanatismo, si scontra con la realtà. Nella “piccola patria” dei protagonisti, a New York, nell’intera East Coast e forse ovunque in America, l’italiano è irrecuperabile. Di Dante, Manzoni e simili, recitati in originale, nessuno sa cosa farsene. Titus si trasforma in un crociato. Quasi cerca il martirio. Si esibisce al chiuso e all’aperto, in quartiere inospiti, nel Bronx, a Queens. Informa di queste performances i suoi amici in lunghe missive orgogliose e drammatiche (donde il titolo ‘Lettere a Manhattan’). Le sue recite diventano qualcosa fra l’omelia e il comizio. Incontra un pubblico dapprima apatico. Poi insofferente. Alla fine ostile. Rissa, ragli, invettive, lancio di oggetti. Il monologhista viene arrestato più volte: disturbatore della quiete. Infine, durante un comizio tenuto in un parco dalle parti della Pulaski Avenue, fra polacchi, portoricani, neri, nell’empito della recita e della contestazione, il vecchio Titus cade, batte la testa e muore. La crociata in nome dell’Italo-America è interrotta, non ci saranno repliche. Da giovane, Cancogni pensava di fare l’attore e il suo innato individualismo lo spingeva a sognarsi “monologhista”. Da un reportage giornalistico di John Steinbeck apprese, molto più tardi, che questa varietà di artisti ha avuto qualche onore nell’America del primo Novecento, e ancoravi sopravvive. Ma in ‘Lettere a Manhattan’ l’autore non ha versato soltanto reminiscenze autobiografiche. Vi affiora anche una diagnosi: quel simulacro d’Italia, un po’ commovente, un po’ ridicolo, che s’era inserito in un angolo di New York scompare o perde i suoi connotati. L’Italoamericano”, dice Cancogni, “vuol far dimenticare di esserlo. Qualche residuo senso delle origini rimane nei sessantenni, nei settantenni. I figli non vogliono più saperne. Il loro terrificante slang è, dopotutto, a suo modo,inglese”. E i cinesi se la prenderanno Little Italy? “Può anche darsi che se la siano già presa, e che la lascino in vita soltanto perché la presenza di un ristretto ceto italo americano contribuisce a rendere quelle strade un po’ frequentate. Una vera riscossa degli italiani, laggiù, non so prevederla. In ogni caso, temo, sarebbe cruenta. A meno di un improbabile compromesso: che i cinesi, per esempio, si mettessero a parlare italiano…”. Con Little Italy scompare anche un particolare genere di “come eravamo”: pietanze orami ignote qui da noi (tipo “spaghetti with meat balls”); odori ormai “datati” e quasi irrecuperabili in patria. “Gli odori? Speriamo di no!”, esclama Cancogni. “New York è una città piena di odori piacevoli in maggioranza. L’unico che manca è, misteriosamente, l’odore della benzina, proprio quello in cui l’Europa sprofonda. Fra l’Oceano e l’Hudson, New York è la città più ventosa del mondo. Il vento disperde i miasmi “generali”. Senti invece gli odori locali, che ti si annidano accanto mentre cammini. Odore di trattoria, profumo di caldarroste, spiedini, hot dogs. Un odore caldo, che sa di spezie. Ma chi mi farebbe riconoscere New York a occhi chiusi”. A parte Little Italy (un quartiere che ha frequentato poco ma descritto a puntino), Cancogni si sente legato all’America. Non vive all’americana neppure quando si trova lì, la considera un mondo lontano che non sarà mai davvero suo. E però l’ama. Razionalmente. Politicamente. Ce l’ha soprattutto con l’antiamericanismo che serpeggia in ogni angolo della psicologia europea. “Si tratta”, così lo definisce, “di un mal di francese venato di ottusità storica. Sono infatti gli intellettuali francesi, i “philosophes” o ciò che ne resta, i principali sacerdoti di questa liturgia. Vedono nell’empirismo americano il nemico dei loro ideologismi. Mostrano nei riguardi del Nuovo Continente la gelosia dell’aristocratico che vide sottratta l’egemonia, rubati gli strumenti per possedere il mondo. E’ come se l’Europa non sopportasse che gli Stati Uniti – un paese di immigrati, di servi – siano diventati i loro padroni. E li abbiano salvati almeno due volte (forse anche tre, se ci si mette il comunismo) da morte certa”.
– 06/11/1997
Dante, un italiano a New York
Storia di amicizia e tradimento di una tournée teatrale per rinvigorire la lingua madre
Qualche tempo fa l’editore Fazi ha ripubblicato il bellissimo romanzo d’esordio di Manlio Cancogni ‘Azorin e mirò’ personaggi sotto le cui spoglie si celano, com’è noto, l’autore stesso e Carlo Cassola: un’edizione che, rispetto alle precedenti e lontane, si arricchiva di una venturosa e intensa introduzione di Sandro Veronesi e di una Nota di Simone Caltabellota. Il romanzo, che un critico di non cedevoli entusiasmi come Luigi Baldacci definì “il più importante racconto italiano del dopoguerra”, appariva nel 1948 su una rivista ormai leggendaria, ‘Botteghe oscure’ all’attenzione di un pubblico che avrebbe amato, di lì a poco, un capolavoro come ‘La giacca verde’ di Soldati o certe ‘Storie ferraresi’ di Bassani: fortunatissimi lettori, precoci testimoni di un Novecento magro e musicale, che si sarebbe delineato con sempre più nitore. La segnalazione di questo libro mi sembra doverosa, ora che lo stesso editore stampa un nuovo romanzo di Cancogni, dopo oltre dieci anni di silenzio. E tanto più se è vero che le note d’attacco di ‘Lettere a Manhattan’ sembrano annunciate un’amicizia di leggenda, simile a quella tutta letteraria che si racconta nel libro d’esordio: “Col grande Titus e il suo amico del cuore Phil, noi “vecchi” di Little Italy fino all’anno scorso avevamo mantenuto rapporti affettuosi ma piuttosto radi”. Un libro, letto oggi, di grande ambivalenza, di suggestiva ambiguità, se il giovane Caltabellota lo ripropone come il documento di una giovinezza ardente e tersa, mentre Baldacci, con più disciplina storica, vi scorgeva esattamente come la reazione autocritica ad un clima di rarefazione stremata, di sublimi disimpegni, forse sostenuta dal modello flaubertiano di ‘Bouvard et Pécuchet’: il clima ermetico degli anni che precedettero la seconda guerra. L’ambiguità di ‘Azorin e Mirò’, attestabile al livello della ricezione critica, si ritrova in questo misterioso romanzo, ma come dato costitutivo, se non addirittura programmatico. La storia si svolge tra la Little Italy e il Connecticut: e vi si riconosce la veloce intelligenza di vita che c’è i ‘America primo amore’, per personaggi che potrebbero essere i figli di quelli soldatini. Titus Bovini, attore monologhista ormai sessantenne, irrompe concitato e tumefatto nella vita di Phil Miraglia , l’amico con cui aveva condiviso tutto, persino la guerra di Corea. V’irrompe con un sogno che si muta presto in ossessione religiosa: quello di restaurare a Little Italy l’italiano di Dante e di Manzoni attraverso una serie di spettacoli teatrali, salvando la comunità dall’invasione dei cinesi e della loro mafia. L’ilarotragica storia di questa ‘tournèe’ si rivelerà, fino al suo drammatico epilogo, come la straziante vicenda di un tradimento,. Quello del fanatico Titus, marito crudele e insensibile, sempre più livido e assente, barricato nella sua ostinazione: il tradimento di chi, nei vecchi compagni, ha cercato complicità piuttosto che amicizia. Quello dell’angoscia e volubile Phil, incalzato dal buon senso della moglie, sempre più propenso a vedere negli ideali di Titus i segni di un delirio senile. Ma è davvero questo il romanzo della disillusione e del tradimento? Nell’incantato finale – ecco l’ambiguità – la morte di Titus – il messia di un’esilerante religione che ha saputo parlare, però, al cuore delle donne-sembra resuscitare dentro una luce limpidissima, il mito del “grande amico”. Phil, sconvolto, si trova nel punto esatto dove Titus è morto, quando vede l’acqua sorgere dall’erba gorgogliando: “Vi immergemmo le dita: era fresca e viva come quella di una polla di montagna”. Freschissimo Cancogni! E se Titus avesse avuto ragione ?
Manlio Cancogni
Lettere a Manhattan
Le parole sono la vita” dice l’italoamericano Phil Miraglia nella battutachiave dell’ultimo romanzo dell’ultraottuagenario Manlio Cancogni, tornato felicemente alla narrativa dopo dieci, anni dimostrando fra l’altro una freschezza e un’energia affabulatoria tutt’altro una freschezza e un’energia affabulatoria tutt’altro che senili. Numerosi sono gli ingredienti e le suggestioni che sprigionano da un racconto scritto con apparente semplicità, ma che nasconde più anime di quanto non appaia a una lettura superficiale. In principio era il verbo. Perciò Titus Bovini, sessantenne americano di origine lucchese. Attore fallito diventato poi rappresentante di vini toscani, un mezzo matto claudicante e dalla voce chioccia, si mette in testa con folle ostinazione di organizzare un tour nei teatrini statunitensi per recitare in italiano le opere di Dante e Alessandro Manzoni. Assistito dalla moglie succube e aiutato da un’armata Brancaleone di amici;ora trascinati dal cialtronesco carisma del leader, ora perplessi ed esitanti, Titus intraprende l’improbabile tournèe come una missione salvifica. Si tratta di un atto di risarcimento patriottico, dopo che per tutta la vita si è vergognato delle proprie radici e ha esaltato la grande e ariosa America, sparlando continuamente di un’Italia piccina e gretta. Ubbidendo al “formicolio dell’anima”, dichiara una guerra impossibile e patetica agli Stati Uniti: forte di un coraggio incosciente, pretende di ammaliare le folle con il puro suono della lingua madre, di tener testa alla mafia cinese con il progetto utopistico di fondare un teatro italiano a Little Italy, di demolire la moda del politically correct divulgando la santità dell’Innominato (perché “l’arte può far diventare bella una cosa brutta”). Come per il personaggio manzoniano, anche quella di Titus è la storia di una conversione, testimoniata con fede incrollabile sino al martirio: la fede nella forza e nella pericolosità della parola, nella sua stabilità in un mondo dove tutto cambia rapidamente, nella sua capacità di compiere miracoli e trasformare in oro anche il fango. Detta così, si capisce come una storia simile corresse il rischio della retorica, dell’apologo edificante o dell’elogio passatista. Domina nel romanzo un senso di perdita irreparabile, ma il tono leggero e scanzonato, mai predicatorio, produce sul lettore un effetto di disincanto e la sua miscela di buffo e straziante ricorda “Caccia alle farfalle”, malinconico film di Oscar Iosseliani che potrebbe piacere a Cancogni. Il quale condisce la narrazione di umori beffardi e, sul filo dell’ironia, sembra sempre sul punto di rovesciare la storia in una parodia di se stessa. E invece rimane in mirabile equilibro tra parabola sacra e farsa picaresca, perché riesce con abilità a prendere in giro il suo eroe suonato e a conferirgli però la nobile dignità di un Don Chisciotte della parola. Nell’umanissimo personaggio di Titus è ridicolizzata ed esaltata insieme la figura dell’artista: un egoista maldestro e ipocondriaco mosso dal disperato bisogno di comunicare al prossimo, un fanatico megalomane che insegue la vana ossessione di salvare il mondo con la letteratura. Cantando le tragicomiche gesta del suo profeta scalcinato, lo scrittore gioca in parallelo con i testi messi in scena da Titus (l’esiliato Dante e la tragedia del “volgo disperso” nell’Adelchi manzoniana) e racconta la ricerca di un’identità da parte di uomini spaesati dal vertiginoso cambiamento del mondo. Tocca qua e là molte tematiche che da tempo gli stanno a cuore: allude pudicamente al valore del paradosso della vita di Cristo e compone una delicata elegia dell’amicizia virile quando indugia con finezza sul rapporto tra Titus e Phil, l’amico bravo e intelligente, pieno di buon senso borghese e di generosità, ma privo di follia, e dunque privo di fede.
Una storia rapida e incisiva
A Manhattan con Cancogni
La storia raccontata da Manlio Cancogni nel suo nuovo romanzo, ‘Lettere a Manhattan’, ci ha ricordato un racconto di Cynthia Ozick, ‘Invidia ovvero Lo yiddish in America’. Romanzo e racconto, ambientati in due comunità, quella ebraica e quella italoamericana di New York, la cui lingua d’origine va in diverso modo estinguendosi, trattano l’uno dell’invidia di uno sconosciuto poeta in yiddish per un collega ricco, famoso e soprattutto tradotto, e l’altro di un folle progetto per far rivivere l’italiano non lo parla più. Non è solo una questione di tema o di ambiente, New York appunto, e la provincia americana, è la scrittura stessa dell’ottantatunenne Cancogni che si adatta benissimo allo sfondo newyorkese: una prosa senza fronzoli, velocissima , con dialoghi e narrazione perfettamente armonizzati, di una secchezza inconsueta per lo standard prezioso e letterario della prosa italiana; al punto che, siccome la storia è raccontata da un amico dei due protagonisti,un italoamericano che ci immaginiamo anglofobo, capita spesso di pensare a ‘Lettere a Manhattan’ come alla traduzione italiana di un originale inglese. La trama: Titus Bovini, attore teatrale di qualche successo in passato, ma ormai in declino, dopo aver trascorso una vita a cercare di soffocare le sue radici in Little Italy, per un’improvvisa folgorazione sulla sua via di Damasco decide di dedicarsi alla rinascita della lingua dei padri. Coinvolge nel suo progetto Phil, l’amico di una vita, e a poco a poco gli altri amici di Little Italy: le lettere a Manhattan, quasi delle lettere paoline a una comunità di evangelizzati, sono quelle che Titus scrive agli amici dalle varie tappe di una tournèe provinciale in cui recita i nostri classici perché si preparino nel modo migliore al suo arrivo e al suo apostolato. Il libro si regge tutto sulle due opposte possibilità . Titus è impazzito, la vecchiaia, l’insuccesso gli hanno dato alla testa, ed ora, infelice e megalomane, si è inventato un ruolo messianico; oppure, la malattia di cui ha sofferto stata veramente l’occasione per la chiamata ad una missione che italiani in America. Insomma, avrà ragione la ragionevolissima moglie di Phil, che mette l’accento sull’egoismo, La crudeltà, la vanità di Titus, o avranno ragione le fedeli seguaci che egli trova a Little Italy? Cancogni, lealmente, rende conto sia dell’assurdità che delle nobili ragioni dell’irrealizzabile disegno. C’è un unico punto in cui sembra sbilanciarsi, nella mezza pagina del finale, ma anche lì nulla è assertito: il nostro obiettivo testimone non fa che riferirci un fatto, spetta a noi vederci una coincidenza o un segno divino, forse nemmeno Cancogni sa, o ha deciso: a lui come a noi manca la fede assoluta che Titus richiede; c’è però una disponibilità incredula, se così si può dire, a coglier la presenza del soprannaturale non solo nel quotidiano, ma addirittura nel grottesco.
Il messaggio religioso percorre le pagine di “Lettere a Manhattan”
ANNUNCIANDO IL VERBO A LITTLE ITALY
E’ una vecchiaia operosa, quella di Manlio Cancogni. Anzi, una seconda giovinezza, una straordinaria estate di San Martino umana e letteraria. Ottantadue anni portati in modo gagliardo, dopo un decennio di silenzio quest’estate è tornato nelle librerie. E non con uno, ma con due libri nuovi. Il primo – del quale offriamo in questa pagina un ampio estratto – si intitola “Caro Tonino” ed esce per i tipi della Galleria Pegaso di Forte dei Marmi (pagine 94, lire 15.000), la raffinata sigla editoriale di cui lo stesso Cancogni cura da tempo le pubblicazioni. Si tratta di una lunga lettera immaginaria all’amico Antonio Cederna, il combattivo ambientalista morto nell’autunno scorso. Ma è anche e soprattutto un atto d’amore verso la Versilia, la terra che il giramondo Cancogni (è stato a lungo inviato speciale di giornali prestigiosi) ha sempre amato e che il 19 giugno 1996 è stata devastata da quello che nel sottotitolo di “Caro Tonino” viene definito “diluvio”. Il legame con le proprie origini e la fiducia nell’amicizia sono i temi portanti anche della seconda novità di Cancogni arrivata di recente in libreria, il romanzo “Lettere a Manhattan”, pubblicato dall’editore romano Fazi (pagine 140, lire 20.000), che l’anno scorso aveva riproposto “Azorin e Mirò”, che dello scrittore toscano è giustamente considerato il capolavoro giovanile. Un filo sottile eppure visibilissimo lega i due libri. In “Azorin e Mirò” (apparso per la prima volta su “Botteghe Oscure” nel 1948) la cronaca di un’amicizia destinata a durare tutta una vita viene infatti ripercorsa fissando il fuoco della prospettiva nell’inizio del rapporto fra due ragazzi innamorati della letteratura. Uno di loro, Mirò, rinuncerà alla scrittura per vivere una vita apparentemente anonima, che tuttavia appare ad Azorin – divenuto invece letterato di professione – percorsa in modo misterioso dalla grazia. Anche Titus, il protagonista di “Lettere a Manhattan”, ha condiviso con l’amico Phil una stagione di entusiasmo artistico, cercando di sfondare sui palcoscenici di Broadway. Impresa non facile per un ragazzo di Little Italy, il cui inglese, per quanto corretto, conserva sempre qualcosa di metallico, di scolastico. Phil abbandona senza rimpianti e si consegna alla tranquilla esistenza della “middle class” americana. Titus, invece, non si rassegna e, dopo un’esistenza divisa tra il commercio e l’attività di attore di monologhi in giro per gli States, arriva finalmente a capire che la lingua di Shakespeare non gli appartiene, non può appartenergli. Il suo compito – o meglio, la sua missione – consiste nel restituire ai disorientati italiani di Broccolino la bellezza di una terzina di Dante o di un capitolo di Manzoni. A tutti i costi, dovesse anche rimetterci la vita. Condotto con sapienza sul filo della metafora (per Titus l’italiano è in realtà “figura” del Verbo, cioè di Cristo), “Lettere a Manhattan” è finora il romanzo che con maggiore chiarezza rende conto del percorso spirituale compito da Cancogni in questi ultimi anni. Una conversione silenziosa e profonda, che affiora anche in quel passaggio di “Caro Tonino” in cui, contemplando la devastazione della sua Versilia, lo scrittore pronuncia questo atto di fede: “Rimarrà nella realtà. Capisci che cosa voglio dire? Il tempo, lo sappiamo bene, è un’illusione. Con la morte finisce: c’è solo l’Essere”.
FUGA IMPOSSIBILE DA LITTLE ITALY
Dopo dieci anni di silenzio, Manlio Cancogni ha portato a compimento un nuovo lavoro narrativo. Lo scrittore bolognese, autore di diversi romanzi fortunati, ora giunto oltre la soglia dei novanta anni, inaugura così una nuova stagione della sua scrittura. “Lettere a Manhattan” è un romanzo breve, ambientato nell’America della East Coast, dove due italo – americani, Titus e Phil, concepiscono il progetto di riconquistare culturalmente l’antico quartiere della comunità italiana di New York. Little Italy rischia, infatti, l’invasione del popolo cinese al seguito della mafia affaristica. E’ il febbraio del 1986, quando Titus annuncia al vecchio amico Phil il suo arrivo nel Connecticut e, col volto già pestato da oscuri nemici, gli propone l’ardua impresa. Il mezzo sarà il teatro: speciali recite in italiano di alcuni brani di Manzoni. Phil sentimentale e nostalgico dell’Italia è dominato da Titus, ben deciso a diventare pienamente americano, dimenticare lo slang, e fuggire da Little Italy dietro il miraggio della carriera artistica. Titus, nelle lettere all’amico Celso di Manhattan, spiega, con lucidità sospetta, quasi da ossesso, come tutto si fonda sulla necessità di appropriarsi di nuovo di una lingua pura, vincendo le resistenze di anonimi nemici. La trama del romanzo prende quindi un ritmo esilarante: la troupe dei due amici, e rispettive consorti, affronta impavida club e collegi di provincia, con i monologhi di uno strano attore zoppo, declamante la lingua manzoniana. Ma dopo i primi effimeri successi, tutto si disgrega. Titus si isola nella sua idea fissa, mentre si svela la fallacità del nobile ideale: la lingua è una realtà inconsistente se non è utile, come inesistente è ormai l’identità italiana negli States. Cancogni ha orchestrato una commedia dal ritmo perfetto, che mette in gioco, con toni comici, la drammatica esclusione dalla società, e dalla vita, del folle che insegue l’ideale della purezza. Titus ha cercato, nell’inglese prima, e nell’italiano poi, di fuggire la “contaminazione” necessaria alla vita e all’espressione. Sarà soddisfatto solo nell’ultimo atto, quello narrativamente più debole, in cui Titus diviene un predicatore di strada destinato a cadere sotto la violenza dei bassifondi newyorkesi. La sua resurrezione finale, in forma di sorgente d’acqua pura, chiude la storia con una nota sospesa di speranza e di rinnovata follia, mentre le donne italiane corrono a bagnarsi la fronte alla corrente salvifica.
MANLIO CANCOGNI
Utopia della Parola
Sino al 1987 scrittore prolificissimo, “intramontabile ma dispersivo” ( così Pampaloni ), Cancogni esce da un decennale silenzio di riflessione con ‘Lettere a Manhattan’, romanzo singolare non tanto nella macrostruttura quanto nel modo di raccontare e nei materiali con cui e su cui è plasmata la storia. Il ‘topos’ del Profeta ovvero di colui che si fa propugnare e propagatore di un’idea costi quel che costi: sul piano personale, familiare, delle amicizie della vita stessa perché “in una cosa ci credi o non ci credi. Se ci credi devi avere coraggio di andare fino infondo” è così in ‘Lettere a Manhattan’ la storia dell’utopia di Titus Bovini e della sua disinteressata volontà di ridare dignità a Little Italy e ai suoi abitanti debarbarizzandoli dalle espressioni linguistiche d’un inglese mai ben acquisito. Un’utopia presto tradottasi in ossessione proprio per le continue difficoltà che si frappongono e che Titus legge anche paranoicamente quali intrusioni malavitose di chi è invece più interessato a investimenti edilizi nel quartiere. Una ossessione che l’ex attore monologhista in attesa di inaugurare il suo Matelda Teather, cadenza nella recita in italiano di passi manzoniani (L’innominato, l’Adelchi) e danteschi (dal Purgatorio) in teatrini improvvisati da varie comunità italiane circondato dalla moglie Emma e da amici rivisitati nei loro dubbi , distacchi, e fascinazioni. Perché Titus carattere bizzarro e per nulla facile agisce da elemento di contraddizione con la sua intransigente predicazione che non ammette compromessi. Richiamare i materiali che sottostanno al libro significa allora anche leggere l’utopia della “riappropriazione della lingua – Parola” di Titus come metafora della radicalità delle scelte da condurre “usque ad mortem, mortem autem crucis”. Ciò che va di pari passo col ben noto destino di disprezzo dubbio e umiliazione che, nel caso di Titus vede sostituirsi alla croce la non certo più nobile lapidazione nel Queen’s : con righe conclusive che dicono addirittura d’un passaggio dal martirio alla santificazione popolare con tanto di attingimento di reliquie; il che mi pare eccessiva forzatura narrativa e metaforica in un racconto la cui religiosità è semmai tutta interiore e aperta comunque all’utopia del non – religioso. È su tale andamento che Cancogni costruisce il racconto ambientato in una New York 1986 e affidato a una voce fuori campo ma agente dall’interno del gruppo pur senza qualificarsi : coinvolta “sapienziale” (“noi vecchi” si lascia sfuggire) da testimone narrativamente evangelico che poi nelle quattro Lettere di Titus e Celso si vede accostare una fraseologia in taluni passo richiamante le ‘Epistulae’ Paoline (l’incipit della quarta ricalca addirittura quello di Ad Philippenses). Qui Cancogni pesca il substrato narrativo: dai nomi, alla storia stessa di Titus calibrata prevalentemente sulla vicenda di San Paolo sia nel momento persecutorio (antitaliano) che in quello della folgorazione (a providence: con tanto di caduta a terra), mescidata con momenti della figura di Gesù (la recita al Central Park somma Montagna del Discorso e Monte degli Ulivi); dalla pregnanza data alla Parola, al ruolo delle donne, le “meglio disposte ad accogliere la parola se è una parola di vita”, e le più fedeli anche quando gli amici – discepoli dubitano o tradiscono; al contrasto con la moglie Emma che riproduce parole brusche di Gesù a Maria sulla propria missione a altro ancora. A render fluido il racconto ci pensa poi un ritmo rapido cadenzato da limpida prosa; e con tratti anche esilaranti. Ma amaramente; perché monta pian piano un tono che lo sguardo interrogante tra fascino della verità – utopia e inestinguibile dubbio qualifica come malinconia esistenziale.
– 05/01/1997
Arnaldo Colasanti
Letture per cambiare la vita
Nonostante contenga tre vistose, severe, stroncature, Novanta di Arnaldo Colasanti non è solo un libro polemico ma un testo tessuto di richieste precise, di necessità dichiarate. I libri devono cambiare la vita, la letteratura deve distinguere ciò che conta da ciò che risulta fungibile, chi scrive deve sentire il peso della scelta, deve conoscere il fallimento e il buio. Quasi tutte le recensioni hanno messo in rilievo l’asprezza di certi giudizi. In realtà il nucleo più profondo di Novanta è nella tregua, nelle pause fra una polemica e l’altra, lì dove si mostra in tutta la sua inermità l’idea di una critica che esige capolavori, che indica nella pratica della vendetta obliqua e del compromesso, la malattia mortale di una letteratura incapace di uscire da se stessa e di decifrare il mondo. Si può non essere d’accordo su alcuni giudizi espressi da Colasanti ma il loro tono, quello che potrebbe apparire un eccesso nasce dal rifiuto di una scrittura che si accontenta di un orizzonte ridotto, che scambia la sua profondità con qualcosa di esterno e inessenziale. E’ il caso della “stroncatura” del libro del Papa ingiustamente frainteso da chi ha raccolto l’intervista. Eppure, perché un cristiano non dovrebbe esigere dal vicario di Cristo il massimo di profondità spirituale?, perché non dovrebbe dire la sua delusione rispetto a un linguaggio, a un pensiero inferiori alla forza di quel “Non abbiate paura” con cui si aprono le pagine di Varcare la soglia della speranza? Novanta non è il breviario di “un’anima bella” ma una meditazione drammatica sulla responsabilità della letteratura, fin dalla prima fase: against dryness, atto di accusa contro la miseria delle istituzioni ma insieme volontà di combattere fuori di noi, ciò che comunque esiste in noi. Mi sembra che Colasanti sia severo prima di tutto con se stesso: la sterilità, la tentazione del potere, in fondo la possibilità di accantonare i propri sogni, la rinuncia a realizzarli non sono pericoli lontani ma opportunità, disattenzioni spesso impercettibili. Colpisce nella sequenza dei capitoli il divario esistente fra l’indignazione sulle opere e il riconoscimento dell’infelicità delle creature, il tono sommesso di alcune, bellissime epifanie. Ma è un divario apparente. In entrambi i casi infatti la posta in gioco è il destino della scrittura, il suo intrecciarsi alla vita. “Leggere e scrivere. Cioè cambiare la vita” dice Colasanti nell’ultimo capitolo in cui parla degli autori che ama: da Oe Kenzaburo a Yaakov Shabtai, a Pasqual Quignard a Janet Frame. Nomi distanti, diversi che tuttavia si potrebbero incidere per spessore etico sulla massima di Leonardo Bruni, vera e propria figura dell’intero libro: “Non fare niente con paura, niente con arroganza, niente con avarizia, niente con ira, niente con ingiustizia, niente con volgarità”. Tutto si stringe in quel “nil” che non è il nulla, ma un “luogo dell’ardore” e della scelta, non un vuoto ma un niente che sostiene, che costruisce. In questo spazio di nudità la scrittura rivela se stessa, racconta la solitudine di chi scrive e di chi legge, riconosce il mondo nella gratuità della conoscenza. L’indignazione nasce quando lettura e scrittura tradiscono se stesse per diventare strumento di dominio, luogo di rancore. Allora i confini si confondono, i vizi si moltiplicano e crescono gli uni sugli altri. A questo si può rispondere solo salvando l’unicità dell’emozione, quel “nulla della vita” che non è nichilismo ma esperienza di profondità. Il problema è piuttosto un altro: può un’aspirazione critica di questo tipo essere davvero militante o questo fatalmente la condurrà a una dispersione, al dover comunque convivere con una società letteraria da cui non è sempre facile prendere le distanze? Può davvero realizzarsi quel doppio respiro reclamato da Marina Cvetaeva per il critico, o il respiro è mozzato e solo la lontananza può davvero aguzzare lo sguardo? E’ una questione aperta ma chiedere che lo sguardo della critica fissi oltre il passato e il futuro anche il proprio volto è una richiesta semplice e altissima – una vetta – che occorre scalare con la coscienza della vanità del cammino. Leggere, scrivere sono la concretezza dei passi e l’aria del monte che non è detto si raggiunga. Per questo c’è differenza tra “difendere il proprio lavoro” e lasciare che questo lavoro accechi fino al rancore più o meno aggressivo perché non si è abbastanza apprezzati o segnalati, o inclusi nei premi. Non si tratta di essere buoni ma di sapere che l’angustia, l’arroganza, l’invidia possono essere combattute, che o la letteratura consente di fare un passo oltre se stessi oppure è inutile, perché è diventata un’altra cosa: evasione, finta polemica, esercizio di potere, lettera morta, appunto, conformismo.
Libri dello stesso autore


Matelda
Manlio Cancogni