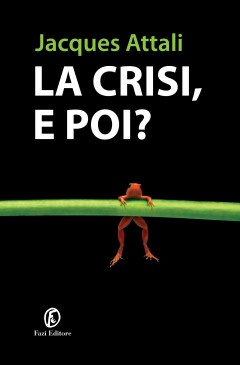Manlio Cancogni
Matelda
Racconto di un amore
Matelda è il racconto della passione di una vita. La passione è quella per la poesia, e i protagonisti di questa storia d’amore, a metà strada tra autobiografia letteraria e uno “strambo memoriale”, come lo definisce l’autore, portano i nomi di Ungaretti, Montale, Penna, Betocchi, Caproni, Giotti e Luzi. Con Matelda, opera davvero unica nel panorama letterario di questo fine secolo, Cancogni disegna uno straordinario e ben preciso ritratto della nostra tradizione poetica, rovesciando il canone a favore di esperienze appartate, incrociando il giudizio di valore con la propria storia di uomo e di scrittore, raccontando se stesso e la storia d’amore che continua a segnare i suoi passi.
«Le avversioni, gli innamoramenti, i gruppi, i premi, le dispute: tutto un mondo attraverso il filo rosso dell’amore per la poesia… una sorta di diario, assieme a un’autobiografia letteraria e un catalogo dei grandi classici del secolo, visti con gli occhi dei ragazzi che li leggevano allora, freschi di stampa».
Ermanno Krumm, «Il Corriere della Sera»
«Una memoria calda, onesta e fulminante… il libro è pieno di ritratti indimenticabili».
Enzo Di Mauro, «il manifesto»
– 03/11/1998
IL VERSO DEL CIGNO
UNGARETTI ERA CAPACE di quella malignità che richiede grande candore. Quasimodo forse non meritò il Nobel ed era circonfuso da un’aura antipatica, probabilmente per via dei baffetti e del riporto color carota. Penna era un giovanotto con l’aria invecchiata e gli occhi giallastri, spiava i ragazzini e ronzava sempre intorno ai pisciatoi pubblici: lì nascevano i suoi “fiori senza gambo”, germogli della sua sofferenza. Montale sognava di fare il baritono, era sempre ben rasato, camminava impacciato, a piccoli passetti: solo se nessuno lo vedeva si muoveva disinvolto e agile. Saba amava Dante e Verdi, riteneva che Leopardi avesse scritto un bel verso e basta: ‘E chiaro nella valle il fiume appare’. Tutto il resto, ripeteva cantilenante, “xe culo, xe culo, xe culo…” Maledetti toscani, ce ne sono ancora? Oh si, certamente. Ma oggi pensiamo ai comici, forse prima di tutto a Benigni. Più che a scrittori e poeti. Senza peli sulla lingua, a ottantadue anni, Manlio Cancogni, scrittore e grande giornalista – da tempo ormai vive tra Fiumetto e New York – pubblica un piccolo libro che fruga tra le corone d’alloro con la spudoratezza delle passioni e delle avversioni di un maledetto toscano. Con lo sguardo cangiante dell’innamorato che, poi, magari si disinnamora e guarda l’oggetto del desiderio ridimensionarsi senza pietà. Se fosse un dongiovanni, adesso correrebbe dietro all’ultimo poeta di grido; lui invece chiude tornando a Dante, alla poesia mistica degli spagnoli del Cinquecento, agli Inni sacri di Manzoni. Resta fedele solo a Luzi e Betocchi. Dopo aver amoreggiato con un bel po’ di poeti e di glorie patrie. ‘Matelda. Racconto di un amore’, appena uscito da Fazi, doveva essere un saggio per ‘Paragone’, commissionato da Cesare Garboli. Strada facendo, è diventato un’altra cosa. Qualcosa che sta a metà tra il diario intimo e il racconto inversi: cesellato da rime imparate a memoria, intarsi inframmezzati di ricordi personali, incontri, scoperte e disillusioni, fatti della storia degli ultimi sessant’anni. È stato scritto in un’estate caldissima, nel 1994, a New York, durante i mondiali di calcio. Pieno di curiosità e di aneddoti, il racconto di Cancogni stupisce per la sua particolare andatura: sono i versi che si rincorrono a dar senso agli eventi, piccoli e grandi. La poesia intrecciata alla vita, quando le due cose sembrano aver consumato per sempre il loro tardivo divorzio. È da un bel pezzo che i poeti hanno smesso di dar senso alla nostra esistenza, non li legge più quasi nessuno. “Una bella responsabilità è della scuola”, attacca subito Cancogni. “Se la poesia non s’impara a memoria si dimentica, è quasi ovvio. Del resto è ricordandola che la scopriamo, magari per abbandonarla. Come in amore, uno improvvisamente si dice: che sbaglio ho fatto, nn lo amo più!. Cancogni affila la sciabola: “La verità è che se ne può fare a meno. Sono stati i maestri del pensiero: la poesia non è irregimentabile e loro l’hanno combattuta a morte. Perché hanno bisogno di formule e di schemi. In principio è stato per ragioni molto serie: se nel 1943 mi avessero chiesto, preferisci salvare la poesia o vuoi la sconfitta dell’Asse? Io stesso avrei messo un bel frego su tutti i poeti. Poi, finita la guerra, la prosa sembrava il veicolo più adatto per comunicare, nonostante che la poesia sia stata regina della nostra tradizione letteraria e il romanzo, ancora fino agli anni Trenta, una cosa un tantino volgare. L’astio ha toccato il massimo negli anni Sessanta, con la neo-avanguardia: la poesia in quanto tale, anche quella che si trova nei romanzi, è diventata fonte di alienazione, evasione e tradimento, nemica dell’ordine costituendo. A temere di più i poeti, infatti, sono quelli che hanno in mente la città futura: l’ordine costituendo, da quieto punto di vista , è sempre molto più pericoloso di quello già costituito”. Aiuto, il Gruppo 63! Tutto il potere che gli è stato attribuito, retrospettivamente, sembra un po’ un mito assassino: colpa loro se la poesia è defunta…Non è un po’ troppa questa onnipotenza? “Sono diventati i padroni degli uffici editoriali, contestazione in cattedra”, prosegue Cancogni. “La neo.avanguardia è stata nemica della libertà, costrittiva come ogni ideologia. È troppo facile dire che per la poesia non c’è più posto perché hanno vinto il mondo moderno, il traffico urbano e il puzzo di benzina… No, non ci credo: tanto più la realtà è impoetica, tanto più le smagliature servono, sono necessarie. Mi rinfaccio alla distinzione Kantiana tra fenomeno e noumeno, per dire che se la vita diventa sempre più apparenza, la verità poetica è indispensabile. Cioè il contrario di quel che pensano i teorici dell’avanguardia: nella poesia, loro hanno visto una faccenda consolatoria, compensatrice delle ferite del mondo reale”. Eppure anche Cancogni, tra amore e disamore, guarda severamente i poeti. Lo dice già col titolo del suo “strambo memoriale” : Matelda, infatti, è la figura che appare a Dante nel ventottesimo capitolo del Purgatorio e poi lo accompagna nei successivi. Una donna soletta, che non fa il suo nome, e “…’si gia/cantando e scegliendo fior da fiore/ ond’era pinta tutta la sua via”. È simbolo di una virtù attiva, contrapposta all’auto-contemplazione sterile Matelda è la poesia abbandonata dai poeti, che ormai prima “godono del proprio io fino all’ineffabile”. Il referto dice: morte per narcisismo. “Non poteva che finire così”, riprende Cancogni. “In Italia ci sono trenta-quarantamila persone che scrivono versi, ogni anno escono almeno diecimila libretti e, per ognuno, non ci sono neanche cinquemila lettori! Ha vinto il petrarchismo, gli ultimi poeti sono adoratori di se stessi, grandi narcisi. Sono pochi i figli di Dante, quelli che non si fermano ai loro sublimi patemi. Per me, la vera poesia è oggettiva. E poi c’è un deperimento del linguaggio poetico. Il verso libero non lo sopporto: se non c’è metrica, è come guardare una partita a tennis sena rete e senza righe. A chi interessa? La poesia si è volontariamente ridotta a linguaggio non cantato. Forse perché non si sopporta più quella che, in fondo, è una retorica. ‘Vaghe stelle dell’Orsa io non credea’… Capisco che può dar fastidio; anzi, ormai lo dà persino a me. La poesia è anticamera della preghiera. Oggi ci sono molti poeti bravissimi: ma, se non c’è questo, a che vale? È meglio il calcio”. Eppure, sfogliando la margherita, due poeti sono rimasti: Mario Luzi e Carlo Betocchi, cui il libro è dedicato. “Mario l’ho conosciuto prima della guerra”, racconta Cancogni. “Era, con Alfonso Gatto e Attilio Bertolucci, uno dei giovani eminenti. Alfonso era amabilissimo, Luzi è sempre stato un uomo difficile, mi metteva in soggezione, cosa che non provavo per Montale e Ungaretti, mentre sarebbe stato più giustificato. Quello che mi seduce, in Luzi, è la capacità di trasformarsi: se c’è uno che è cresciuto, che si è evoluto anche con i risultati discutibili, è lui. In Montale c’è già tutto all’inizio: vocabolario, filosofia, perfino il lamento che alla fine diventa fastidioso. Luzi invece è un continuo aprirsi verso qualcos’altro. Per me, la grande poesia resta legata alla metafisica: in Luzi questo è evidente; in Betocchi c’è in più la concretezza delle cose. La realtà santificata dal Verbo, che si fa carne”. Nella memoria di Cancogni, nelle sue scelte di gusto, appare dominante la polarità che oppone Sandro Penna a Eugenio Montale. “Penna è, in apparenza, trasparenza assoluta. Epifanie dettate in sogno, lui diceva che non faceva altro che trascriverle: io non ci credo molto. l’incanto veniva da un patimento enorme: non era l’innocenza del peccato, Penna soffriva moltissimo e viveva imbottito di farmaci, suoi squarci di paradiso nascevano lì. Anche il rugginoso almanaccare di Montale era rotto da meravigliose aperture ‘E fuori, dove un’ombra sola tiene / cielo, mare / dai ghiozzi sparsi palpita, l’acetilene’. Ecco, anche qui, c’è la felicissima epifania dell’acetilene. La differenza è che Penna manca l’almanaccare: l’impoeticità dell’esistere non si vede…” Roma, Firenze, Milano, Parigi…eppure – nel libro di Cancogni, “versiliese cresciuto in esilio” -à tutto sembra tenersi sotto un unico orizzonte: la Versilia appunto. Lui dice che “è la poesia, la mamma” Elenca le passioni che hanno preceduto i poeti nella sua immaginazione di ragazzo: il viaggio in treno verso la Versilia, la geografia, lo sport, l’iconografia della prima guerra mondiale. È lì che sta tornando: “Ungaretti e Montale non esisterebbero, come poeti, senza la Grande guerra, fine di un’epoca tremenda e necessaria espiazione, pagata da milioni d’innocenti…”. Ora che si conteranno i petali caduti. E quelli che la mano non ha sfiorato neppure, per i poeti esclusi e negletti, Cancogni fa ammenda. “Non sono un critico letterario. Mi dispiace soprattutto per Bertolucci e per Parronchi. Che posso dire? Non ci si può innamorare, se almeno una volta non ci si incontra”.
– 03/11/1998
La Matelda di Dante e la poesia del Novecento
È la storia di un amore inossidabile, che ha percorso la vita intera di un uomo, e insieme tutto il Ventesimo secolo tra guerre, fascismo, liberazione, ricostruzione. Lo racconta Manlio Cancogni, classe 1916, nell’ultimo libro edito da Fazi “Matelda racconto di un amore” (1998, 22 mila lire). Matelda è la bellissima donna che appare a Dante nel Paradiso terrestre “cantando e scegliendo fior da fiore/ ond’era pinta tutta la sua vita” ed è simbolo, per il fiorentino, di una nuova volontà poetica irradiata da un amore più alto, che lo prepara alla contemplazione della Verità. Anche per Cancogni “Matelda poesia” vale per ciò che essa “detta dentro” ed è innanzitutto un atto di fede, una passione e una vocazione che lo ha confortato nelle situazioni drammatiche dell’esistenza e lo ha accompagnato da sempre in giro per il mondo. Ci troviamo ora a Parigi, dove Ungaretti presenta alla Sorbonne il suo libro di poesie, ora in un’osteria fiorentina con Montale e Gadda, ora all’università del verde e ondulato Vermont, ora a Roma in una libreria di via della Mercede, dove appare per la prima volta grigio e avvolto in un soprabito liso, Sandro Penna… Come ha premura di avvertire Cancogni, il libro non vuole essere un saggio di poesia italiana contemporanea ma uno “strambo memoriale”, una confessione intima che non esita a esprimere le proprie simpatie o antipatie, ponendosi all’occorrenza controcorrente e preferendo ai grandi della poesia del Novecento – Montale, Ungaretti, Quasimodo – le esperienze più appartate, provinciali, trascorse ingiustamente indifferenti alla critica ufficiale. Come non citare ad esempio la poesia dialettale del triestino Virgilio Giotti? Di lui Cancogni è perdutamente innamorato, con la sua lingua che lo rende “innocente e in un certo senso classico”, mentre “la sua parola arrivava naturalmente al suo oggetto senza girarvi intorno; con la forza di un classico che dice le cose come devono essere dette in quel modo e in nessun altro”.
– 04/06/1999
Manlio Cancogni:”Matelda”
Se la poesia è un’amante
“Matelda” è il titolo di un incantevole libro di Manlio Cancogni, giornalista e scrittore. È la storia del suo amore per la Poesia, una passeggiata fra i fiori dei migliori poeti italiani. Un sogno, racchiuso in queste pagine, da percorrere e ripercorrere, da sottolineare, perché Cancogni riesce con un linguaggio semplice e autentico a trasmettere le sue emozioni, le scoperte poetiche, sin da quando ragazzo, si accostò “alla gloriosa triade”: Carducci, Pascoli, D’Annunzio. “Non amavo nessuno dei tre”, egli confessa all’inizio del suo racconto, attraverso cui conduce il lettore appassionato come lui, verso una fiamma di luce d’amore, “quel quid specialissimo ineffabilmente puro”, che è il fine della poesia. Nella libreria paterna, in seguito l’autore incontra Baudelaire e Verlaine, che però non riuscirono a toccare “le corde più riposte del cuore”. Le pagine di Cancogni sono preziose; vi sono citati versi di poeti come Palazzeschi e Gozzano, Corazzini e Moretti, per passare a Joyce in Dedalus (“E quando saremo sposati/ io sarò felice con te/ io amo tanto la mia Rose O’Grady/ e la mia Rose O’Grady ama me”), e al suo primo incontro con Eugenio Montale “un nome da poeta”, di cui lesse per la prima volta, una poesia su “Letteratura”, un trimestrale che “all’epoca godeva di molta autorità”. Parlava Cancogni di poesie con l’amico Cassola, durante lunghe passeggiate in cui dicevano a memoria, i versi preferiti. Con la poesia di Quasimodo ebbe un incontro negativo, quando lesse “Delfica”; lo fece “quasi incazzare”: “Di che parlava santo Iddio?” (“Nell’aria dei cedri lunari/ al sogno d’oro udimmo il Leone/ svelata è la vena di corolla/ sulla tempia che declina al sonno/ e la tua vena orfica e marina”) A Firenze, nel ’46, Cancogni frequenta alle “Giubbe Rosse”, “la banda ermetica”, di cui facevano parte Mario Luzi e Giorgio Caproni, che amò “a prima vista, prima delle sue poesie”. A Roma ebbe modo di conoscere Gatto, Penna e Giotti; di tutti descrive anche le caratteristiche fisiche, come si è verificato l’incontro, e quali “avrebbero avuto in seguito un posto nella sua memoria”, accompagnandolo fino a oggi. Fra questi c’è Betocchi e la sua “splendida raccolta” che è “L’Estate di San Martino”, che “fu il primo riconoscimento ufficiale alla sua grandezza”. Cancogni racconta in un certo senso la guerra, il pre e post bellico poetico, frammisto a episodi esistenziali suoi e dei poeti conosciuti e amati. In quel particolare periodo, la sua poesia era per lui “il veicolo designato per l’amore”. “Matelda” non è certo un libro su cui si possono fare agevolmente note recensive, perché si viene coinvolti dalla lettura, essendo da centellinare, da tenere a portata di mano, arricchendosi di volta involta, riscoprendo con l’autore la poesia che è la protagonista di questo volumetto, e i poeti che sono i tramiti, con gli strumenti adatti a trasmetterla come una “scossa dell’anima”. I versi citati sono moltissimi e così i nomi di chi li ha scritti. Inoltre, movendosi l’autore in quest’ambiente letterario, divenne membro di prestigiose giurie di premi che sanciscono il valore di un poeta. E la poesia gli fu di grande aiuto, soprattutto quando per ragioni professionali (come giornalista è stato inviato speciale dell'”Europeo” e dell'”Espresso”) è vissuto a New York. Dei critici o “tecnici” chiamati a giudicare, egli dice che “premiano i poeti forniti di credenziali letterarie (o editoriali) i poeti del non dire”; mentre le giurie popolari tendono a preferire poeti sconosciuti pubblicati magari da un piccolo editore, ma che trattano temi poetici per tradizione, come l’amore, il dolore, la morte, la speranza. ”Riconosciuti i meriti dei professionisti della poesia, non riesce però a vedere nelle loro nobili esercitazioni traccia di interessi che vadano oltre la letteratura. Sintomi di un interesse, di una passione, di un ideale (chiamatelo come vi pare) si riscontrano invece negli altri, gl’ingenui e i sentimentali, che non hanno la stessa accortezza letteraria dei premi. Un poeta nascerà solo a patto di ignorare le regole, la maniera”. Riferisco queste righe perché mi sembrano oltreché giuste, anche confortanti. Così come mi fa piacere riportare qualche verso che Cancogni cita di Batocchi, il suo “inseparabile compagno di viaggio”: “voce che metti barca/ quando sospeso è il tempo/ …voce azzurra arrochita;/ voce d’altri evangeli/ di sorprendenti veri/ al cuor che ne sussurra; voce che d’uomo sei/ voce che apparirai/ voce alla Maddalena/ donna che piangi, donna?…nella Pasqua serena”/. Di Batocchi Cancogni dice: “l’ho con me, nella vita pendolare che faccio tra Fiumetto e New York, insieme al Nuovo Testamento, a Fray Luis de Leon, San Juan de La Cruz, a Manzoni, a Pea. Dite che esagero? Io non esprimo un giudizio; constato un fatto”.
– 03/11/1998
Tre consigli
Poiché queste pagine vogliono avere anche il sapore di un diario di bordo, a uso e consumo dei poeti ma anche del loro pubblico e di quanti coltivano un interesse non specialistico per la poesia; vorrei segnalare alcuni volumi recentissimi. Alberto Cappi arriva alla terza puntata dei suoi “materiali” (Materiali per un’arca, Book, Bologna, pagine 64, 18.000 lire) arricchendo ulteriormente il bagaglio di suggestioni di cui è intessuta la sua prosa, in bilico fra la prosa d’arte e il saggio filosofico. In linea con la più avanzata riflessione sul fare poetico (lungo percorso che dall’ermetica giunge a Ricoeur e Derrida) ci insegna come il rigore metodologico possa coniugarsi con la ricchezza e la profondità e con quel particolare calore umano che traspare dalla sua opera poetica, in fase di deciso apprezzamento critico: suoi testi stanno apparendo sulle più qualificate riviste letterarie (anche sull’imminente 1/’99 de La clessidra e a lui sarà dedicato uno dei prossimi Quaderni di Testuale). Manlio Cancogni in Matelda (Fazi, Roma, pagine 132, 22.000 lire) ci offre un singolare excursus di un secolo di poesia, lo fa da testimone diretto e qualificato, come redattore di riviste centrali nella storia letteraria, narratore di notevole levatura e accademico. Il libro è una godibilissima galleria dei maggiori personaggi poetici del secolo, ma soprattutto una sorta di saggio discorsivo, all’inglese, su settant’anni di poesia, il racconto del rapporto di un uomo con essa, con gli irragionevoli innamoramenti, i ripensamenti, i mutamenti di gusto, la ricerca di una spiegazione umana prima che freddamente critica. Alberto Castoldi in Bianco (La Nuova Italia, pagine 130, 15.000 lire) edito nell’interessantissima collana “Biblioteca” diretta da Mario Lavagetto, cerca di ricostruire la “fenomenologia” del colore bianco in letteratura e nell’arte visuale: colore del nulla ma al contempo somma di tutti i colori, esso si affianca davvero al silenzio (la pagina bianca di Mallarmé) come allegoria della modernità. Esemplari le pagine riguardanti il Gordon Pym di Poe (l’annullamento nel bianco) il Moby Dick di Melville (la lotta contro di esso) e la pittura di Whistler e Watteau.
– 03/11/1998
Il racconto di un amore protagonista la poesia
“Matelda. Racconto di un amore” di Manlio Cancogni (Bologna, 1916) non è un racconto di fantasia, ma uno “strambo memoriale” in cui lo scrittore ripercorre la storia del suo amore per la poesia, dalle infatuazioni dell’adolescenza alle letture selettive della vecchiaia. Molti dei suoi poeti Cancogni li ha conosciuti e frequentati, di qualcuno è stato amico, altri li ha solo sfiorati: il suo libro è anche un repertorio di aneddoti, di curiosità, di ritratti non agiografici. Matelda, la bellissima donna che compare a Dante in vetta alla montagna del Purgatorio, rappresenta la virtù attiva, quella che magnifica la creazione divina con le opere: il simbolo, per Cancogni, della poesia che è un fare, un operare, un aggiungere bellezza alla bellezza del creato; l’opposto della poesia che si flette su di sé e si autocompiace. E’ questo ormai il suo ideale di poesia, anche se in forma più indefinita lo è stato fin dall’inizio; a esso si devono le sue preferenze, e anche i momenti di diffidenza verso una poesia che in certi passaggi storici glie è parsa troppo lontana da quanto succedeva nel mondo. Cancogni ha sempre chiesto alla poesia di fare presa sul reale, di parlare di qualcosa che riguardasse la sua stessa vita: “Ho sempre letto la poesia specularmene alla mia storia personale, cercando di riconoscermici”, scrive. La libertà nel giudizio, la mancanza di reverenza si devono all’ottica personale, utilitaristica, da cui Cancogni guarda alla poesia, che ne fa qualcosa di cui ci si può servire e su cui si può anche cambiare idea. Montale è stato per molto tempo un valore sicuro, ma a lui Cancogni si rivolge sempre più raramente. Da Penna, molto ammirato in gioventù, dal suo fondo di malattia e sofferenza, è addirittura respinto. Giotti, Saba, Luzi, Caproni sono stati i poeti più importanti e amati; rimane Batocchi, scoperto tardi, poeta su cui Cancogni torna ora continuamente. Con questi nomi e con pochi altri, estranei al nostro secolo e al nostro paese, la sua arca poetica è riempita. Non vi entra naturalmente quello che lui chiama terrorismo avanguardista; non vi entrano la sperimentazione di Zanzotto o Rosselli, né la ricerca dei più giovani, di cui Cancogni lamenta la mancanza di coraggio e di individuazione, il manierismo, la debolezza del pensiero. I poeti, scrive, non credono più nelle Muse, e per questo non ne sono visitati. Eppure non è proprio così. Leggo, così sto zitto, ci si è sentiti dire da un giovane poeta recentemente, e intendeva: la smetto di parlare dei miei versi e faccio parlare attraverso i miei versi qualcos’altro, qualcun altro. E che sull’identità delle Muse, come sulla consistenza della realtà a cui stare vicini, i poeti ormai (ma da quanto tempo in realtà?) non possono fare che delle ipotesi.
– 11/08/1996
Dal suo libro d’esordio, oggi riscoperto, alla conversione: a colloquio con l’ottantenne scrittore toscano
Il segreto di Cancogni
“Fin dall’inizio ho avuto l’intuizione che la vera bellezza si può conoscere solo attraverso la rivelazione, ma non mi sono reso conto che questa era una prospettiva religiosa. Ora non potrei più scrivere se non seguendo un’ispirazione cristiana”
“Beh, sì, ma non è il caso di parlarne in un’intervista…”. Quando si arriva al tema della conversione, Manlio Cancogni diventa, più che riservato, pudico. E’ sempre stato uno scrittore prolifico, ma ora, superati gli ottant’anni (versiliese a tutti gli effetti, è nato “per sbaglio” a Bologna il 16 luglio 1916), sembra entrato in una seconda giovinezza letteraria, dominata da un’inequivocabile ricerca religiosa. Nei prossimi mesi l’editore romano Fazi pubblicherà due suoi nuovi libri: un romanzo, che nella stesura definitiva dovrebbe intitolarsi “Lettere a Little Italy” e un poemetto autobiografico, “Matelda”. Generi diversi, un unico argomento. Quale? L’incontro con il Verbo, con il “Logos” di Giovanni. Anche in questo caso Cancogni non vuole anticipare molto, ma qualcosa, alla fine, gli si riesce a strappare: “Nel romanzo c’è un italo-americano che riscopre la lingua dei padri, e la trova molto più vera, molto più bella dell’inglese d’oltreoceano – dice -. In “Matelda”, invece, c’è la storia del mio rapporto con i poeti del Novecento, da aldo Palazzeschi, che ho conosciuto nel 1935, fino a Carlo Betocchi, che ho imparato ad amare soltanto negli anni Sessanta, ma che oggi considero la voce più alta della nostra poesia contemporanea. Vede, betocchi ha una caratteristica unica: è capace di comunicare quella gioia che è la vera essenza del cristianesimo”. Inutile chiedergli se Betocchi sia in qualche modo coinvolto in questa conversione di cui non vuole parlare. “La poesia c’entra relativamente – risponde -, è sempre qualcos’altro a determinare queste scelte…”. In attesa dei due libri nuovi, li stesso Fazi riporta in libreria un gioiello da tempo introvabile. Si tratta di “Azorin e Mirò” (a cura di Simone Caltabellota, pagine 116: l’introduzione di Sandro Veronesi è in realtà un saggio in forma di racconto), il racconto breve che, pubblicato nel 1948 su “Botteghe oscure” rappresentò il vero esordio di Cancogni. Un libro curioso e indefinibile, che trasferisce in una Spagna volutamente stilizzata l’apprendistato letterario dello stesso cancogni e dell’amico Carlo Cassola, nascosti appunto sotto gli pseudonimi – in larga misura interscambiabili – di Azorin e Mirò. Il primo è destinato a bruciare la propria vicazione poetica trasformandosi in un fortunato professionista della scrittura, il secondo conserva intatte le intuizioni delle giovinezze a dispetto di un’apparente rinuncia alla scrittura. A unirli rimane la convinzione che la più vera realtà sia nascosta sotto la crosta delle apparenze. Un racconto che è, insieme, un’appassionata dichiarazione di poetica, davanti alla quale il Cancogni del 1996 appare quasi imbarazzato. “non ho avuto neanche il coraggio di rileggerlo – confessa -, figuriamoci rivedere le bozze. Penso che fosse un ottimo punto di partenza, al quale purtroppo non sono rimasto abbastanza fedele. Altrimenti avrei scritto di meno, forse quattro o cinque libri in tutto. E non è detto che sarebbe stato un male”. - Non è troppo severo con se stesso? “Semplicemente obiettivo. Per esempio non ho difficoltà ad ammettere che “Allegri, gioventù”,con cui ho vinto lo Strega nel ‘73, è una delle mie cose peggiori. Ma è andata così. In fatto è che, mentre scrivevo “Azorin e Mirò” , non mi rendevo conto delle implicazioni del mio discorso. senza contare che il mestiere di giornalista, che ho praticato per molti anni, mi ha distratto. mi era convinto, a torto, che in letteratura si dovesse usare lo stesso stile oggettivo e distaccato di un articolo di cronaca”. - Qual’era l’intuizione centrale di “Azorin e Mirò”? “Che esiste una verità assoluta, non personale, una forma di bellezza superiore alla quale si può attingere soltanto per rivelazione”. - Era una prospettiva già religiosa, dunque. “Sì, ma allora non me ne resi conto. Del resto, non fu l’unico equivoco. In “Azorin e Mirò” questa cindizione di consapevolezza viene descritta con il termine “sub-liminare”, con il quale Cassola e io pensavamo di tradurre l’inglese “subliminal”. Ci sembrava un modo efficace per alludere a una realtà “vera”, situata oltre (o, meglio, al di sotto) la soglia della percezione sensoriale. Ignoravamo del tutto che il “subliminale” riguarda piuttosto la persuasione occulta…” - Come si è risvegliato in lei l’interesse per le tematiche religiose? “Qualche anno fa pensavo di aver smesso di scrivere. Sì, continuavo a pubblicare qualche racconto, ma era convinto di avere già detto tutto quello che dovevo dire. Dopo di che è scattato qualcosa, mi sono accorto che potevo ancora scrivere, ma soltanto seguendo un’ispirazione che credo di poter definire cristiana. grazie a questo cambiamento di prospettiva, mi sono accorto che anche nei miei libri precedenti esisteva un filone religioso, che però era rimasto implicito, inespresso. Sa, per tutta la vita ho frequentato ambienti laicisti, ho lavorato per giornali come “L’Europeo” e “l’Espresso”. Intendiamoci, lì ho incontrato amici carissimi, eppure in mezzo a loro mi sono sempre sentito un ospite”. - Per lei, quindi, lettura e messaggio religioso coincidono? “Una letteratura che serva soltanto a far divertire gente che si diverte già abbastanzanon ha nessun senso, e non ne ha mai avuto: non sono io a dirlo, lo stesso Manzoni la pensava così. La letteratura non può essere altro che il veicolo della verità”. “Azorin e Mirò” appartiene, in un certo senso, anche a cassola, uno scrittore che oggi appare sempre più dimenticato… “Ingiustamente dimenticato. Anche qui, per colpa di un malinteso. carlo era lo scrittore più di avanguardia che si potesse immaginare (basterebbe rileggere i suoi racconti lunghi, rpimo tra tutti “Il taglio del bosco”), e invece è diventato il bersaglio di una neo-avanguardia che aveva come obiettivo non il rinnovamento della letteratura, ma la conquista del potere letterario”. - Lei ora ha quattro volte vent’anni, come direbbero ora i francesi: quali sono le sue letture? “A parte un residuo di obblichi professionali, le mie sono tutte riletture; Dante, “I Promessi Sposi”, i libri di Enrico Pea, Betocchi. E anche molta letteratura spagnola, in particolare i grandi mistici del Cinquecento, come Giovanni della Croce e Luìs Léon. Tutti testi che leggo finchè non li ho imparati a memoria. Un altro grande scrittore ingiustamente dimenticato, poi, è Ramòn Pérez de Ayala. Uno dei suoi racconti, “Luz de Domingo”, l’ho roletto così tante volte che uno di questi girni finisce che lo traduco.
– 03/11/1998
Cancogni: poesia e innamoramento, un’autobiografia
Come fa Cancogni a ricordare l’odore della carta in un numero di “Letteratura” sfogliato nel 1936? Non solo lo ricorda, ma se ne serve per il racconto. Vuole ricostruire, a partire dalle più piccole sensazioni, i suoi primi passi in direzione della poesia. E’ qui il segreto e il fascino della sua ultima breve narrazione, “Matelda. Racconto di un amore.” . L’amore in questione é quello per i poeti e Matelda é il nome della bellissima figura che accompagna Dante negli ultimi canti del “Purgatorio” e che, per Cancogni, rappresenta la poesia stessa. Giornalista e scrittore, Manlio Cancogni tiene in questo suo ultimo libro una sorta di diario, assieme a un’autobiografia letteraria e un catalogo dei grando classici del secolo, visti con gli occhi dei ragazzi che li leggevano allora, freschi di stampa. Com’era azzurra la copertina di “Avvento notturno” di Luzi, nella prima edizione Vallecchi, e come brillava il celeste mare degli “Ossi di seppia” di tredici anni prima. Gli amici (Cassola, Lauricella) erano attenti lettori prodighi di consigli. Ma ben presto alle letture seguirono le conoscenze personali. Il diario diventa a poco a poco una sorta di memoriale: registra gli incontri con tre giovanissimi ermetici a Firenze (Luzi, Parronchi e Bigongiari), a Roma la frequentazione di Gatto e Penna. In tante vicende non é però l’aneddotica a prevalere, ma il commento ragionato, la corrispondenza fra persone e opere. Le avversioni, gli innamoramenti, i gruppi, i premi, le dispute: tutto un mondo attraverso il filo rosso dell’amore per la poesia. Con “Matelda” siamo vicini al romanzo di formazione ma visto un po’ di lato. Coerentemente con la convinzione che in Italia non esiste un romanzo vero e proprio, ma solo racconti lunghi, Cancogni insegue un antico sogno, un brivido segreto che la letteratura gli rivelò da ragazzo.
– 03/11/1998
Cancogni: poeti per una vita
E’ uno di quei libri che Emilio Cecchi definiva “valuta oro”. Piccoli, agili, dettati dalla voce interiore, mai faticosi, sempre accesi – un aneddoto, un’intuizione, un armonico giro di “stilo” . Ecco “Matelda”, il racconto critico della poesia italiana novecentesca secondo Manlio Cancogni, non privo di intermezzi forestieri. O meglio: un viaggio nei versi che hanno attraversato, via via spiegandola, indentificandola, l’autobiografia dello scrittore e giornalista d’indole versiliese, così a sé nelle nostre Lettere, sospeso tra l’ Italia e l’America, estraneo a ogni campanilismo, a ogni tuffo nello stagno strapaesano. “Matelda”. Ed é subito Dante. Purgatorio, l’entità femminile che simboleggia la “poesia attiva ( e cioé una poesia che sia oggettivamente un fare, un aggiungere)”. Ecco il sentiero via via arato da Manlio Cancogni, coopotando ed escludendo (per esempio Cardarelli: “Le sue belle poesie mi parevano di una freddezza marmorea. Pezzi da museo. O piuttosto, calchi”. E dire che il freddoloso signore di Tarquinia scorgeva “la speranza nell’opera” ). Uno “strambo memoriale” é, avvisa Cancogni, “Matelda”. Epperò fedele allo spirito del secolo, ai valori indiscutibili. Montale, non a caso, s’impone al vertice ( “Era entrato nella nostra tradizione lirica con uno scricchiolio di vetri mandati in frantumi”), ancorché, col trascorrere del tempo, venga accomiatato (“Era stato il poeta della mia giovinezza; c’ero cresciuto insieme, romanticamente. Ora, giunto alla sessantina, la sua musica cominciava a riuscirmi fastidiosa. Del resto avevo smesso da un pezzo di sentire Beethoven”. Libero, liberissimo, Cancogni, sino all’impertinenza, autorizzata dall’immersione assoluta in questo o in quel depositum lirico, dalla consapevolezza che una cosa è l’opera, un’altra l’artefice, che nell’opera é trasmigrata la “nobilitate” dell’autore. E così – non scadendo nel pettegolezzo, sempre onorando l’eleganza del tratto, attingendo a un calamaio di cristallina, raffinata perfidia – il viaggiatore può cogliere “la voce bassa, piuttosto neutra, da ragioniere” di Montale o la natura diversa di Sandro Penna (“E non era un caso; forse, che costui fosse un povero pederasta, costretto a vivere di espedienti per una costituzionale inattitudine a un lavoro regolare”). Luzi dopo Montale, nella scala di Cancogni. E intorno (non dimenticando di “misurare” gli Ungaretti, i Quasimodo, i Saba) gli outsider: Caproni e Betocchi. E, in particolare, Virgilio Giotti, appartata voce triestina, un alfiere del dialetto, l’estremo medicamento di Manlio: “Il dialetto ha il merito di andare diritto alle cose, chiamandole con il loro nome, facendole apparire vere e nuove”. Con buona pace delle vecchie e meno vecchie avanguardie, fumose, intraducibili, aride. “Matelda” merita un brindisi vernacolare, “un de quei vinetini – versi di Giotti – / d’i monti, che un pocheto/ liga, smarì, ciareto,/ma bon”.
– 03/11/1998
Voglio dimenticare Sandro Penna
Manlio Cancogni, con “Matelda. Racconto di un amore” (Fazi, pagg.130, £ 22,000), salda i propri conti con la poesia, ossia con una passione sia pure parziale e non dominante, mai tranquilla né rassegnata, e anzi carica di forti modificazioni e di autentici tradimenti- come se una scala delle temperature avesse registrato via via abbandoni e utopie, frantumi e tragedie, privatissime felicità e dirompenti percussioni stiriche e colettive. Cancogni ha scritto questa memoria – così calda e onesta e fulminante, ancorché disossata dal tempo e dalla lunga vita – dopo aver lanciato lo sguardo nel futuro, e da lì, da quell’estrazione, ha rivisto e costruito tutto. Insomma, meglio si é posto in una posizione difficile e insieme inevitabile. E’ precisamente la visione postuma che gli ha consentito una resa dei conti definitiva, morale. Che cosa resta, allora, di tutte quelle esperienze di lettura che invocavano e producevano radicalità e rivolta? Che cosa resta di questi incontri con i più cari poeti del secolo? Cosa resta della poesia? E’ straordinario come, per Cancogni, la percezione della poesia abbia avuto bisogno di incarnarsi nel corpo stesso dei poeti, nei loro gesti, nello splendore e nella miseria delle loro abitrudini e persino nei tic e nelle contumelie al Dio che atterra e nella fame. La poesia appare indissolubile dalla fisicità, dallo slancio vitale e dalla generosità. I poeti di un’intera esistenza abitano e attraversano le pagine di “Matelda” perlopiù come “ospiti ingrati” e delicatamente in bilico, simili ad angeli provvisori, pronti a cadere, a precipitare nella desolazione di un addio senza ripensamenti: Montale e Ungaretti, Gatto e Penna, Saba e Giotti, Quasimodo e Parronchi, Bigongiari e Betocchi ( a cui il libro è dedicato), Bertolucci e Fortini e Pagliarani. La simpatia e l’affetto vanno soprattutto a Gatto, a Caproni, a Luzi, a Giotti (struggenti sono le pagine che lo riguardano e bruciante l’offesa del destino che ha impedito l’incontro tra i due). Penna, invece, é la presenza più ossessiva – una sorta di demone ambiguo e sfuggente, necessario e perturbante. Il libro é pieno di ritratti indimenticabili, sempre resi e storicizzati nella velocità dell’immediatezza, del qui e ora. Ma non é questo, o solo questo, che più conta. Per capirlo bisogna arrivare al tredicesimo capitolo, l’ultimo prima dell’epilogo. E’ il momento decisivo, addirittura formativo di “Matelda”. “Libri che amavo e riliggevo, quasi ogni anno, con rinnovato interesse”, scrive Cancogni, “oggi non posso nemmeno aprirli senza provare stanchezza, disaffezione, disgusto”. Si spegne il mito di Gatto, e poi di Montale, di Caproni, di Luzi, addirittura, con dolore e costernazione, dello stesso Giotti. E’ un desolato elenco di amori chiusi, finiti per sempre. il furore si abbatte su Sandro Penna (“non solo non voglio rileggerlo, vorrei anche dimenticare le tante poesie imparate a memoria…Penna era malato. Le sue poesie non sono nate, come lui andava dicendo dal sogno; sono nate dalla sofferenza, dall’insonnia, dal vizio e dalla solitudine”), dal quale si sente turbato per quell’immobilità” che gli provoca solo prepulsiuone e un senso di vertigine. Oramai é la musicalità che, seducendolo, lo offende. E’ anche la bellezza che non riesce a dimenticare se stessa, ossia ciò che Cancogni chiama l’”empietà dell’estetismo”. Nulla, egli afferma, va sacrificato alla bellezza, tanto meno la verità, la fede e la speranza. Per questo, i compagni di viaggio sono oggi il Nuovo Testamento, Dante, Fray Luis de Lein, Juan de la Cruz, Manzoni, Pea e il prediletto Betocchi – colui che non vacilla, maestro di concretezza e di modestia, il quale non si considerò mai “più importante nemmeno degli oggeti, come le seggiole che gli tenevano compagnia nella sua stanzetta di studente, essendo destinata alla stessa sorte”.
– 12/02/1998
Narrativa italiana
Dell’amore perduto
Cancogni e la cristianità della vita
Come recita il sottotitolo, “Matelda” é il “racconto di un amore”: e l’amore di una vita é quello per la poesia. Precisato ciò, può diventare chiaro anche il titolo del libro: Matelda, infatti, è “la bellissima donna” che appare a Dante nel canto XXVIII del “Purgatorio” e lo guida sino a Beatrice. Essa é il “simbolo della poesia attiva ( e cioè una poesia che sia oggettivamente un fare, un aggiungere)”, una poesia, insomma, che sappia allargare il mondo, arricchirlo. E’ bene dire subito che questa spiegazione si trova nell’ultimo capitolo del libro: e vale come correzione, se non addirittura rovesciamento, di tutto quello che Cancogni, quanto alla poesia, ha creduto di amare, almeno a partire dagli anni Trenta. L’elogio della poesia “attiva”, che lo scrittore identifica soprattutto con Betocchi, qui sopraelevato anche come uomo, implica un giudizio molto severo sul Novecento, il secolo in cui, come la “sterile Rachele” dantesca, i “poeti hanno preferito (…) guardarsi negli occhi, ammirandosi, godendo del proprio io fino all’ineffabile; fino allo sbriciolamento della realtà e alla distruzione della persona”: il secolo del “ciò che non siamo”, del “ciò che non vogliamo”, della morte di Dio, ma anche del narcisismo e del solipsismo, dell’egolatria quale esito inevitabile nell’età del tramonto di tutti i valori. Quello di Cancogni é, insomma, un approdo radicalmente francescano, nemmeno troppo sorprendente per chi ha letto le sue recenti “Lettere a Manhattan” (Fazi): l’approdo di chi si spoglia di tutto, salvo pochissimi libri, da leggere, però, come breviari morali; di chi ha voluto deporre come una spoglia morta della propria vita passioni letterarie che, pure, furono fortissime. La poesia non può coincidere con la “ricerca di un momento di suprema bellezza”. C’é qualcosa di empio nel non accettare il carattere transitorio della bellezza, nel “farne un bene assoluto al posto dell’Assoluto”. Un’empietà che Cancogni é costretto a riconoscere anche in quei poeti che, a lungo, sono stati irrinunciabili mete del sentimento, voci tra le più sensibili alle epifanie della vita: non dico Montale, ritenuto ancora il poeta “più rappresentativo” del secolo (in ballottaggio con Luzi), ma spesso cerimonioso, e presto irritante per la sua “retrica del negativo”, tutto dentro “il fumo della propria superbia”; non dico il purissimo Penna, sospettato subito di estetismo; dico gli amatissimi Giotti e Caproni. Cancogni lo deve ammettere: anche Giotti e Caproni ebbero fede solo nella poesia, illusi d’erigere, grazie ad essa, un monumento aere perennius. Dietro quella poesia c’era, invece, solo il nulla. Inutile dire che il maggiore indiziato del processo al nichilismo novecentesco è Cancogni stesso: quello che insieme a Cassola, autoritrattosi in “Azorin e Mirò” (1948), aveva creduto che la luce di una sera estiva potesse valere più di tutte le rivoluzioni degli uomini e delle loro sofferenze. Oggi, per Cancogni, la realtà vince il sogno: e a quell’estetizzante idea di “sub – limine” ha sostituito un concetto di grazia più prossimo a un sentimento cristiano della vita. E’ la sua terapia per la nevrosi del secolo: non so quanto potrei farla mia. Resta comunque, e d’alto valore diagnostico, questo bellissimo, straziato, libro d’un figlio del secolo.
– 03/11/1998
Litigando su Montale
Alternata alla passione per il calcio, la poesia é il filo rosso che tiene insieme una vita. E giunto oltre gli ottant’anni, Manlio Cancogni ha pensato di raccontarsi srotolando quel filo. Nasce in questo modo “Matelda” (Fazi, pagg.130, lire 22,000), una saporita autobiografia scandita dai versi, ma anche dalle figure fisiche, i volti, il candore e le malizie dei poeti italiani che hanno calcato la scena dagli anni Trenta fino grosso modo agli Ottanta e che Cancogni ha frequentato. Fra i primi emergono dalle quinte gli ermetici, alcuni dei quali hanno la faccia larga e pallida. Non usano dare né consigli né indicazioni. Non amano i giudizi, tantomeno quelli “irriducibilia significati logici e correnti”. Siamo sul finire degli anni Trenta. Cancogni legge “l’Allegria di naufragi” di Ungaretti, gl “Ossi di seppia” di Montale, si entusiasma per il giovane Luzi. Gli piace la poesia nella quale si possa cercare sempre “un particolare reale, nel rapido accendersi di un’epifania”. Ma a volte gli stessi versi che provocano un sussulto dell’animo possono lasciare freddissimi. Meglio Bologna – Lazio: un dribbling di Sansone, una rovesciata di Piola non valgono, come intensità artistica, più di “certi minuetti inconcreti”? Scoppia la guerra e si stringono le prime conoscenze. Sandro Penna é avvolto da un alone di diffidenza, non tanto per le sue sacelte sessuali, quanto per “quel velo di suicidio, di stantio che lo copriva dal casco di capelli alto sulla fronte angusta, fino alle scarpe scalcagnate”. Dei più anziani Penna ama Saba, ma è ossessionato perché teme di essere copiato. Qualche anno dopo compare anche Montale, incontrato al Forte dei Marmi mentre cammina impacciato, a brevi passi. E’ solo una commedia, dice Giorgio Zampa, che giura d’averlo visto sulla spiaggia passeggiare spedito, quasi a balzi. A guerra finita cambiano i connotati della società letteraria. A Trieste Cancogni rivede Saba. “La letteratura italiana, mio caro, sono secoli di noia”, sibila l’autore de “Il canzoniere”. “Solo due poeti ci sono, Dante e Verdi. E tutto il resto xe culo, xe culo, xe culo”. A Parigi, nel 1953, ritroviamo Ungaretti che si rigira per le mani un suo volume di poesie. “Chissà che cosa ne penserà quel povero Montale”, dice ghignando. “E’ cattivo, é cattivo”, brontola Ungaretti trafiggendo il suo interlocutore con un’occhiataccia. Una vera burrasca, secondo Cancogni, si abbatte sulla città dei poeti con l’irrompere dell’avanguardia. Una discussione con Elio Pagliarani su Montale va avanti a sciabolate. “Non c’era altro modo di combattere”, annota Cancogni. “Dichiarata la guerra o si é di qua o si é di là. Il disprezzo letterario comportava anche quello morale, personale”. Sono anni in cui la poesia vive di strappi. E sono anni di futuri ideologici. Quella stessa estate Cancogni assiste a una lite furibonda fra Franco Fortini e Silvio Guarnieri. L’oggetto é sempre Montale, che il poeta di “Foglio di via” così liquida:”Come si può essere tanto stupidi da non capire che Montale é stato il poeta del fascismo?”. Matelda, che dà il titolo a questo giornale di bordo, é il personaggio dantesco che compare nel “Purgatorio” e che si incarica di condurre il poeta a concepire il suo mestiere non come mezzo per acquistare fama né, soprattutto, per tenere fisso lo sguardo su di sé. Matelda, agli occhi di Cancogni, appare come il simbolo della poesia “attiva”, vale a dire “una poesia che sia oggettivamente un fare, un aggiungere”. Orientato da questa bussola, Cancogni è il cronista, onestamente non imparziale, di una vicenda che si é svolta sotto la corteccia della cultura italiana di questi decenni. Pesi e misure mutano con il passare degli anni agli occhi dell’autore. Crescono poeti come Carlo Betocchi e il triestino Virgilio Giotti, poco più che un marginale, stando a molta manualistica. Tramonta la stella di Montale. Ma in ogni caso il finale non é confortante: “La poesia é andata sempre più ripiegandosi, compiacendosi di se stessa”. E i poeti “hanno preferito guardarsi negli occhi, ammirandosi, godendo del proprio io fino all’ineffabile”.
– 03/11/1998
“Il novecento? E’ stato il secolo di Betocchi”
Roma. Non é un libro critico: con la quieta determinazione dei suoi 82 anni, Manlio Cancogni non si stanca di ripeterlo. “non ho voluto stilare classifiche – aggiunge – . Quando dico che, per me, Carlo Betocchi è il poeta più importante del Novecento italiano non intendo sostenere che é il più grande. Appartiene a un’altra categoria, ecco tutto”. quale? “Quella dei poeti che sanno trasmettere la gioia”, risponde, lasciando intendere che non stiamo parlando soltanto di belle lettere. Questo libro di “non – critica” si intitola “Matelda” (Fazi, pagine 132, lire 22,000, in libreria nei prossimi giorni) e rappresenta forse l’esito più inatteso del prodigioso autunno di Cancogni.. “Racconto di un amore”, annuncia il sottotitolo e infatti di innamoramenti si parla. E anche di disamori. “Montale, per esempio, non riesco più a rileggerlo – confessa lo scrittore – , mi sembra chiuso in una sua sublime retorica. Sa che cosa gli manca? La luce, quella luce bianca, assoluta, che si ritrova in Toscana, ma anche in Castiglia e in Terra Santa. Qualcosa di metafisico, che ai miei occhi rappresenta l’essenza stessa della poesia”. Non a caso, con il passare degli anni gli auctores di Cancogni si sono ridotti un drappello più che ristretto, reso compatto dalla percezione di questa luminosità più che umana: Dante, i mistici spagnoli, il Manzoni degli “Inni Sacri”, l’immancabile Betocchi. “Di lui però non ricordo quasi nulla a memoria, ho iniziato a frequentarlo troppo tardi”, puntualizza con candore Cancogni. Gli altri poeti, infatti, li padroneggia in modo invidiabile. A partire da Dante – e il Dante del “Purgatorio”, in particolare – nel cui segno si conclude questa rievocazione di quasi un secolo di poesia. Il racconto di “Matelda” inizia infatti nella Firenze degli anni Trenta, con l’amico Carlo Cassola che suggerisce a Cancogni di leggere Palazzeschi e prosegue con la scoperta degli ermetici, primo fra tutti Alfonso Gatto. Seguono, in incontri sempre più ravvicinati, il già ricordato Montale, Sandro Penna, Giorgio Caproni, Virgilio Giotti, Mario Luzi e, buon ultimo, Betocchi. Tutti, o quasi tutti, poeti che Cancogni ha non soltanto letto, ma anche conosciiuto di persona. Ci sono istantanee memorabili, in “Matelda”, come quella degli acerrimi avversari Montale e Ungaretti coalizzati – una volta tanto – contro il parvenu Quasimodo, “colpevole” per giunta di potersi fregiare della livrea di premio Nobel. Oppure Attilio Bertolucci allibito davanti al critico che definisce ipallage il suo romanzo in versi “La camera da letto”, o anche i tre moschezttieri dell’ermetismo – Luzi, Piero Bigongiari, Alessandro Parronchi – rivisti nella primavera del 1940: “S’intuiva – scrive Cancogni – un’aria pura intorno alle loro teste dai capelli fini”. “Betocchi era del tutto diverso- ribadisce-: a vederlo sembrava sempre impolverato, quasi fosse appena uscito da uno dei cantieri in cui lavorava. Ma era proprio questa concretezza a renderlo così speciale. Ma negli ultimissimi tempi questa crisi irreligiosa era stata almeno in parte superata, grazie al dialogo con amici come don Divo Barsotti e Piero Malvolti, un avvocato di Fucecchio che aveva anche doti di scrittore”. Cancogni si interrompe commosso. Malvolti, che di “Matelda” é stato il primo lettore, é morto da pochi giorni. E a Betocchi, si capisce. “L’anno prossimo cadrà il centenario della sua nascita – conclude – . Potrebbe essere l’occasione per tributargli quel riconoscimento che finora non é venuto. E’ il poeta della realtà che vince il sogno, come recita il titolo della sua prima raccolta. il più importante, il più autenticamente cristiano tra i poeti italiani del nostro secolo”.
– 03/11/1998
CANCOGNI. Che delusione i poeti moderni
Il primo premio della poesia contemporanea dovrebbe andare secondo lui a Franca Grisoni, che scrive versi in dialetto sirmionese (chì sota’ let mé gho i me bis,/’Isola’mpes, e lur i é lé/e mé sol lét), ma dà l’impressione di una poesia coltissima fatta di materiali provenienti da epoche lontane, forse dal tempo di Catullo. Nel 1985 si é battuto per attribuire a “La boba” il premio Bagutta, vinto poi dal “Danubio” di Caludio Magris. Due anni dopo ha cercato di farle assegnare il Viareggio, ma all’ultimo scrutinio il premio andò a Valerio Magrelli per “Nature e venature” In questo culto della sincerità immediata, molto spontanea e scanzonata, c’è la quintessenza di Manlio Cancogni. Il più americano degli scrittori italiani, tanto che vive parte dell’anno a New York, ha appena pubblicato “Matelda, racconto di un amore” (Fazi Editore) un autobiografia letteraria, in cui racconta la sua iniziazione alla poesia, ricorda i grandi poeti del ‘900, e difende una sua personalissima estetica. “Lei sembra più sensibile alla spontaneità della poesia, che alla tecnica della lingua racchisa in un verso”. “E’ vero. Anche se preferisco la poesia versificata, meglio se in rima. Il verso libero per me é come giocare a tennis senza rete.” “In questa sua preferenza c’é una vocazione metafisica?” “Non c’é dubbio che, forse sin dall’inizio, ma di certo negli ultimi anni si é risvegliato in me il senso della poesia per la sua finalità, anzi per la sua utilità. Tutto ciò che riguarda la tecnica, il laboratorio in cui il poeta cucina a volte in maniera raffinatissima, s’unisce per me a un senso di futilità. Ricordo il poeta Tommaso Giglio, che ebbe una certa notorietà negli anni ‘50 e poi smise di scrivere versi. Un giorno gli chiesi come mai aveva smesso. Mi rispose: “Trovavo inutile continuare”, e mi dette un’idea scandalosa: “L’unica poesia che valeva la pena considerare era quella didattica: Dante ma non Petrarca, di Leopardi solo “La Ginestra”, dov’é chiaro il contenuto”. All’epoca, era la fine degli anni ‘60, io dirigevo La Fiera Letteraria, era un’idea che rifiutavo, perchè intossicato dalla letterarietà pura, dalla letteratura come gioco, che deve servire a nulla.” “Adesso invece la condivide pienamente?” “C’é la poesia che viene dall’alto e ci mette in comunicazione con qualcosa di oltre, con la Verità con la V maiuscola: solo quella é poesia. Il resto sono solo esercizi letterari, alcuni di ottima qualità”. “Fra i poeti che lei dice di aver amato di più, Penna, Gatto, Giotti, forse solo Caproni ha una vera vocazione metafisica.” “Indubbiamente, sia pure al negativo. Oggi però preferisco non leggerlo più. E’ come se mi segassero dentro con un filo tagliente. Virgilio Giotti, amatissimo in passato, oggi mi affligge, è tutto qui, anche se in “El Paradiso” ho l’intuizione dell’eternità, come compresenza di tutta l’esistenza nell’eternità, e questo mi dà unno struggimento malinconico. Sandro Penna poi mi sgomenta: la felicità di momenti particolari dell’esistenza che sembrano sospesi, al nulla, mi dà quasi un senso di empietà”. “Dunque la poesia o é metafisica…” “E quindi religiosa, oppure non mi serve più. Non riesco più a leggerla. Ormai leggo solo Dante, i mistici spagnoli, gli “Inni Sacri “di Manzoni. E dal ‘900 solo Carlo Betocchi, che ha scritto versi come : “Non piango mica: nemmeno mi lamento/scodinzolo, per quel che so, per alleviarmi/la noia…” E anche Mario Luzi. Gli altri li rileggo solo per vedere la reazione, sempre negativa, perché mi danno malessere”. “Anche Montale?” “Non lo posso più rileggere. L’ho ammirato tanto, lo sapevo a memoria, ma ora si sgretola l’edificio della memoria e non resta altro che il fastidio per il linguaggio così “burchiello” come disse Ungaretti, citando quell’antico poeta fiorentino che scriveva poesie incomprensibili in una lingua curiosa, stramba. Mai sentito un giudizio tanto demolitore, però aveva un fondo di verità. Che vuol dire per esempio “una luna maggenga”? Di maggio? E’ un vocabolario un po’ arruffato e a volte incomprensibile”. “Eppure lei adora un poeta come Virgilio Giotti che scrive in dialetto triestino.” “Un foco di do legni/chi brila i ar di pian/pian nel scuro, una dona/che e scalda le man./Quanti ani el mi cor el gh’a batù/de sora el suo/vizin al suo el bati triste ancora. L’ho scoperto grazie al Alfredo Todisco, ma il primo che me ne parlò fu Gatto nell’agosto del 1940, scendendo da un filobus in via XX Settembre: “Sia ben chiaro, esclamò , il poeta più grande di noi tutti é Giotti”. Io non ebbi occasione di leggerlo finché nel ‘51 Todisco non mi diede “Colori” la raccolta pubblicata da Parenti. Ne rimasi incantato, commosso. non ne ho mai fatto questione di bravura poetica. Tutto ciò che é proprio della poesia del nostro tempo, fatta di allusioni, doppi giochi, ambiguità, insomma l’aspetto metaforico non l’ho mai veramente apprezzato.Istintivamente m’interessava la trasmissione diretta di esperienze e di presunte verità delle emozioni; sapere cosa dice. Non c’é niente di più diretto degli “Inni Sacri” di Manzoni. “Eppure la poesia é arte combinatoria. Per alcuni é una scienza, a metà strada tra la musica e la matematica, e c’è pure chi ha studiato la misura prosodica delle terzine di Dante”. “E’ il risultato che deve avere l’apparenza della spontaneità. Oggi però, anzi dai simbolisti in poi, si tende a credere che una cosa sia poetica di per sè, per come un certo cibo é stato cucinato, anziché per quello che dice. Il mio comunque non é un saggio critico sulla poesia contemporanea, ma il racconto di una serie di innamoramenti e tradimenti, dove parlo di autori dimenticati. E spesso sono molti e importanti come Pea, per esempio, Se lei oggi va in libreria a chiedere qualcosa di Pea, le daranno un libro di Oliviero Beha. Mentre l’Enrico Pea di Moscardino e “La Maremmana” non si trova più nemmeno sui cataloghi”. “Per tornare a Giotti, lei racconta come negli anni ‘70 cercò di accreditarlo come il maggior poeta italiano del ‘900 in una sperduta università americana nel Vermont”. “Sì, è vero a Middlebury, e una sera a casa del chairman del dipartimento di italianistica mi misi a recitare “El Bombardin”. “Co so partido via,/me go basà con mia/mamma e mio papà;/coi fazzoletti i me ga saludà./E in una col fagoto/de la biancaria soto/scai, anca portà/me iero el bombardin mio. Soldà…” “Cos’é cambiato col politically correct nella penetrazione accademica della cultura italiana in America?” “E’ un’espressione antipatica, come l’uso che se ne fa. Significa una volontaria autolimitazione che nasconde un’avversione per la lettura intesa come libera. Perché vale solo ciò che ha un interesse comune per tutti, volto al progresso sociale, quindi stiamo attenti a non offendere nessuno, parliamo di neri e non di negri, rispettiamo le minoranze etc. In fondo c’é qualche affinità col realismo socialista degli anni ‘50, con la poitica del Pci nei confronti della poesia che doveva occuparsi della vita di una colettività in quanto l’individuo, separato dal contesto, non aveva esistenza reale. E’ un’ideologia che mi fa orrore: che l’arte e la letteratura debbano piegarsi a interessi superiori, sono disposto ad ammetterlo. Solo che distinguo tra metafisica e metafisica. La finaltà dei marxisti non la posso condividere, almeno del tutto, Ma rifiuto la poetica che afferma l’autonomia della letteratura. La buona letteratura per me ormai si confonde con la buona filosofia”.
– 03/11/1998
“Montale era proprio un fascista”: parola di Franco Fortini
Tra le passioni di Manlio Cancogni, la più pura é quella per la poesia, un amore lungo e costante, di cui questo libro, “Matelda”, in uscita da Fazi, dà oggi testimonianza. Il titolo allude al personaggio dantesco, ma la poesia di cui parla Cancogni é soprattutto quella di questo secolo, che Manlio giudica con onesta partigianeria. Pubblichiamo qui accanto – per concessione dell’editore – una pagina del libro, avvertendo che la passione segreta, ma rivelata nella dedica, di Cancogni è Carlo Betocchi, poeta grande e appartato. Quell’estate, o la successiva, l’amico Giovanni Giudici vinse il Carducci con il bel volume La vita in versi, edito da Mondadori, unico prodotto finora, della nuova poesia, che non mi avesse lasciato indifferente. Nulla a che vedere, per intendersi, con le futili forzature dei “nuovissimi”, dei Porta, Giuliani, Sanguineti, Balestrini ecc., la loro vuota preziosità. Giudici si capivs. La sua voce anzi era fin troppo piana, discorsiva, narrante; e il sottinteso politoco, così naturale che non disturbava. Giudici era d’origine cattolica; poi comunista; cinese, precisava, fedele lettore dei “Quaderni Piacentini”. Dopo il Premio andammo a cena insieme ad altri amici da Eugenio al Paludetto, una trattoria all’aperto, non lontano dal Giardo, paradiso, un tempo; dei cacciatori di uccelli acquatici, e del mio amico pittore Beppe Bongi. C’erano fra gli altri Franco Fortini e Silvio Guarnieri, presidente del premio. Fra i due montò a poco a poco una lite furibonda. Oggetto: Montale. Ma forse Montale era solo un falso scopo che nascondeva un contrasto di fondo, politoco, fra comunisti di stretta osservanza sovietica, e comunisti eterodossi, cinesi. “Come si può essere tanto stupidi da non capire”, gridò Fortini, “che Montale é stato il poeta del fascismo? E non venirmi a dire che Montale non ha mai avuto la tessera, che aveva firmato il Manifesto Croce, che i fascisti lo cacciarono dal Viesseux e lo tenevano sotto sorveglianza. Sono cose, lo sai benissimo, che non contano”. Guarnieri, fedele e leale amico del poeta, ribatteva anche lui urlando. Giudici sorrideva mestamente. Investito, di tanto in tanto, come diversivo, dagli insulti di Fortini (tu stai zitto, sei un cretino!) mi confermavo l’idea che una guerra ideologica di rara animosità stava abbattendosi sulla repubblica delle lettere. Che ormai si giudicasse in base a divise, bandiere, etichette, senza badare ai valori individuali, mi pareva mostruoso. Mi ero irritato e forse sgomento, non sapendo con sicurezza se la mia estraneità allo scontro fosse apparente o reale e di fatto non fossi anch’io parte in causa nella bagarre. Non leggevo riviste della neoavanguardia, non avevo mai preso in mano “I Quaderni Piacentini”. Poco sapevo di Mao e della Rivoluzione culturale. Tutte cose che, senza conoscerle, mi facevano una grande antipatia, sembrandomi inoltre che per la nostra intellighenzia disoccupata fossero soprattutto alibi. Questa forse era la mia colpa. Volevo dire, nel linguaggio degli eversori, che facevo parte dell’establishment; che ero, oggettivamente (usava molto questo termine) un fascista?
Libri dello stesso autore

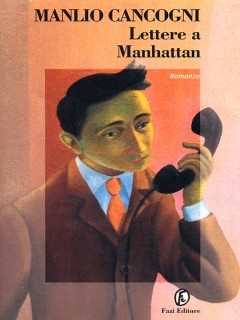
Lettere a Manhattan
Manlio Cancogni