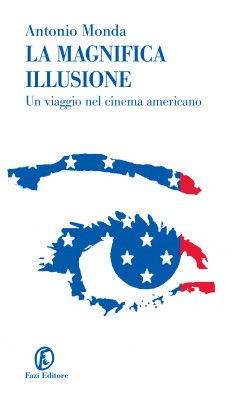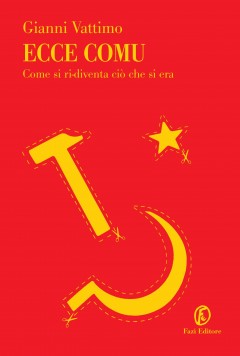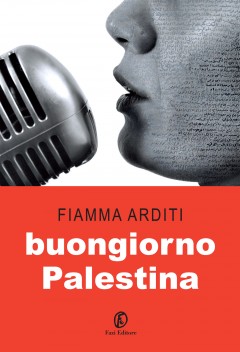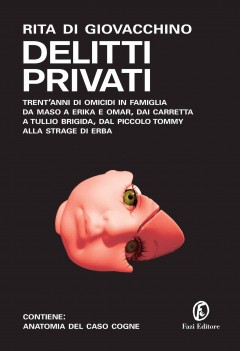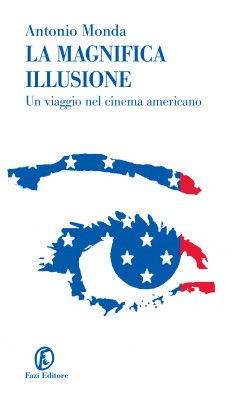
Antonio Monda
Tu credi?
Conversazioni su Dio e la religione
Un gruppo di intellettuali e artisti di primissimo piano, di differente sesso, religione e tradizione culturale, accetta di raccontare la propria riflessione personale su Dio e di dialogare sulle risposte più intime alle grandi domande dell’esistenza. Non tutti i protagonisti di questo libro sono nati negli Stati Uniti, ma hanno tutti trovato in America il luogo della libertà d’espressione artistica e intellettuale e, nonostante contraddizioni stridenti e aberrazioni di ogni tipo, della tolleranza religiosa. In queste loro conversazioni senza veli sul rapporto con la dimensione trascendente, personalità come Saul Bellow, Paul Auster e Salman Rushdie rivelano approcci diversissimi, che vanno dal colloquio quotidiano con Dio alla perplessità rispetto alla sua reale esistenza, alla convinzione della sua totale e raggelante assenza. Le loro scelte e il loro percorso consentono al lettore non solo di interrogarsi su un tema di assoluta attualità, ma anche di riflettere sulla realtà sociale e culturale dell’America: è il paese del puritanesimo e del consumismo, come si tende spesso a sostenere, o c’è qualcosa di autentico e profondo nel richiamo costante a temi spirituali da parte di politici, artisti e intellettuali?
Gli intervistati: Paul Auster, Saul Bellow, Michael Cunningham, Nathan Englander, Richard Ford, Paula Fox, Jonathan Franzen, Daniel Libeskind, Toni Morrison, Grace Paley, Salman Rushdie, Arthur Schlesinger jr, Derek Walcott, Eli Diesel, David Lynch, Martin Scorsese.
– 29/11/2007
Wie hältst Du’s mit der Religion?
– 26/01/2008
Se Jonatha Safran Foer pensa all’Aldilà
– 19/05/2006
L’epifania invisibile di Dio e il mistero della fede
| ilsole24ore.com | |
|
Epifania: oggi Dio/mi appariva così:/qualcuno Parole del poeta ebreo Yehuda Amichai che ci |
|
– 22/11/2007
Noi non credenti e la religione
– 01/05/2006
Punti di riferimento
Tu credi? La grande domanda dell’esistenza è stata rivolta a un gruppo di artisti e intellettuali americani come Paul Auster, Martin Scorsese, Jane Fonda, David Lynch, Salman Rushdie (per citarne alcuni ).E da lì prende inizio un viaggio affascinante nelle insondabili profondità dell’Assoluto. Per riflettere sul bisogno di spiritualità, sul personalissimo modo di dialogare con la divinità e su quel continuo interrogarsi sul senso del vivere, con o senza Dio, e del morire, che ognuno porta dentro di sé.
– 01/05/2006
Tu credi
Cattolico, credente, di famiglia “religiosissima”, di quelle che non fanno colazione se non passano prima in Chiesa, Monda (che da 15 anni vive a New York da dove collabora in maniera egregia per Repubblica) ha pensato di affrontare una riflessione dialogata sul rapporto che hanno con l’esistenza di Dio alcune grandi personalità della cultura newyorkese (Martin Scorsese, Spike Lee, Paul Auster, Richard Ford, David Lynch, Saul Bellow, Salman Rushdie…). In altre parole, ha chiesto ai suoi interlocutori se ritengono che Dio esista, sotto quale forma e qual è la loro conseguente scelta di vita. La cosa più anomala di questo libro è che, man mano che si va avanti, Monda continua imperterrito a prendere schiaffi da tutti i suoi intervistati; che tutti, dico tutti (a parte forse Eli Diesel), si dichiarano “non credenti”, accusano la Chiesa di Roma di essersi macchiata di crimini infami, sono totalmente a favore della separazione tra Stato e Chiesa e sono convinti che dopo la morte non ci sia niente, che il paradiso sia un’idea inutile (Paula Fox).
Monda cerca di ribellarsi a questo diluvio di affermazioni contrarie alla sua fede, arrivando perfino, di fronte ad una Jane Fonda convinta che i Vangeli cosiddetti apocrifi siano quelli giusti, a negare che la Chiesa li abbia mai condannati!
Fa quasi tenerezza quando si contrappone all’idea che uno Stato possa permettere l’aborto o l’eutanasia, quando si dice convinto che Dio ha creato l’uomo a sua immagine e somiglianza, si manifesta con orgoglio “cattolico, apostolico, romano”, crede ai miracoli, che Dio si sia incarnato, sia nato da una vergine e abbia salvato il mondo, fino a giustificare in tutto l’istituzione cattolica perchè è stato Cristo ad affidare, con tutta la sua autorità la chiavi a Pietro ( ?!?). Gli intervistati, pur con profondo rispetto, lo trattano quasi con sufficienza, e con un po’ di compassione.
Credo che, forse, qualche domanda alla fine del libro se la sia posta anche lui. Almeno lo spero. Per lui, ovviamente. Però ne dubito.
– 07/05/2006
PREMI NOBEL DI FRONTE A DIO
C è chi come il poeta Derek Walcott immagina Dio, nella perfetta iconografia popolare, “come un uomo bianco con la barba bianca”, e chi invece in Dio non crede, anche se ammira chi ha l’eroismo di farlo in un tempo come il nostro. C’è ancora chi crede in Dio, ma non nel valore della preghiera, come aveva affermato lo scrittore Saul Bellow, e chi invece ha abbandonato la pratica religiosa, nonostante l’educazione cattolica, perchè il Concilio Vaticano II aveva abolito il latino, come spiega la scrittrice afroamericana Toni Morrison. Sono tutti premi nobel per la letteratura che, insieme ad altri scrittori (Richard Ford, Paula Fox, Jonathan Franzen, Salman Rushdie, Eli Wiesel, Paul Auster), poeti, ma anche registi come Martin Scorsese e Spike Lee (in tutto 18), sono stati intervistati da Antonio Monda, docente di Regia cinematografica alla New York University, nonché critico cinematografico.
Il titolo esplicita la domanda intorno alla quale vertono le conversazioni, Tu credi? (Fazi). Antonio Monda parla del libro, costruito “su una semplice ma fondamentale provocazione: ho chiesto ai miei interlocutori di dirmi in tutta onestà se ritengono che Dio esista, e qual è la loro conseguente scelta di vita”. Si tratta di colloqui brevi, ma intensi, capaci di rimuovere la riservatezza iniziale degli intervistati, di ascoltarne le confidenze, di dibattere anche. Per la maggior parte degli interlocutori Dio resta un mistero e anche se diventa difficile o impossibile credere, resta un grande interesse verso il religioso, quasi una forma di nostalgia.
Paul Auster precisa: “Non ci credo. Ma questo non vuol dire che non ritenga la religione un elemento culturalmente fondamentale dell’esistenza”. E Paula Fox, citando la O’Connor e El Greco: “Mi commuove la loro dedizione assoluta nei confronti di qualcosa che ritenevano superiore a loro”.
– 21/06/2006
Conversazioni su Dio le interviste di Monda
– 15/04/2006
Conversazioni americane su Dio
Qual è la domanda più grande che l’uomo può porre a se stesso e agli altri? La vita, la morte, il loro significato sono temi importanti, universali, materiali fondamentali per domande gravi. Ma per lo scrittore di origine ebraica, e premio Nobel per la pace, Eli Wiesel, la domanda più grande è un’altra: “Alla fine dei conti l’esistenza di Dio è l’unico problema autentico […] nel quale tutti gli altri problemi sono riassunti e mimetizzati”. Ne è convinto anche Antonio Monda, autore di un libro di conversazioni su Dio e la religione con 18 intellettuali e artisti statunitensi. Essi sono 12 scrittori (di cui quattro premi Nobel): Paul Auster, Saul Bellow, Michael Cunningham, Nathan Englander, Richard Ford, Paula Fox, Jonathan Franzen, Toni Morrison, Grace Paley, Salman Rushdie, Derek Walcott ed Eli Wiesel; l’attrice Jane Fonda; i registi Spike Lee, David Lynch e Martin Scorsese; l’architetto Daniel Libeskind e il politico Arthur Schlesinger jr. L’Autore insegna presso la New York University ed p critico cinematografico della Repubblica e della Rivista dei libri. è anche un organizzatore di grandi eventi culturali newyorkesi e romani. Tra questi ricordiamo la manifestazione The hidden God (Il Dio nascosto) presso il Museum of Modern (MoMa) Art di New York, che rivela il suo interesse per la presenza del sacro nella cultura contemporanea. Il suo lavoro gli ha permesso di stabilire ampie e profonde relazioni con molte personalità della scena culturale statunitense. Così ad alcune di esse ha deciso di rivolgere una domanda semplice e impegnativa circa la loro fede.
Una domanda difficile
Quali reazioni alla domanda sulla fede? In un caso la reazioni è diretta: “Ma non sai che sono ateo?”. A rispondere così è lo scrittore Richard Ford. Alla fine accetta anche lui di rispondere, ma solamente dopo averci pensato bene. Più spesso le reazioni sono invece di titubanza, di perplessità più sfumata, a volte di imbarazzo. Non per l’argomento religioso in se stesso, che al contrario è un tema molto frequentato dalla pubblicistica. Ha giustamente notato lo scrittore premio Nobel Saul Bellow che “Ultimamente si fa un gran parlare di Dio, della religione, della spiritualità, dell’anima”. Nel secolo scorso sembrava che fossero idee destinate a scomparire e si diceva: “dio è morto”. Ebbene – conclude Bellow – “Le uniche cose morte sono quelle idee” (p. 34).
La difficoltà degli intervistati nasce dal fatto che l’inchiesta non ha un taglio sociologico, ma è un tentativo di affrontare “il nocciolo del problema, rivendicandone la centralità in ogni esistenza e sottolineando costantemente come ogni singola scelta (esistenziale, artistica, politica) scaturisca direttamente, e imprescindibilmente, dalla risposta che viene data alla “grande domanda” (p. 14). Il poeta caraibico premio Nobel Derek Walcott sembra condividere l’impostazione di Monda: “La religione è un dato da cui non si prescinde. Sono sempre stato convinto che è illusorio pensare di farne a meno, o di non esserne formati in maniera indelebile” (p. 140).
Gli intervistati sono artisti di origine protestante (la maggioranza), ebrea, cattolica (M. Scorsese) e musulmana (S. Rushdie). Monda non cela affatto il suo punto di vista, anzi lo dichiara apertamente, evitando così ogni inutile imparzialità. Egli si definisce nell’introduzione “cattolico, apostolico, romano” (p. 17). I suoi interlocutori lo sanno bene. Lo conoscono. Questa dichiarazione così esplicita non comporta chiusure, difficoltà o forzato e superiore rispetto. Al contrario genera chiarezza nel dialogo, che è un confronto vero, serrato, veloce: le risposte raramente superano la decina di righe. Anzi, in genere sono ben più fulminee. Si nota così l’origine giornalistica di queste pagine, che sono apparse sul quotidiano la Repubblica.
Una religiosità contraddittoria
Per lo più gli intervistati riconoscono l’esistenza di Dio. Monda cita una ricerca secondo la quale solamente il 10% degli statunitensi si dichiara ateo o agnostico. Tuttavia mette subito in guardia il lettore: le risposte delle persone che egli ha incontrato non corrispondono a quelle dei campioni statistici. Anzi le capovolgono a favore di posizioni agnostiche. E così commenta: “Dobbiamo pensare che la presenza della fede e della religione tenda a ridimensionarsi – o persino a scomparire – una volta che si dialoga con la classe intellettuale, o invece dobbiamo ripensare alle parole del Vangelo di san Matteo (11,25) nel quale Cristo eleva una preghiera al Padre, benedicendolo: “Perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli”? Si tratta di uno dei tanti passaggi in questo viaggio nel quale le domande sono risultate superiori alle risposte” (p. 21). Cercheremo qui di individuare alcuni nodi centrali che emergono dalle interviste e che ci sembrano utili alla riflessione.
Un Dio indistinto. Alle fine della lettura di questo libro il lettore credente potrebbe rimanere perplesso e insoddisfatto. Nell’intervista predomina una religiosità che fa riferimento a un mistero vago e confuso. Se invece si esprime un legame con una tradizione precisa, essa viene vissuta e interpretata in maniera ben poco ortodossa. Vale per tutti la risposta della scrittrice Paula Fox, interrogata su cosa sia per lei la religione: “Non la considero una questione di tradizioni e dogmi, ma piuttosto un’esperienza spirituale” (p. 57). Si parla molti di “spiritualità” in questo libro, poco di una fede incarnata, storica.
Jonathan Franzen, scrittore di culto della più recente narrativa statunitense, non riesce proprio ad avere un’idea definita, come del resto sembra avere un’idea confusa di tutta la realtà: se non crede nel Dio che risponde alle preghiere, ritiene pure “che quanto vediamo con i nostri occhi e viviamo con i nostri sensi sia in realtà un’illusione […] e al di là di questa illusione so che c’è qualcosa di molto più grande e importante. Credo che esista qualcosa di eterno e ho un grande rispetto per ogni esperienza mistica. È una parte essenziale della mia vita” (p. 77). Se si apprezza un’apertura al mistero, si resta colpiti dalla sensibilità dominante, che è generica e indistinta. Così il regista “indipendente” Spike Lee crede in “un’entità superiore”, una presenza superiore” che non sa definire come Dio (p. 85); il premio Nobel Toni Morrison crede “in un’intelligenza interessata a ciò che esiste e rispettosa di quanto ha creato” (p. 104); lo scrittore Salman Rushdie invece crede “che esista qualcosa di misterioso e incomprensibile, che tuttavia non sia trascendente o sovrannaturale” (p. 122). Alla fine comunque nessuno degli intervistati banalizza il fatto religioso. Paul Auster, scrittore newyorkese di grande successo, afferma di non credere, ma riconosce nella religione “un elemento culturalmente fondamentale dell’esistenza” (p. 28). Tuttavia molti collocano la religiosità in una sfera fin troppo, vaga, indeterminata o di prevalente rilevanza socio-culturale. Non è questa la sensibilità del momento? Non è forse questo il pericolo maggiore per un autentico senso religioso?
Un Dio sempre più grande. Più pertinente ci appare allora quanto afferma Toni Morrison: “La mia idea di Dio è quella di una crescita infinita che scoraggia le definizioni ma non la conoscenza” (p. 104). Invece che ribadire un mistero vago, preferisce affermare un mistero sempre più grande, incapace di essere ridotto nei limiti di una definizione. Sono gli scrittori di origine ebraica ad affermare una fede precisa, seppure con un grande senso del pudore, del rispetto e persino del timore, come nel caso di Saul Bellow, che mette in allerta il lettore su un tema che non può mai essere affrontato, a suo giudizio, con lo spirito della curiosità invasiva. A nostro avviso, è Derek Walcott, commentando il quadro La nostalgia dell’infinito di Giorgio De Chirico, a chiarire la questione: “Credo che ognuno, a prescindere da quelle che possono essere le sue convinzioni, senta nel proprio intimo il senso di qualcosa di infinitamente più grande. La fede ci offre una chiave, anzi una strada, che si oppone al mistero, e ne crea un altro, quello che credenti definiscono appunto “mistero della fede”” (p. 143). Walcott, di formazione metodista, chiarisce che la fede non nega il mistero, ma lo illumina e lo protegge rispetto alla sua trasformazione in idolo, alla sua affermazione vga e fumosa.
Dio e il male. Il problema del male e dell’orrore emerge qua e là nel testo. Spesso – specialmente per coloro che più di altri si dichiarano atei, agnostici o credenti in un vago mistero – viene associato alla presenza delle “religioni organizzate”, che nella storia si sono imposte con la violenza. In controtendenza la bella dichiarazione di Eli Wiesel davanti alla domanda su come egli concepisca l’esistenza senza la fede: “L’assenza programmatica di un dio, o quanto meno l’illusione di combatterne la presenza, porta sistematicamente all’orrore” (p. 147). La sua è una “fede ferita” (p. 149), ferita dall’orrore della storia e anche dalle crisi personali, ma proprio per questo solida e adulta.
Vengono in mente all’intervistatore le parole che il credente Saul Bellow aveva scritto in Herzog: “La storia umana è la storia della crudeltà e non dell’amore. Se il vecchio Dio esiste è un assassino”. Come conciliare queste affermazioni con la sua fede? E Bellow nell’intervista non si sottrae all’obiezione: “Credo che la vita di un uomo sia fatta anche di momenti: Herzog riflette sui continui abomini dell’umanità ma non interrompe mai il proprio rapporto con Dio” (p. 36). Una fede solida, dunque, capace di confrontarsi in maniera adulta col problema del male, capace anche di elevare la preghiera come “un atto di ringraziamento rispetto all’esistenza” (p. 37).
La storia religiosa personale
Certo, chi ha sviluppato una religiosità generica rischia di fare discorsi altrettanto generici e vaghi, di esprimere pensieri in libertà, anche un po’ naïf. È il caso di molti degli intervistati. Parlare seriamente di Dio non significa esporre teorie, ma passare attraverso la propria esperienza personale, la propria vicenda biografica. Questa la tesi implicita di Monda, il quale mette i propri interlocutori alla corda, richiamando una storia concreta: li interroga non solo su quello che hanno pensato, ma anche su quello che hanno vissuto. Essi dunque sono invitati a parlare delle loro radici, delle loro origini, spesso segnate dalla fede o da un’educazione religiosa. Così Monda li spinge a considerare la domanda sulla fede non come lo spunto per una riflessione teorica e disincarnata o una divagazione su un tema libero, ma come una meditazione su un tassello della propria umanità e anche un momento della loro storia familiare.
La rottura dell’incantesimo. Così Paul Auster parla anche di crisi, di momenti di passaggio nei quali l’“incantesimo” si è rotto, la fede si è oscurata e sono sorti molti problemi con i gruppi religiosi, con quella che egli definisce la “religione organizzata”. Colpisce leggere storie di allontanamento dalla fede, conversioni al contrario, momenti di distacco, le cui cicatrici restano però nella carne. In questo è esemplare Nathan Englander, scrittore newyorkese di origine ebraica, che si è allontanato dalla fede. Interrogato su questo tema, egli risponde che il suo rapporto con la religione attualmente è “quello di una persona che si è spogliata di tutto, ne prova eccitazione ma forse non sa come relazionarsi con la propria nudità” (p. 51).
Il rapporto con la Bibbia. Se il rapporto con la fede è complesso e spesso irrisolto (sono pochi coloro che si esprimono decisamente per una fede limpida o un chiaro ateismo), è altrettanto chiaro che la maggioranza degli intervistati ha avuto un rapporto positivo con la Bibbia. Per Toni Morrison è “un libro meraviglioso scritto da straordinari visionari” (p. 104). Nathan Englander non ha mai trascurato la lettura della Bibbia, “l’opera più bella mai scritta”. Monda lo incalza con la domanda se la sua lettura del testo sacro sia da scrittore o da uomo di fede. La risposta di Englander non è banale: “A volte mi chiedo se c’è una differenza. Ma se intendi dire quanto è rimasto dentro di me del ragazzo educato alle scritture, ti dico che quando richiudo la Bibbia la bacio e sto ben attento alla posizione in cui la colloco nella mia libreria” (p. 52). Cosa lo affascina della Scrittura? “La sua complessità, e la capacità di parlare nel linguaggio dell’eternità” (p. 53). Anche Grace Paley, scrittrice “femminista” di origine ebraica, pur non essendo credente e rifiutando ogni idea di trascendenza, afferma di provare da sempre “un profondo interesse per la Bibbia”, anche se “da un punto di vista storico e letterario” e non religioso. Afferma: “Credo che saia un meraviglioso libro storico con grandi momenti di poesia, che racconta la storia di un popolo che definisce se stesso” (p. 110).
Desiderio e immaginazione
Sarebbe interessante rileggere le interviste sulla base del coinvolgimento emotivo che esse rivelano. Se, ad esempio, Paul Auster risponde in maniera alquanto fredda, controllata, altri, come Michael Cunningham, sembrano decisamente coinvolti. Alcuni si esprimono come se esponessero una teoria pensata e sperimentata, altri invece sembrano esprimere un pensiero che si sviluppa mentre viene comunicato. Preferiamo i secondi. Un esempio è proprio Cunningham, il quale esordisce da ateo, ma poi, davanti alla forte tentazione di vedere Dio come un’illusione, sembra percepire una forte resistenza interiore ed esclama: “Un universo che non contempli un’intelligenza armonica e superiore di qualche tipo è così sterile…” (p. 40). Per quanto l’uomo si sforzi di negare Dio, nel suo cuore batte un desiderio che non si può negare o svilire o azzerare: questo sembra comunicarci con le sue contraddizioni.
Cristo per lui è semplicemente un pensatore. Tuttavia sente di non essere soddisfatto di questa definizione. Non approda alla divinità di Cristo. Si ferma molto prima, in realtà. Tuttavia comprende che nel cristianesimo c’è qualcosa che muove la capacità di immaginare. In particolare nel cattolicesimo. Quando parla della sua infanzia, egli ricorda di essere stato invidioso di una sua amica che frequentava una scuola cattolica: gli sembrava “parte di un mondo misterioso, pauroso, ma anche promettente”, al contrario del suo liceo pubblico più simile a uno “shopping center in declino” dall’“aura di sconfitta secolare e polverosa” (p. 42s). E tutto questo perché in quella scuola cattolica a trionfare erano i simboli, le icone, vero nutrimento per l’immaginario.
Quelle di Cunningham sono le stesse immagini a contatto con le quali si è formato il regista di origine italiana e cattolica Martin Scorsese, che da ragazzino fu chierichetto. Di quei tempi Scorsese ricorda “il rituale e la scansione liturgica dell’anno: qualcosa che mi ha formato profondamente sia da un punto di vista drammaturgico che esistenziale” (p. 133). Anche Jonathan Franzen: se non sa dare una risposta precisa alla domanda su Dio, delle sue esperienze nella chiesa congregazionalista frequentata in giovane età, egli però ricorda molto bene il senso del mistero e l’ascolto di “storie straordinariamente suggestiva” (p. 76). Adesso ammette: “Una parte di me crede, ma ho dei problemi molto seri a definire questo essere onnipotente. Certo non credo all’immagine classica di Dio” (p. 75). Interrogato sulle sue immagini del passato però ricorre fortemente al potere dell’immaginazione: per lui l’immagine di Dio “era vicina a quella di Aslan, il leone delle Cronache di Narnia di C. S. Lewis. È un animale grandioso, dal respiro dolce. Terrorizza, ma se il tuo cuore è puro, ti conforta” (p. 77). Un po’ come il regista David Lynch, di origine presbiteriana, ma lontano da ogni forma religiosa organizzata, che però conferma di avere l’idea di un Dio “padre e pietoso” e di ripensare spesso “all’idea del regno dei cieli” (p. 98).
L’appello all0’immaginazione si fa prudente negli artisti di origine ebraica. Tuttavia colpisce l’intervista con Eli Wiesel, una delle più belle. “Com’era il Dio dell’infanzia?”, chiede Monda. “Non molto diverso da quello della maturità – risponde Wiesel -. Posso dirle che era nei miei sogni, nelle mie preghiere, in ogni aspetto di un’esistenza altrimenti inconcepibile” (p. 146). Anche Nathan Englander conferma il ricorso all’immaginario. Infatti, interrogato sulla vita dopo la morte, egli è tentato di dire che si tratta di un’illusione, ma prosegue: “Se mi chiedi dove credo che si a in questo momento mio nonno ti rispondo: in paradiso” (p. 54). Non è la forza delle idee a plasmare le tensioni più profonde, ma il desiderio del cuore e le immagini che ad esso corrispondono.
Così anche l’architetto Daniel Liebeskind, autore del progetto di ricostruzione delle Twin Towers di New York. Egli non immagina Dio: lo si può ascoltare, non immaginare (cfr. p. 90). D’altra parte, però sente come la sua fede non possa non tradursi in arte, anche nel proprio lavoro, nel quella riconosce elementi religiosi: “Credo che ogni progetto sarebbe fallace se si rifacesse solo a se stesso, o se cercasse l’armonia soltanto in se stesso. Anche quando non lo ammettiamo la spiritualità è una dimensione dell’esistenza. Ce lo ricordiamo raramente, quando ad esempio rimaniamo senza parole di fronte al mistero, o alla bellezza perfetta” (p. 92). Dunque “non c’è stato un grande architetto che non abbia avuto un forte elemento di spiritualità” (p. 92).
Se letto con attenzione, Tu credi? aiuta a capire l’impatto che l’immaginazione può avere sulla vita di fede. In un grande Paese come gli Stati Uniti, che vive tra il puritanesimo e il consumismo, l’immaginazione sembra essere una valida ancora di salvezza per il senso della fede. È fin troppo facile contestare a molti intervistati debolezza speculativa o vaghezza di contenuto. Fa bene invece Monda a interrogarli su quale sia la loro immagine di Dio. Alcune risposte date nel libro possono apparire fin troppo fantasiose, ma tutte, in realtà , hanno un riferimento che fa appello all’esperienza reale degli artisti e no solamente alle loro opinioni o idee. Così nel caso di Cunningham che immagina Dio come un grande donna di colore perché così era la sua babysitter, persona che amava “di un amore fuori dal normale” (p. 43).
Non stupisce quindi che spesso Monda chieda quali siano gli scrittori in cui i suoi interlocutori riconoscono la presenza dell’elemento religioso. È interessante notare che la figura più citata è Flannery O’Connor, “una cattolica assolutamente ortodossa e insieme una delle più grandi scrittrici del secolo scorso”, afferma Cunnigham, che prosegue: “È impossibile separare la sua fede dalla sua arte, come hanno tentato di fare alcuni critici. Se si continua a leggere la sua opera trattando il suo cattolicesimo come una specie di ostacolo che lei è riuscita a superare, non si capisce cosa abbia fatto e si insulta la sua memoria. Nelle sue opere di narrativa, nelle sue lettere e nei suoi saggi, la O’Connor rappresenta il migliore argomento che conosco contro il tentativo di ignorare o minimizzare il cattolicesimo. Come lei stessa ha detto più di una volta, il suo credo ha formato e chiarificato la sua visione” (p. 46s). Cunnigham ha colto, anche grazie alla O’Connor, il legame profondo tra visione e credo, tra immaginazione e fede, confermato del resto, in un modo o nell’altro, dagli intervistati.
L’arte come idolo della redenzione
La prima conseguenza del legame tra immaginazione e fede per uno scrittore ricade direttamente sulla sua ispirazione. Martin Scorsese esplicita un legame diretto e personale: “Penso che il mio cattolicesimo sia parte della mia intimità, e sono convinto che sarà sempre così” (p. 131). E aggiunge: “Il mio cinema risulterebbe inconcepibile senza la presenza della religione” (p. 131). Anzi: “Ho fatto il regista per esprimere tutto me stesso e anche il mio rapporto con la religione, che è determinante. […] È certo che per me la religione si è intrecciata, e quindi anche espressa, attraverso un mezzo che mi ha conquistato sin da quando mio padre mi portava a vedere Fronte del porto e La finestra sul cortile” (p. 134). Arte e religiosità appaiono legate, in un modo o nell’altro. Salman Rushdie non solo non nega questo rapporto ma lo esplicita legandolo alla religiosità di suo nonno, che afferma essere stata determinante nella sua scrittura (cfr p. 119).
Ma questo vale anche per persone che sembrano nona vere alcuna forma di legame con le religione. È il caso di Richard Ford. Alla domanda “credi di Dio?”, la risposta è netta e monosillabica: “No”. I ricordi del suo passato sono segnati dai dettami della tradizione presbiteriana e dalla frequentazione domenicale del culto, “un rito vuoto e privo di senso” (p. 65). Un giorno, preso da un moto di “disillusione e ribellione”, ha lasciato tutto. E quello fu anche il giorno nel quale decise di diventare uno scrittore. Nel caso di Ford la sua religione diventa dunque la scrittura e “le due scelte sono strettamente collegate” (p. 65). Nel mio caso, prosegue lo scrittore, “l’arte, e in particolare la scrittura, hanno dato un senso all’intera esistenza. Fin quando non ho fatto questa scoperta, e conseguentemente la scelta di essere un artista, sentivo qualcosa che mancava sia sul piano mondano che spirituale” (p. 66). Ogni volta che gli viene posta una domanda su Dio, ammette Ford, egli continua a pensare all’arte, identificandola con la divinità. Ecco qual è l’effetto dell’intrinseco legame tra fede e immaginazione per una persona che ha perso la fede: il culto per l’immaginazione creativa, per la scrittura, che diviene forma di appagamento delle tensioni interiori. L’arte diviene sostituto della fede, addirittura forma di “redenzione”.
L’uomo religioso non può non vedere in questa trasposizione una forma sofisticata di inganno. La scrittura e l’arte sarebbero forme di salvezza rivali e nemiche in radice della salvezza religiosa, “ciò che resta della fede quando la si è perduta”. Se l’arte di proponesse come via di salvezza, sarebbe un idolo. Su questa risposta però pare converga anche Franzen: “la mia religione è quella dei libri” (p. 80). Anche Spike Lee pensa “che l’arte rappresenti il tentativo umano di sublimarsi, e porti con sé le debolezze dei rispettivi autori. Ma il risultato spesso ci offre l’intuizione della perfezione. Forse di Dio” (p. 87).
Così non stupisce che sia proprio l’ateo Ford a citare un “passaggio meraviglioso” della Lettera agli Ebrei: “La fede è fondamento delle cose che si sperano e prova di quelle che non si vedono” (Eb11,1). Abbiamo discusso con Monda sul titolo di Tu credi? prima della sua pubblicazione. Si ragionava se non fosse proprio la seconda parte di questo versetto, nella forma inglese della King’s James Version, a dover finire in copertina: “L’evidenza delle cose non viste (the evidence of things not seen)”. Perché? Perché questa frase, che si riferisce alla fede, a nostro avviso può, mutatis mutandis, definire anche l’immaginazione. La fede non si risolve nell’immaginazione, e viceversa, ma tra di esse c’è un legame profondo. Tuttavia proprio all’interno di tale legame si biforca un bivio, che dunque lega e insieme separa la fede dell’incredulità. Alla fine il “passaggio meraviglioso” della Lettera agli Ebrei è rimasto come titolo della prefazione a firma dell’autore.
Conclusione
Antonio Monda con il suo libro non intende presentare la coscienza religiosa degli Stati Uniti. Anzi, premette alla sua inchiesta la precisazione che essa non corrisponde alla tendenza generale del Paese riguardo ai temi religiosi. Il suo è un approccio molto personale. Ha intervistato persone conosciute grazie al suo lavoro, e ne ha conosciute di nuove. L’autore non lo scrive, ma le porte gli sono state sempre aperte tranne in due casi: Hillary Clinton e Condoleezza Rice. Altri tre autori non hanno potuto rispondere: Susan Sontag e Arthur Miller perché scomparsi durante l’elaborazione del volume; Mohammad Ali per motivi di salute. Alla fine ci si rammarica perché un’inchiesta così interessante non abbia coinvolto altre voci forti d’America. Per citarne una tra tutte: Bruce Springsteen, a nostro giudizio il vero grande assente di queste conversazioni, accanto a Woody Allen. Comunque è chiaro che il volume non ha pretese di esaustività, se mai l’intenzione di far meditare.
Tu credi? fa riflettere sul rapporto che alcuni artisti e intellettuali statunitensi (molti dei quali però non sono nati negli Stati Uniti) hanno con la fede. Esso è complesso ma non negativo. Soprattutto nelle loro parole si avverte un grande bisogno insoddisfatto di spiritualità. Non è possibile riassumere tutte le posizioni in poche pagine: gli approcci alla fede sono troppo disparati e vanno dalla preghiera quotidiana alla raggelante convinzione dell’assenza di Dio. In mezzo tante posizioni sfumate, indefinite, precarie. Qui abbiamo cercato di esplicitare i problemi e i temi principali che emergono dalle conversazioni, utili per una riflessione ulteriore, specialmente sul rapporto tra arte e fede.
Al di là di qualunque intento sociologico o statistico, l’autore di Tu credi? non lascia il lettore con risposte definite., AL contrario, a lui affida domande impegnative, capaci di svegliare coscienze assopite: “Com’è che si diventa credenti? Cosa succede? E com’è che si sceglie invece di non credere? Cos’è che non scatta? Cos’è che dà una visione del mondo finita e materiale […]? Ed è possibile essere realmente felici quando si arriva a una conclusione del genere?” (p. 118).
– 01/05/2006
Credo d’immaginare immagino di credere
– 11/05/2006
“Tu credi?”: rispondono Rushdie, Lynch e gli altri
– 01/05/2006
Dio, la cultura statunitense e i limiti dell’immaginazione
– 28/04/2006
Dio c’è. Forse
– 24/04/2006
La divina conversazione
– 15/04/2006
Tu credi? Di Antonio Monda
– 15/04/2006
Antonio Monda, Tu credi?
– 02/04/2006
L’America che crede. E quella che dubita
– 25/03/2006
Dio? Un vecchio saggio. Forse una baby sitter…
– 01/03/2006
Tu credi?
Paul Auster, Saul Bellow, Salman Rushdie: sono solo alcuni degli intellettuali, tutti grandissimi, intervistati da Monda sul loro rapporto con Dio e la fede. Una serie di riflessioni intime e illuminanti, sulle quali aleggia una domanda non elusa dai protagonisti: perché loro hanno trovato proprio negli Stati Uniti il luogo della loro libertà d’espressione artistica e intellettuale, nonché della tolleranza religiosa?
– 12/03/2006
Il Padreterno secondo Rushdie e Walcott
– 14/03/2006
I cattivi ragazzi di Little Italy
– 18/03/2006
E pian piano l’intellettuale arriva al Dio dei semplici
– 15/03/2006
Diciotto modi di avere fede
– 24/02/2006
Se c’è un Dio anche per i Nobel
– 24/02/2006
Parola di Pulitzer, Dio c’è ed è una donna di colore
Lei crede in Dio?
“Vedo che iniziamo direttamente dalla Grande Domanda. La parte più grave di me stesso, quella che è seriamente intenzionata a non farsi prendere in giro da nessuno, dice: “Cosa aspetti? Ammettilo : Dio è qualcosa che abbiamo inventato per vivere con la consapevolezza della nostra mortalità”. I cani e i gatti pensano di vivere per sempre, e non hanno alcun dio. Io non ce la faccio a non notare che le uniche specie consapevoli sin dall’inizio del fatto che un giorno non vivranno più sono quelle che erigono cattedrali e organizzano processioni con statue addobbate con tuniche. Ma nello stesso tempo un universo che non contempli un’intelligenza armonica e superiore di qualche tipo è così sterile… Mi chiedo se alcuni di noi non siano a riguardo troppo intelligenti per il nostro stesso bene. È facile, specialmente quando si invecchia, congratularsi con se stessi per la propria abilità di vedere attraverso ogni cosa, ma quando riesci a vedere attraverso ogni cosa trovi il nulla. E mi chiedo se io, o chiunque, voglia sinceramente e realmente essere così disilluso da vivere in un mondo privato completamente di qualunque elemento di magia o di mistero…? Quando ero bambino avevo un gioco chiamato Magic Eight Ball. Era una palla di plastica, simile a quella di un biliardo, ma grande come un pompelmo, alla quale si potevano fare delle domande dopo averla agitata con forza. Da una finestrella color viola comparivano otto differenti risposte, e ricordo che una era: “Risposta nebulosa: riprova più tardi”. Quindi voglio citare il mio oracolo dell’infanzia, e alla domanda rispondo: “Risposta nebulosa: riprova più tardi”. O, se vuole che affronti la domanda da una prospettiva leggermente più adulta: sospetto ci ciano delle relazioni profonde ancora non scoperte tra Dio e i principi della fisica. E io credo nella fisica”.
Ritiene che la scienza possa spiegare ognicosa?
“Io non credo che la scienza, la religione, l’arte oqualunque altro tipo di ricerca umana sia in grado di spiegare tutto. Ma credo che stiano lavorando tutte nella stessa direzione. Uno dei perenni obiettivi della fisica è una teoria di campo unificata, una spiegazione di come lavori l’universo che tenga in considerazione sia l’astrofisica che la fisica delle particelle subatomiche, elementi che in questo momento sembrano essere in contrasto tra di loro. Quello che è vero riguardo al movimento delle stelle non risulta essere vero per il movimento degli elettroni, e così il risultato sembra impossibile, e probabilmente lo è. Gli scienziati lavorano su misteri oscuri e frustranti come quelli dei teologi e degli artisti, e molto di quello che i fisici stanno scoprendo non arreca novità in quella direzione, e sembra non avere alcun senso. Quindi se credi nella fisica risulta veramente un grande salto affermare che credi anche in Dio. In un qualche tipo di dio”.
Tertulliano diceva: Credo quia absurdum.
“È un paradosso eccellente.
Qualcun altro, non ricordo chi, ha detto qualcosa del tipo: “È meglio credere, perché se lo fai, e poi si scopre che hai ragione, hai vissuto una vita di fede e, a seconda delle tue convinzioni, può anche esserci la prospettiva di un premio in paradiso. Se invece si scopre che avevi torto e che non c’è un Dio o la vita dopo la morte, cos’è che hai perso in realtà?”. Apprezzo questa concezione così prammatica. La definirei l’approccio alla religione di un Consumatore Intelligente”.
Mi parli della sua educazione religiosa.
“Sono stato educato, almeno a parole, secondo i dettami della religione episcopale”.
Perché dice a parole?
“Perché per noi l’osservanza era rappresentata esclusivamente dal frequentare la chiesa la domenica e recitare la preghiera prima dei pasti. Ho frequentato anche le scuole domenicali e ancora ricordo a memoria le preghiere, a cominciare dal Credo di Nicea, ma quando crescevo la mia casa era tutto tranne che invasa da qualunque tipo di senso attivo di spiritualità cristiana. Non avevamo crocifissi, statue della Vergine né niente del genere. Potrei dire che andavamo in chiesa perché probabilmente sarebbe sembrato troppostravagante il contrario. Ma stranamente, da bambino, ero ossessionato dall’iconografia cristiana. Forse tutto derivadall’influenza dei parenti di mia madre, che erano cattolici. Mi ricordo che facevo delle ostie con il pane in cassetta. E quando avevo sette, otto anni, dipingevo molti quadri religiosi. Quello che consideravo il mio capolavoro raffigurava delle anime che ascendevano da un cimitero verso il cielo. Erano tutte ricoperte da tuniche bianche, ed erano raffigurate tutte di profilo, perché era l’unico modo in cui ero in grado di dipingere. Sorridevano estaticamente e galleggiavano in cielo verso il paradiso, che avevo dipinto nel lato in alto a destra della tela, e avevo ricoperto con delle stelline dorate. Per quanto ricordo, la mia descrizione del paradiso somigliava molto al Griffith Park Observatory. Si trova sulle colline di Los Angeles, dove sono cresciuto: è il posto dove Sal Mineo viene ucciso in Gioventù bruciata. Più avanti negli anni, ho avuto un’amica che frequentava una scuola cattolica. I corridoi di quella scuola erano tutti ricoperti da arazzi vecchi e ammuffiti, e vicino all’ingresso della caffetteria c’era una scultura a grandezza naturale di Cristo, che teneva aperta la sua tunica per rivelare il proprio cuore rosso e sanguinante. Ogni giorno, le ragazze che andavano a ordinare i bastoncini di pesce, sfilavano sotto la statua di Gesù, che sanguinava quietamente per loro. Dietro l’area attrezzata per gli sport c’era un campo con delle croci nere, nel quale erano sepolte le monache. Al confronto, la scuola pubblica nella quale frequentavo il liceo sembrava più o meno uno shopping
center in declino. Ero così invidioso dell’aria soprannaturale della scuola della mia amica: mi sembrava parte di un mondo più misterioso, pauroso, ma anche promettente”.
Mi sta dicendo che il cattolicesimo le ha fatto sentire la presenza di Dio più di quanto avesse fatto il protestantesimo episcopale?
“Diciamo che la presenza implicita di un Dio particolare e pauroso era molto più convincente dell’aura di sconfitta secolare e polverosa che si respirava nella mia scuola”.
Qual è l’immagine che aveva di Dio?
“Una donna di colore”.
Lei sa che Derek Walcott (Nobel per la Letteratura nel ’92, ndr) mi ha detto invece che lo immagina tuttora come un uomo bianco anziano e barbuto?
“Ritengo che queste immagini arrivino presto nella nostra vita. Quando era bambino la mia babysitter era una grande donna di colore che amavo di un amore fuori del normale. Quando penso a Dio penso a
lei”.
– 21/02/2006
Paula Fox: “Dio è il nome di qualcosa che non capisco”
Libri dello stesso autore