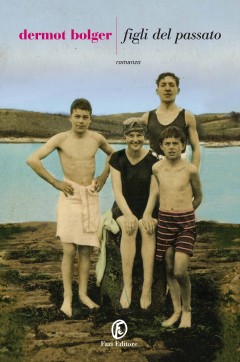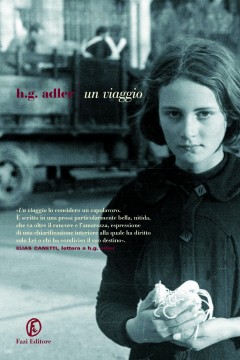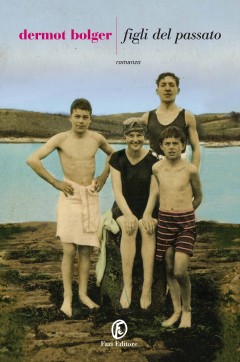
Dermot Bolger
Verso casa
Traduzione di Lucia Olivieri
«Non è sufficiente nascere in un posto per sentirsi a casa. La propria casa si trova là dove non sono più necessarie spiegazioni e si diventa finalmente se stessi».
Animali braccati e indifesi, Hano e Katie, i protagonisti di questo romanzo di Dermot Bolger, chiedono alla vita solo un rifugio che metta fine al movimento di una fuga disperata. Il delitto che hanno commesso li ha esiliati per sempre ai confini dell’esistenza sociale, ma la loro perdita d’innocenza ha radici ben più profonde di quell’ultimo gesto irrevocabile. È stato il carattere criminale del Potere, disgustosa maschera di viltà e pulsione omicida, a spingerli oltre il bordo, in quella terra di nessuno dove brilla incerta, miraggio della notte, la promessa di uno scampo. Verso casa è il romanzo di una giovinezza stuprata e derubata dei suoi beni più preziosi, l’amore e l’amicizia, e insieme la cronaca di un doloroso e necessario emergere alla consapevolezza di sé e del proprio destino. Nessuno prima di Bolger ci aveva descritto con tanto crudo e apocalittico sentimento della verità l’Irlanda che ci appare in queste pagine. È qui, fra i sobborghi miserabili di Dublino e le torbiere intrise di pioggia, i decrepiti villaggi contadini e i boschi scampati alla distruzione, che Hano e Katie, poveri di tutto e carichi di un tremendo fardello di memorie, dovranno tentare di vincere la loro partita. È qui che, imparando a dimorare in un rischio perpetuo, questi natural born killers cresciuti nel cuore della vecchia Europa diventeranno se stessi, troveranno la loro casa. Quella casa che è possibile abitare solo quando ogni altra casa possibile, ogni certezza del futuro, ogni compromesso di comodo con l’esistenza sono ormai ridotti in cenere.
– 08/03/1997
VERSO CASA CON BOLGER RISCOPRENDO L’IRLANDA
‘Verso casa’, bellissimo romanzo dell’irlandese Demot Bolger (Fazi, traduzione di Lucia Olivieri), si apre sulla fuga dei giovanissimi Hano e Katie attraverso la campagna d’Irlanda. Da Dublino, nei cui sobborghi sono cresciuti, e in cui anche Bolger ha bruciato rapidamente infanzia e adolescenza per diventare scrittore ed editore di sconosciuti ora famosi (tra loro Doyle e Mac Namee), li esilia un delitto che, in qualche modo, è legato alla morte dell’amico Shay. Quale sia questo delitto lo si saprà soltanto alla fine del libro, verso la quale si corre, desiderando e temendo il suo arrivo come raramente accade, sull’onda di una prosa densa e fonda come l’oscurità che copre i due fuggitivi. L’ esilio in patria di Hano e Katie è cominciato molto prima della loro fuga, ed è lo stesso spaesamento che ha già colpito intere generazioni di irlandesi. L’infelicità dei padri, strappati alla terra di lontane contee per la città e le sue fabbriche o per i cantieri inglesi, avrebbe dovuto consentire ai figli di rimanere a casa: ma la casa di questi ragazzi non più il passato rurale che il padre di Hano tenta di difendere nel suo piccolo giardino di periferia, giardino che sta al centro del difficile, pudico scambio d’amore tra padre e figlio; e non è nemmeno nell’Irlanda urbana del loro presente, dentro cui ci riportano, nella direzione opposta a quella seguita dalla cronaca della fuga, il lungo flashback di Hano e le visioni che occupano la mente di Shay oltre la morte. Eppure è lì che vivono , nel paese dei sussidi e delle lunghe file agli uffici di collocamento o negli aeroporti, in un limbo senza tempo di cui si sentono prigionieri e in cui si rifugiano per non dover guardare nel vuoto che nessun futuro, così pensano, verrà a colmare. Dei nostri tre amici. Shay è il primo a scuotersi dall’immobilità e a entrare nel labirinto che si deve esplorare per trovare il luogo in cui si diventa finalmente se stessi: a lui si affidano Hano e Katie. Tutti e tre, in un incastro un po’ troppo esatto, vi incontrano lo stesso Minotauro, il mostro a tre teste dei Plunkett, corrotti e impuniti politici e affaristi tra gli spartitori di un’Irlanda che in futuro diventerà come un’oasi verde per ricchi europei. Nell’ultimo provvisorio rifugio, ripercorrendo la sua vita accanto a Katie addormentata, Hano trova che la vera casa è dove nessuno ne cercherebbe una, nella fuga, e nell’amore che nasce e resiste dentro la precarietà. Nessuno, o chiunque abbia imparato, anche senza pagare un prezzo così alto, che non esiste alcun posto che si possa chiamare casa, non esiste più nessun posto al mondo in cui ci si possa sentire al sicuro. A questa casa, già intravista nell’adolescenza, Hano ritorna dopo una tortuosa deviazione senza la quale non esisterebbero né il romanzo né il percorso di rigenerazione che questi personaggi compiono anche per il lettore; è un cammino che li ha portati in luoghi davvero inospitali, ma la loro avventura è cominciata dove comincia per tutti, dal nodo di crudeltà, ribellione e sofferenza che stringe l’adolescente quando taglia via da sé gli ormeggi dell’infanzia.
Nichilistico viaggio attraverso un paese povero e devastato
IRLANDA INSANGUINATA
Il volto illividito dal freddo, ma soprattutto dalla paura, non si muovono. Se ne stanno immobili in un fossato ai bordi della strada, nascosti dietro un folto cespuglio. Sentono i passi dei poliziotti che calpestano la ghiaia, mentre i fasci di luce delle loro torce scrutano il buio. Gli stivali lucidi di un uomo con i baffi folti che sfiorano i corpi di Hano e di Katie raggomitolati raggomitolati nel terriccio. Hano è scosso da un tremito, respira affannosamente come se gli mancasse l’aria. Katie invece non ansima, le labbra chiuse e lo sguardo duro. I minuti trascorrono lenti. Hano rivede in un flash back la scena di poco prima – un corpo che si abbatte su un pavimento, il sangue che schizza sui vestiti e i bagliori di fuoco -, ma ormai alla rabbia è subentrata l’angoscia. Gli stivali si muovono, i passi s’allontanano e il cupo silenzio è infranto dal rombo del motore di un’automobile. In un sussurro Katie dice: “Se ne sono andati”. Ha i capelli corti, un maglione blu e un paio di jeans la ragazza che adesso è in piedi. Hano indugia qualche istante poiché muoversi significa prendere una decisione. Poi: “Senti, Katie, torna indietro. Altrimenti sbattono dentro anche te quando ci beccano”. Lei lo guarda con occhi gelidi. Lui ripete la frase: “Vattene, ritorna a casa. Io non so cosa mi aspetta. E per te non posso fare niente”. Hano barcollando si allontana. Lei gli va dietro: “Da te non voglio niente. Fai come se non ci fossi”. Camminano per ore abituandosi all’oscurità. A volte perdono il senso dell’orientamento. Una macchina della polizia li supera e Hano sente la camicia fradicia di sudore. Oltrepassano campi disseminati di rottami, pneumatici accatastati, mucchi di immondizia. Si fermano agli incroci, incerti dove dirigersi. Percorrono vie deserte e sentieri tra i campi. Sfiorano edifici periferici e case malandate. Un cane abbaia. Un passo dopo l’altro si allontanano dalla città senza mai parlare. Ancora avanti sotto un cielo opaco. Seguendo una strada che costeggia villette dai muri scrostati, raggiungono un promontorio. Dietro si vede Dublino punteggiata di luci, davanti si estende il mare. Sulla spiaggia Katie lo guida verso un capanno dove avrebbe potuto ripararsi dal vento. Hano le domanda: “Come facevi a conoscere questo posto?”. E lei racconta delle sue scorribande notturne con gli amici a bordo di auto rubate che finivano sempre lì. “Che tu lo creda o no, tutti gli urli e il casino che facevamo si dissolvevano di colpo, come se fossimo arrivati alla fine di un viaggio. Guardavamo il mare. Almeno il mare non è di nessuno, non c’è nessuno che viene a mandarti via se non hai pagato l’affitto…”. Hano la interrompe: “Hai già passato la notte con qualcun altro qui?”. La risposta di Katie è sprezzante e insieme amara: “Che cosa te ne frega?”. Gli spiega che quel posto è pieno i fantasmi. I compagni di tante folli avventure sono finiti in prigione o in manicomio o in un ospedale consumati dall’Aids. Hano per la prima volta percepisce nella voce di Katie un grumo di disperazione. E per la prima volta si rende conto che quella bislacca ragazza unitasi a lui è diversa da come l’aveva vista a Dublino. Allora gli era antipatica, lo irritava. Gli sembrava identica “a tutte quelle ragazze che vedeva per strada ridere beffarde dei passanti, indifferenti alle giornate che sfilavano loro davanti, appestate dalla noia, specchio di un’adolescenza avvizzita”. In quella sedicenne dai capelli arruffati e le scarpe da tennis inzaccherate, Hano riconosce una parte di se stesso. Lungo e labirintico è l’itinerario di Hano e di Katie attraverso un’Irlanda povera, generosa e ribelle – destinata a scomparire come i boschi abbandonate e le nere torbiere – per trovare un rifugio e una speranza. Il loro è un vagabondaggio tra i ricordi che affiorano e sono ferite spirituali che acutizzano il dolore di due tristi ragazzi che si sentono traditi e orfani. E su di loro incombe un altro fantasma: quello di Shay, l’amico dei cuore di Hano e di cui Katie era stata segretamente innamorata, prima che fosse ucciso. ”Verso casa” (Fazi Editore) di Dermot Bolger è un romanzo forte e aspro, impregnato di un profondo malessere, di una lacerante inquietudine che si trasforma in un impeto di rivolta. La complessità dell’opera deriva dalla struttura narrativa non lineare ma ellittica, dalle diverse angolature con cui l’autore osserva la vicenda intrecciando senza interruzione il presente e il passato, e soprattutto per l’ampio ventaglio dei temi trattati. L’abilità di Dermot Bolger, commediografo oltreché narratore (nel 1917, a 18 anni, ha fondato la casa editrice Raven Arts Press dando un impulso decisivo allo sviluppo della nuova letteratura irlandese), è di riuscire a tenere unita una materia così densa. Ed è esemplare il modo attento e minuzioso con cui racconta, rappresentando in modo visivo non soltanto i personaggi e l’ambiente ma anche gli stati d’animo. Le parole diventano immagini malinconiche ma illuminate – nelle parti più efficaci del libro – di una luce poetica che rischiara un universo cupo e lacerato. Se il leit-motiv del romanzo di Dermot Bolger è la fuga di Hano e di Katie – come trasognati rivisitano i luoghi irriconoscibili della loro infanzia – via via affiorano i guasti interiori ed esistenziali, le fratture tra cattolici e protestanti, i contrasti tra la vecchia Irlanda delle ballate e la giovane Irlanda del rock, il caotico miscuglio tra differenti stili di vita, e la ricerca di un’identità sempre più difficile da rintracciare. Divisi tra contrastanti impulsi, l’animo fragile e nella testa tanti confusi pensieri, “i figli del Limbo”, come li definisce Bolger, si sentono esuli in patria. Se la casa è un’anima, loro l’hanno perduta. Hanno rifiutato l’esistenza stentata e faticosa delle loro famiglie d’origine contadina installandosi in monolocali periferici. Hanno fatto la coda di fronte agli sportelli degli uffici di collocamento per trovare un lavoro impiegatizio. Come Hano che riesce ad ottenere una scrivania nel Dipartimento elettorale e qui, la testa china su schede e fogli, fa la conoscenza con la noia di giornate sempre uguali e subisce le angherie del capo dei burocratici. In quello stanzone male illuminato, incontra Shay, allegro e loquace. Giocatore di biliardo, frequentatore di pub e di locali notturni, innamorato della sua vecchia Triumph Herald con cui scorazza per i quartieri di Dublino, agli occhi di Hano è un personaggio mitico. Ne imita i gesti, il modo di parlare e di camminare. E l’esuberante Shay si affeziona all’impacciato Hano, lo protegge fin quando lo invita a trasferirsi nel suo alloggio. Quella stagione però si rompe quando Shay improvvisamente, staccandosi dall’Irlanda nella quale non si riconosce più, decide di partire per l’Europa. Invano l’amico cerca di dissuaderlo: “Rimani, la tua casa è qui…” e lui: “La propria casa bisogna trovarla, non è quella dove si nasce. Neanche un pollo passa la vita accovacciato sui frammenti del proprio guscio…”. Continuando ad alternare episodi che escono dalla memoria a quelli che scorrono nel presente, Dermot Bolger dilata ancora il romanzo spingendolo verso vicende dal significato simbolico – non sempre convincenti – o verso situazioni politico-affaristiche. Ad esercitare il loro potere finanziario sono i fratelli Plunkett: Pascal, alto e massiccio, un “self made man” diventato proprietario di officine, imprese di pompe funebri, catene di negozi e società immobiliari; e Patrik, un politicante che sotto i modi eleganti ed affabili nasconde un animo cinico. Mentre ferve la campagna elettorale, Hano viene assunto come autista da Pascal Plunkett e conosce intrighi, maneggi e ricatti. È vittima di un brutale episodio che lo fa precipitare nello sconforto. Si ricorda che Shay l’aveva ammonito: “Guardati dai Plunkett…”. Dopo alcuni mesi riappare Shay. Hano lo trova in casa dentro un cappotto di lana scura, un cappello nero e un paio di anfibi ai piedi. Ha gli occhi stanchi e la barba lunga. Non è più lo stesso di prima. La sua euforia è falsa, recita una parte che non gli si addice come se volesse nascondere un segreto. Ripete: “Lo odio questo Paese, non so perché sono tornato…”. Qualche giorno dopo si contraddice: “E’ strano, vero? Non è necessario che un posto di piaccia per sentirne la mancanza. Guardati attorno. Dublino è ormai una città morta, e io mi trovavo dove dovrebbe pulsare il cuore del futuro. Non che ne sentissi la nostalgia , ma mi trascinavo dentro un senso di incompletezza. Come si fa ad andarsene da un posto se poi devi continuare a portartelo dentro?”. In quel periodo appare Katie: quasi ogni giorno è lì, si siede su una sedia e guarda con occhi imploranti Shay chiedendogli un po’ di tenerezza. Poi la tragedia. Una notte un giovinastro cerca di aprire la portiera della Triumph di Shay, dalla finestra Hano vede la scena e urla. Shay corre un strada. Pochi secondi e una Bmw guidata da Justin Plunkett, figlio dell’onorevole Patrick Plunkett e dedito al commercio di droga, lo investe e lo uccide, temendo che l’esule dall’Europa, diventato un corriere di “polvere bianca”, riveli il suo losco traffico. A vendicarlo è Hano. Convinto di trovare Justin entra nella villa di Pascal Plunkett che gli promette regali e quattrini se mentirà alla polizia dicendo che si è trattato di un incidente. Lo accarezza e lo abbraccia, il ragazzo però si divincola e con un coltello squarcia il corpo dell’affarista. Prima di scappare incendia la palazzina. Il finale del romanzo riporta in primo piano Hano e Katie in fuga. Ormai consapevole che la loro avventura è destinata a fallire, Hano si convince che “la propria casa si trova solo in se stessi” non accettando né patteggiamenti né compromessi con un mondo ostile. Al termine del nichilistico viaggio Dermot Bolger ha uno scatto anche stilistico. Il racconto diventa concitato, e lo scrittore mette in bocca ad Hano queste provocatorie parole: “‘I Ribbonmen’, gli uomini di Malcom Dwyer, i ‘Croppiers’, gli ‘Irregulars’ attaccavano di notte quelle che una volta erano state le loro case. Ogni secolo ha dato un nome a questi giovani ribelli. Quale nome sceglieranno in futuro per noi?”.
– 08/01/1997
I ROMANZI DI DUBLINO E DINTORNI
E’ un momento d’oro per la letteratura irlandese in Italia. Oltre ai libri di McNamee e di Collins che recensiamo in questa pagine, altre uscite vanno segnalate. In primo luogo “Moran tra le donne” di John McGahern (Einaudi), uno scrittore che in Irlanda è enormemente popolare. Poi, ovviamente, “Uno splendido isolamento” di Edna O’Brien, forse la maggiore scrittrice irlandese vivente (pubblicato da Feltrinelli). Curioso anche il romanzo “Verso casa” di Dermot Bolger (Fazi Editore). Infine, di Roddy Doyle (lo scrittore dublinese reso famoso da film come “The Commitments”, “The Snapper”, “The Van”) Guanda ha appena pubblicato “La donna che sbatteva nelle porte”.
– 08/01/1997
Un confronto fra la letteratura delle due nazioni nei secoli fino agli scrittori contemporanei
IRLANDESI E INGLESI, PERCHE’ COSI’ NEMICI? LEGGETE I LORO LIBRI E CAPIRETE PERCHE’
Oggi gli scrittori dell’isola non sono solo la romantica espressione di un popolo. Nella nuova letteratura una vena “anazionale”. Gli esempi di McLiam Wilson e Colm Toibin. La violenza in “Resurrection man” di Eoin McNamee
La questione irlandese è paradossalmente al centro che alla periferia dei problemi inglesi e anche europei. La cronaca di quasi trenta anni di sangue ha messo in luce motivazioni arcaiche, come il nazionalismo dell’Ira o l’anticattolicesimo Orangista degli unionisti, mescolati ad attualissime ridefinizioni di territori e istituzioni nazionali che la globalizzazione e l’Europa provocano ovviamente anche qui. Culturalmente poi la questione irlandese è davvero centrale a quanto nel continente si intende per britannico. Gli ultimi vent’anni di attività editoriale in Inghilterra sono stati caratterizzati dal tentativo di dar voce a tutto il mondo anglofono: se fino agli anni Sessanta i protagonisti erano John Osborne, Kingsley Amis, Angus Wilson o Philip Larkin, negli ultimi tempi a dominare la scena letteraria sono stati Salman Rushdie, Ben Okri, V.S. Naipul, Michael Ondatjie, Nadine Gordimer o Doris Lessino. Siamo nell’epoca del “feed – back” dell’impero, un effetto – eco dell’influenza che la Gran Bretagna ha avuto sulle colonie ha dato un accento decisamente cosmopolita, antiromantico e antinazionalista alla letteratura inglese contemporanea. A fianco di questa situazione, la letteratura irlandese appare spesso distante, ancora romantica e nazionalista. Se però si considera la letteratura inglese in una prospettiva storica la tradizione degli scrittori irlandesi costituisce, se non statisticamente almeno per la qualità, una buona metà del cuore britannico. Da Jonathan Swift a Oscar Wilde, da George Bernard Shaw a Joyce o a Beckett l’importanza dell’Irlanda non è regionale; si può dire piuttosto che incarna l’anima sovversiva, repubblicana, il contrasto. Le due mentalità si fronteggiano attribuendosi a vicenda una lunga serie di luoghi comuni che finiscono col costituire un’identità complessa, in un certo modo simbiotica. L’inglese medio di fronte all’irlandese diventa un difensore delle scelte di Enrico VIII ed Elisabetta I, grato alla corona per avergli risparmiato gli onori della Controriforma e l’oscurantismo che si diffondono in Italia o in Spagna dopo i rispettivi rinascimenti e secoli d’oro. Nessun intellettuale inglese dimentica mai le pressioni su Galileo o quel Giordano Bruno, qui accolto nei circoli elisabettiani oltre che a Oxford e che in Italia finisce sul rogo. Da Shakespeare agli scrittori contemporanei, la protesta degli inglesi verso il loro sovrano è quasi sempre temperata dalla consapevolezza di una libertà dall’influenza cattolica. Questa diventa anzi “la” libertà, un principio profondo nella coscienza anglosassone che ha la sua più piena espressione nella famosa lettera di John Locke sulla tolleranza. Gli scrittori inglesi, come gli altri sudditi della corona, ironizzano sulle proprie istituzioni ma senza mai voler distruggere (per questa ragione il comunismo è sempre stato un movimento marginale in Gran Bretagna). Secondo la celebre battuta di Oscar Wilde, in Inghilterra si può dire tutto, purché non si spaventino i cavalli. E Wilde, da buon irlandese, i cavalli li terrorizzava. Chi riveda una commedia apparentemente lieve come “L’importanza di chiamarsi Ernesto” sapendo che Wilde la scrisse al culmine della passione per Bosie e a un passo dalla galera, non può non sentire in fondo al sorriso per i manierati progetti matrimoniali eterosessuali dell’aristocrazia londinese l’energica protesta contro il perbenismo ipocrita che sta per condannarlo. Con intonazioni diverse gli scrittori irlandesi fanno regolarmente, come Wilde, una grande paura ai cavalli inglesi. Per ragioni politiche o private o letterarie, entrano immancabilmente in un contrasto di qualche genere con la norma e misurano i limiti della libertà inglese. L’inglese è un suddito, non un cittadino; paradossalmente, la straordinaria libertà individuale che si gode nel regno di Elisabetta II, che ancora oggi ha pochi paragoni in Europa, deriva in gran parte dal fatto che il sovrano risparmia alla società la politicizzazione del potere. Che i teatri, la scienza, lo sport, le università e insomma la nazione non siano oggetto di scambio tra i diversi gruppi di potere che si affermano nella politica, permette agli inglesi di disinteressarsi olimpicamente di parlamentari e ideologie. Un nuovo governo non cambia il governo della televisione pubblica o le università, non ridistribuisce poltrone prestigiose. Ci sono dei privilegiati, per nascita o per censo, c’è un “Establishment”, naturalmente, ma le diverse istituzioni hanno sufficiente robustezza per resistere agli assalti che pure sono tentati, ad esempio dalla Thatcher contro la Bbc. L’inglese si interessa moderatamente di politica senza pensare che le cose cambieranno mai troppo, con una fiducia nei propri amministratori non necessariamente dovuta a dabbenaggine, piuttosto a una profonda indifferenza. L’irlandese è invece uno spirito critico, ha un talento letterario e poetico spesso marcato politicamente e uno spirito caustico, politico, che penetra nelle buone maniere della discussione inglese mostrandone limiti e confini. Cosa c’entra d’altra parte il protestantesimo, ad esempio, con il senso della storia dei cattolici o la pratica della confessione che abolisce la colpa individuale, con l’irrequietezza sensuale e poetica di Molly Bloom, le divagazioni di Estragone o Vladimiro che travolgono il “common sense” britannico. Per quanto immersa nei luoghi comuni con cui irlandesi e inglesi si guardano, questa diversità è eloquente; supera, nella letteratura, la miopia che dall’una e dall’altra parte hanno caratterizzato la storia dei conflitti politici di cattolici e protestanti. Niente altro se non la letteratura riesce davvero ad articolare la diversità e l’accanimento reciproco di inglesi e irlandesi; forse perché la questione religiosa coinvolge principi morali così profondi che anche quando gran parte della popolazione inglese non è credente e certo non praticante, il sospetto nei confronti del cattolicesimo sembra essere rimasto inalterato, annidato in un rancore silenzioso, in fondo che si sente minacciato da Roma nonostante nei secoli l’influenza politica del Papa sia enormemente diminuita. La distanza tra i due gruppi si è del resto ridotta in un contesto in cui si vive a fianco con musulmani, induisti, buddisti. Sarebbe tuttavia riduttivo parlare degli autori irlandesi di ieri e di oggi come romantica espressione di un popolo. Se fossero semplicemente scrittori irlandesi, non ci importerebbe un granché di Beckett o Joyce. Al contrario, è perché hanno davvero superato per la letteratura europea il mito ottocentesco della tradizione letteraria nazionale che sono così centrali nel nostro Novecento. Come risponde Stephen Dedalus al nazionalista Davin: “Voi mi parlate di nazionalità, lingua, religione, io proverò a volar via da quelle reti”. Questa vena “anazionale” riemerge talvolta anche nella letteratura irlandese contemporanea. Le pagine di McLiam Wilson (“Ripley Bogle”, pubblicato l’anno scorso dalla Garzanti) sull’Irlanda, nonostante la descrizione drammatica del conflitto, non si lasciano lusingare dal nazionalismo. Lo stesso vale per uno scrittore come Còlm Toibin (proposto alcuni anni fa da Panta, che con “Barcelona” ha ripercorso lo stesso itinerario di disambientamento). O per Tom Paulin, tra i più energici e pungenti, che combina talenti diversi nella scrittura, dalla critica alla poesia. Al contrario, nel romanzo di Eoin McNamee “Resurrection Man” appena pubblicato da Einaudi (p.255, lit.26mila) il protagonista Victor Kelly, è un protestante irlandese con un nome cattolico. Insomma siamo in tutto e per tutto nella prospettiva di una letteratura nazionale e dello spirito, per quanto lacerato, che ne discende. La violenza, non solo quella delle azioni terroristiche ma tutta, dominante nei rapporti erotici, nelle discussioni, in ogni angolo del libro, è l’Irlanda dell’autore. Qui più che negli altri libri citati è evidente il pesantissimo prezzo dei trent’anni di guerra. Una guerra per giunta che appare, da lontano, del tutto anacronistica. A volte si ha tuttavia la sensazione che in tempi così violenti (come del resto è accaduto in Italia per il terrorismo, almeno negli anni subito a ridosso dei fatti di sangue) quello che è stato scritto si sia limitato a documentare, senza davvero riuscire a raccontare.
– 11/01/1997
Vendette e amori scivolanti nel vuoto
Dev’essere stato sull’onda della scorsa Buchmesse, dedicata all’Irlanda, che l’editore Fazi ha deciso di tradurre ‘Verso casa’. Dermot Bolger, nato a Dublino nel 1959, l’ha pubblicato nel 1990.Prima e dopo ha scritto altri romanzi e varie cose teatrali; prestissimo, nel 1977, ha fondato una casa editrice che ha un ruolo importante. Dunque, un intellettuale che lavora per il suo Paese e con gli occhi ben fissi sulla realtà sociale. Eppure (ed è un paradosso che la storia realizza spesso) il suo è un romanzo elegiaco, intimista, che tende a sciogliersi nel lirico. La voce narrante passa dalla terza persona alla prima, talvolta cede il passo alla poesia. Intorno al protagonista, il giovane Hano, stanno la ragazza che ama, Katie; Shay, l’amico – maestro che cerca fortuna all’estero e in continua rivolta con il mondo; Plunkett, un imprenditore politicante, che sfrutta i propri dipendenti ed è tormentato dalle perversioni della propria omosessualità; il padre malato di cancro; un’Irlanda in cui, nonostante l’entrata nella Comunità Europea e le promesse elettorali, non cambia mai nulla. Anche se la vicenda è quasi contemporanea, sembra a volte di leggere il Joyce pre-Ulisse, con la stessa difficoltà di riconoscimento in un Paese povero, ma dalle straordinarie risorse intellettuali. Solo che quello che identifica ‘Verso casa’ è una specie di stanchezza e di ripiegamento: come se le cose narrate scivolassero nel vuoto, o da quelle parti. La scrittura di Bolger copre di ombra, sfuma, finisce per cancellare i contrasti. Persino il ‘grandguignol’ sadomasochista del penultimo capitolo (una scena di coprofilia davvero impressionante) e il melodramma finale (uccisioni, vendette, amori) si stemperano nella regressione uterina del giovane protagonista: la cui casa non è da nessuna parte, o fra le braccia di Katie. Con l’omicidio, la formazione di Hano sembra fallire definitivamente. E forse è davvero questa la forma che deve prendere un romanzo di realismo sociale e di interiorità, in un tempo che concede poco al realismo sociale e non molto all’interiorità.
– 05/01/1997
Verso Casa
La disperazione di due ragazzi nel romanzo di Dermot Bolger
Il volto illividito dal freddo, ma soprattutto dalla paura, non si muovono. Se ne stanno immobili in un fossato ai bordi della strada, nascosti dietro un folto cespuglio. Sentono i passi dei poliziotti che calpestano la ghiaia, mentre i fasci di luce delle loro torce scrutano il buio. Gli stivali lucidi di un uomo con i baffi folti che sfiorano i corpi di Hano e di Katie raggomitolati raggomitolati nel terriccio. Hano è scosso da un tremito, respira affannosamente come se gli mancasse l’aria. Katie invece non ansima, le labbra chiuse e lo sguardo duro. I minuti trascorrono lenti. Hano rivede in un flash back la scena di poco prima – un corpo che si abbatte su un pavimento, il sangue che schizza sui vestiti e i bagliori di fuoco -, ma ormai alla rabbia è subentrata l’angoscia. Gli stivali si muovono, i passi s’allontanano e il cupo silenzio è infranto dal rombo del motore di un’automobile. In un sussurro Katie dice: “Se ne sono andati”. Ha i capelli corti, un maglione blu e un paio di jeans la ragazza che adesso è in piedi. Hano indugia qualche istante poiché muoversi significa prendere una decisione. Poi: “Senti, Katie, torna indietro. Altrimenti sbattono dentro anche te quando ci beccano”. Lei lo guarda con occhi gelidi. Lui ripete la frase: “Vattene, ritorna a casa. Io non so cosa mi aspetta. E per te non posso fare niente”. Hano barcollando si allontana. Lei gli va dietro: “Da te non voglio niente. Fai come se non ci fossi”. Camminano per ore abituandosi all’oscurità. A volte perdono il senso dell’orientamento. Una macchina della polizia li supera e Hano sente la camicia fradicia di sudore. Oltrepassano campi disseminati di rottami, pneumatici accatastati, mucchi di immondizia. Si fermano agli incroci, incerti dove dirigersi. Percorrono vie deserte e sentieri tra i campi. Sfiorano edifici periferici e case malandate. Un cane abbaia. Un passo dopo l’altro si allontanano dalla città senza mai parlare. Ancora avanti sotto un cielo opaco. Seguendo una strada che costeggia villette dai muri scrostati, raggiungono un promontorio. Dietro si vede Dublino punteggiata di luci, davanti si estende il mare. Sulla spiaggia Katie lo guida verso un capanno dove avrebbe potuto ripararsi dal vento. Hano le domanda: “Come facevi a conoscere questo posto?”. E lei racconta delle sue scorribande notturne con gli amici a bordo di auto rubate che finivano sempre lì. “Che tu lo creda o no, tutti gli urli e il casino che facevamo si dissolvevano di colpo, come se fossimo arrivati alla fine di un viaggio. Guardavamo il mare. Almeno il mare non è di nessuno, non c’è nessuno che viene a mandarti via se non hai pagato l’affitto…”. Hano la interrompe: “Hai già passato la notte con qualcun altro qui?”. La risposta di Katie è sprezzante e insieme amara: “Che cosa te ne frega?”. Gli spiega che quel posto è pieno i fantasmi. I compagni di tante folli avventure sono finiti in prigione o in manicomio o in un ospedale consumati dall’Aids. Hano per la prima volta percepisce nella voce di Katie un grumo di disperazione. E per la prima volta si rende conto che quella bislacca ragazza unitasi a lui è diversa da come l’aveva vista a Dublino. Allora gli era antipatica, lo irritava. Gli sembrava identica “a tutte quelle ragazze che vedeva per strada ridere beffarde dei passanti, indifferenti alle giornate che sfilavano loro davanti, appestate dalla noia, specchio di un’adolescenza avvizzita”. In quella sedicenne dai capelli arruffati e le scarpe da tennis inzaccherate, Hano riconosce una parte di se stesso. Lungo e labirintico è l’itinerario di Hano e di Katie attraverso un’Irlanda povera, generosa e ribelle – destinata a scomparire come i boschi abbandonate e le nere torbiere – per trovare un rifugio e una speranza. Il loro è un vagabondaggio tra i ricordi che affiorano e sono ferite spirituali che acutizzano il dolore di due tristi ragazzi che si sentono traditi e orfani. E su di loro incombe un altro fantasma: quello di Shay, l’amico dei cuore di Hano e di cui Katie era stata segretamente innamorata, prima che fosse ucciso. ”Verso casa” (Fazi Editore) di Dermot Bolger è un romanzo forte e aspro, impregnato di un profondo malessere, di una lacerante inquietudine che si trasforma in un impeto di rivolta. La complessità dell’opera deriva dalla struttura narrativa non lineare ma ellittica, dalle diverse angolature con cui l’autore osserva la vicenda intrecciando senza interruzione il presente e il passato, e soprattutto per l’ampio ventaglio dei temi trattati. L’abilità di Dermot Bolger, commediografo oltreché narratore (nel 1917, a 18 anni, ha fondato la casa editrice Raven Arts Press dando un impulso decisivo allo sviluppo della nuova letteratura irlandese), è di riuscire a tenere unita una materia così densa. Ed è esemplare il modo attento e minuzioso con cui racconta, rappresentando in modo visivo non soltanto i personaggi e l’ambiente ma anche gli stati d’animo. Le parole diventano immagini malinconiche ma illuminate – nelle parti più efficaci del libro – di una luce poetica che rischiara un universo cupo e lacerato. Se il leit-motiv del romanzo di Dermot Bolger è la fuga di Hano e di Katie – come trasognati rivisitano i luoghi irriconoscibili della loro infanzia – via via affiorano i guasti interiori ed esistenziali, le fratture tra cattolici e protestanti, i contrasti tra la vecchia Irlanda delle ballate e la giovane Irlanda del rock, il caotico miscuglio tra differenti stili di vita, e la ricerca di un’identità sempre più difficile da rintracciare. Divisi tra contrastanti impulsi, l’animo fragile e nella testa tanti confusi pensieri, “i figli del Limbo”, come li definisce Bolger, si sentono esuli in patria. Se la casa è un’anima, loro l’hanno perduta. Hanno rifiutato l’esistenza stentata e faticosa delle loro famiglie d’origine contadina installandosi in monolocali periferici. Hanno fatto la coda di fronte agli sportelli degli uffici di collocamento per trovare un lavoro impiegatizio. Come Hano che riesce ad ottenere una scrivania nel Dipartimento elettorale e qui, la testa china su schede e fogli, fa la conoscenza con la noia di giornate sempre uguali e subisce le angherie del capo dei burocratici. In quello stanzone male illuminato, incontra Shay, allegro e loquace. Giocatore di biliardo, frequentatore di pub e di locali notturni, innamorato della sua vecchia Triumph Herald con cui scorazza per i quartieri di Dublino, agli occhi di Hano è un personaggio mitico. Ne imita i gesti, il modo di parlare e di camminare. E l’esuberante Shay si affeziona all’impacciato Hano, lo protegge fin quando lo invita a trasferirsi nel suo alloggio. Quella stagione però si rompe quando Shay improvvisamente, staccandosi dall’Irlanda nella quale non si riconosce più, decide di partire per l’Europa. Invano l’amico cerca di dissuaderlo: “Rimani, la tua casa è qui…” e lui: “La propria casa bisogna trovarla, non è quella dove si nasce. Neanche un pollo passa la vita accovacciato sui frammenti del proprio guscio…”. Continuando ad alternare episodi che escono dalla memoria a quelli che scorrono nel presente, Dermot Bolger dilata ancora il romanzo spingendolo verso vicende dal significato simbolico – non sempre convincenti – o verso situazioni politico-affaristiche. Ad esercitare il loro potere finanziario sono i fratelli Plunkett: Pascal, alto e massiccio, un “self made man” diventato proprietario di officine, imprese di pompe funebri, catene di negozi e società immobiliari; e Patrik, un politicante che sotto i modi eleganti ed affabili nasconde un animo cinico. Mentre ferve la campagna elettorale, Hano viene assunto come autista da Pascal Plunkett e conosce intrighi, maneggi e ricatti. È vittima di un brutale episodio che lo fa precipitare nello sconforto. Si ricorda che Shay l’aveva ammonito: “Guardati dai Plunkett…”. Dopo alcuni mesi riappare Shay. Hano lo trova in casa dentro un cappotto di lana scura, un cappello nero e un paio di anfibi ai piedi. Ha gli occhi stanchi e la barba lunga. Non è più lo stesso di prima. La sua euforia è falsa, recita una parte che non gli si addice come se volesse nascondere un segreto. Ripete: “Lo odio questo Paese, non so perché sono tornato…”. Qualche giorno dopo si contraddice: “E’ strano, vero? Non è necessario che un posto di piaccia per sentirne la mancanza. Guardati attorno. Dublino è ormai una città morta, e io mi trovavo dove dovrebbe pulsare il cuore del futuro. Non che ne sentissi la nostalgia , ma mi trascinavo dentro un senso di incompletezza. Come si fa ad andarsene da un posto se poi devi continuare a portartelo dentro?”. In quel periodo appare Katie: quasi ogni giorno è lì, si siede su una sedia e guarda con occhi imploranti Shay chiedendogli un po’ di tenerezza. Poi la tragedia. Una notte un giovinastro cerca di aprire la portiera della Triumph di Shay, dalla finestra Hano vede la scena e urla. Shay corre un strada. Pochi secondi e una Bmw guidata da Justin Plunkett, figlio dell’onorevole Patrick Plunkett e dedito al commercio di droga, lo investe e lo uccide, temendo che l’esule dall’Europa, diventato un corriere di “polvere bianca”, riveli il suo losco traffico. A vendicarlo è Hano. Convinto di trovare Justin entra nella villa di Pascal Plunkett che gli promette regali e quattrini se mentirà alla polizia dicendo che si è trattato di un incidente. Lo accarezza e lo abbraccia, il ragazzo però si divincola e con un coltello squarcia il corpo dell’affarista. Prima di scappare incendia la palazzina. Il finale del romanzo riporta in primo piano Hano e Katie in fuga. Ormai consapevole che la loro avventura è destinata a fallire, Hano si convince che “la propria casa si trova solo in se stessi” non accettando né patteggiamenti né compromessi con un mondo ostile. Al termine del nichilistico viaggio Dermot Bolger ha uno scatto anche stilistico. Il racconto diventa concitato, e lo scrittore mette in bocca ad Hano queste provocatorie parole: “‘I Ribbonmen’, gli uomini di Malcom Dwyer, i ‘Croppiers’, gli ‘Irregulars’ attaccavano di notte quelle che una volta erano state le loro case. Ogni secolo ha dato un nome a questi giovani ribelli. Quale nome sceglieranno in futuro per noi?”.
Violentissima terra d’Iralnda
Violentissima Irlanda nei due romanzi odierni, ambientati a Dublino e a Belfast, l’uno poco dopo l’ammissione dell’Eire nella Cee, l’altro negli Anni Settanta; degli autori, Dermot Bolger è nato nel 1959, e Eoin McNamee nel ‘61. Nel primo libro, più prolisso, la violenza è relativamente latente (i morti ammazzati sono solo due), in quanto nella torpida repubblica irlandese non ci sono altri conflitti che fra sfruttati e sfruttatori; nel secondo siamo invece in piena guerra civile, e ogni atrocità avviene quasi sotto gli occhi di tutti. Ma a questo punto ciascun libro ha diritto ad essere considerato in proprio. A “Verso casa” (trad. Lucia Olivieri) nessuno può negare scorrevolezza e eloquenza, patrimonio apparentemente genetico di qualsiasi irlandese si decida mai a mettere penna su carta; è anche narrativamente gestito con una certa aggiornata ricchezza di espedienti, alternando passato e presente, prima e terza persona, e inserendo in corsivo annotazioni attribuite a un personaggio diverso dal protagonista. Ma nel programmatico, deprimente squallore del mondo che descrive Bolger commette l’errore artistico di rendere colui per il quale dovremmo simpatizzare ancora meno attraente dei suoi nemici. Francis Hanoran detto Hano è un giovane poco più che ventenne, con madre vedova e molti fratellini. Nel “presente” lo seguiamo in una confusa e maldestra fuga mozzafiato per le campagne irlandesi, in compagnia di una ragazzetta, Cait, sua complice in un delitto per ora non specificato. Nelle rievocazioni del “passato” seguiamo la sua iniziazione al mondo del lavoro, iniziata con la conquista di un impiego provvisorio in un ufficio comunale. Qui Hano impara subito a vivacchiare facendo il meno possibile e spendendo la paga in bevande alcoliche, ma soprattutto cade sotto l’influenza di Shay, un coetaneo a differenza di lui estroverso, spregiudicato e brillante. Gli innocui scherzi che Shay escogita continuamente contro le autorità sono a lungo l’unica luce della vita di Hano, che per un pò divide un appartamento con l’amico. Poi però Shay desideroso di avventura parte per l’Europa ormai aperta a tutti, e avendo perso l’impiego Hano si rassegna a fare da inetto autista per Plunkett, un sorbido affarista contro il quale prima di morire suo padre lo aveva messo in guardia. I Plunkett, gente che si è fatta da sé, sono una dinastia di farabutti, uno è spregiudicato politicante, un altro, giovane, trafficante di droga. Hano odia il suo, il quale tratta tutti con disprezzo ma per lui ha una strana predilezione. UN giorno Plunkett getta la maschera e costringe Hano a ripungnanti atti di intimità sessuale, ma poi per farsi perdonare lo colma di favori e gli promette che non lo farà più. Intanto Shay torna umiliato e depresso da disavventure sul Continente, dove per caso incontrò lo stesso Punklett ed ebbe con lui una ripugnante esperienza più o meno analoga a quella di Hano… A questo punto però invece di raccontare il resto spiego la mia reazione davanti all’atteggiamento dello scrittore, purtrppo abbastanza tipico dell’Irlanda sordamente rivendicatrice di oggi, quello di eleggere qualcuno a responsabile dei propri guai e quindi di crogiolarsi nell’odio per costui invece di cercare di porvi rimedio. Plunkett, anzi i Plunkett, simbolo del potere cinico e egoista, sono il motivo per cui i bravi ragazzi come Hano e Shay devono restare poveri e subire ogni sorta di angheria. D’accordo, ma vogliamo anche guardare un pò questi ragazzi? Da come li descrive Bolger costoro non sono altro che degli inetti. Mentre l’esecrato Plunkett appare come un uomo oltre che attivo, tormentato e infelice, perché deviato e frustato negli effetti: una vittima anche lui, in definitiva, e grazie alla sua relativa complessità, la sola presenza vagamente notevole del romanzo. INsomma, evviva Franti, come disse Umberto Eco.(…)
Dermot Bolger
“Verso casa”, viaggio di formazione a tre, nella più misera Irlanda
Dermot Bolger, dublinese trentottenne, arriva in Italia ultimo tra i narratori irlandesi contemporanei ad essere tradotto (anche se all’appello manca ancora uno scrittore sensibile come Hugo Hamilton). Eppure, prima della esplosione di Roddy Doyle e delle sue accativanti saghe proletarie, Bolger è stato il narratore per eccellenza della nuova Dublino: meno rarefatto e cerebrale di John Banville, ma d’altra parte sicuramente meno facile di Doyle appunto e del giovane Joseph O’Connor. Bolger è stato animatore culturale oltre che romanziere (ricordiamo tra gli altri suoi romanzi Nightshift e The Woman’s Daughter), editore negli anni 80 con la casa editrice radical Raven Arts Press che ha lanciato giovani poeti e narratori, oltre ad aver pubblicato una importante antologia di poesia contemporanea in lingua gaelica (The Bright Wave, 1986). Essendo anche drammaturgo e poeta, Bolger si segnalava per la varietà e la ricchezza dei suoi interessi e della sua produzione. Fazi fa uscire ora, nella traduzione efficace e puntuale di Lucia Olivieri, The Journey Home (Verso casa), il più grande successo di Bolger, pubblicato nel 1990, libro coraggioso sulla Dublino più misera e squallida, e al tempo stesso singolare bildungsroman. The Journey Home, in apparenza quasi un road movie (secondo la definizione di Bolger) è una storia sulla bellezza o la violenza della giovinezza, male che notoriamente si cura da sé, col suo passare, ma che in questo caso viene interrotta, sospesa o spezzata nelle figure dei tre protagonisti – Shay, Hano e Shay – disegnando su uno sfondo di diffusa corruzione una vicenda complessa che conduce a un delitto, e poi a un altro omicidio, e infine a una disperata fuga che si snoda attraverso tutto il romanzo, interrotta da frequenti flash back e da intermezzi quasi lirici. Hano è bloccato in una non-vita ancora adolescenziale quando incontra Shay, in un ufficio elettorale in cui viene chiamato a prestare servizio saltuario. Per Hano, disoccupato cronico, il lavoro è l’occasione per fuggire da casa, diventare grande, assumendo gli atteggiamenti e la libertà interiore di Shay, e quasi innamorandosene. Ma anche la giovanissima e cupa Katie è presa dalla figura così libera, vicina eppure altera, di Shay. E nasce un conflitto che è un silenzioso e difficile ménage a tre. All’inquieto Shay però va stretta una Dublino pure ricca di notti e colori, e di emozioni anche estreme. Egli parte per il “continente”, come molti della sua generazione (e prima di loro i tanti sulle navi da bestiame) e torna cambiato, spento… A questo punto è Hano che è chiamato, dalla violenza degli eventi, ad essere se stesso, e non più a voler essere qualcun altro. La vicenda è avvincente, quando non ci si fermi a pensare che nel libro c’è forse troppo di tutto (droga, corruzione politica, degrado), e che una certa moderazione avrebbe forse giovato. Ma questo, come ha detto lo stesso Bolger in una intervista al manifesto qualche anno fa, “è il (suo) romanzo vittoriano, la (sua) opera alla Graham Greene del tipo settemila parole prima di colazione”, e anche un interessante tentativo di coniugare scrittura di qualità con generi altri, “che i critici generalmente disprezzano o sottovalutano”. Verso casa resta soprattutto la punta più alta di quello che è stato definito il realismo urbano di Dermot Bolger, la sua straordinaria capacità di descrivere una Dublino underground che certo sfugge al turista, e anche una Dublino di superficie, che resta comunque laterale rispetto ai circuiti più battuti, e vive tra le council houses dove ancora oggi le quindicenni si trascinano la carrozzina e i fratellini più piccoli. E bisogna dire a onore di Bolger che nella sua ansia di sperimentazione, in seguito egli si è notevolmente allontanato dal cliché del realismo urbano (come qualcuno ha definito le storie dei giovani dublinesi maschi che si drogano fuori dai pub), tentando altre strade, più pericolose ma per lui più stimolanti, testimoniate dal suo dramma “visionario” di qualche anno fa One Last White Horse. Insomma per leggere di una Irlanda non edulcorata, non simpatica né rarefatta, di una Irlanda che mostra un riflesso della sua “terribile bellezza”, questo romanzo di Bolger, intenso e coinvolgente, rappresenta una occasione a suo modo unica.
Libri dello stesso autore