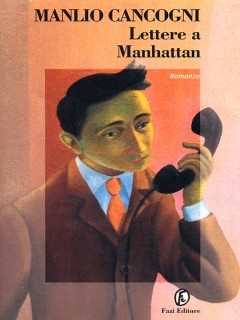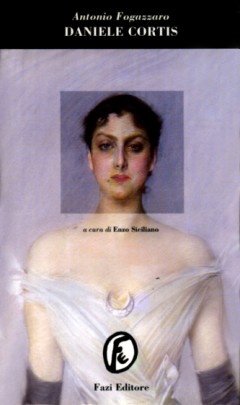Manlio Cancogni
Azorin e Mirò
A cura di Simone Caltabellota
Introduzione di Sandro Veronesi
Azorin e Mirò è la storia di un’incredibile amicizia tra due giovani scrittori spagnoli che, in realtà, sono Carlo Cassola (Mirò) e lo stesso Cancogni (Azorin). Ambientato in una Madrid che ha tutti i tratti della Roma fascista degli anni ’30, il libro dà voce a un sodalizio umano e letterario con toni quasi profetici perché contiene in germe il destino dei due scrittori e il senso di una generazione di fronte a se stessa. Apparso nel 1948 sulla rivista “Botteghe Oscure” di Giorgio Bassani, viene ora riproposto in una nuova edizione accompagnata da un racconto saggio di Sandro Veronesi. “Val più quel colore laggiù, quel reame, di tutte le passioni politiche degli uomini, di tutte le loro rivoluzioni e di tutte le loro sofferenze, esclamò Azorin convinto. E anche questa volta Mirò tacque, felice”.
– 12/06/2007
Cancogni, lezione di libertà
– 01/01/1997
Manlio Cancogni AZORIN E MIRO’
Girando per le strade della città nelle ore del chiaro mattino, quando la gente si reca al lavoro e dai bar esce odore buono di caffè e di “brioches”, può accadere di essere quasi assaliti all’improvviso da suoni o profumi e sensazioni, lo sferragliare di un tram, il vociare dei bimbi della scuola vicina che attraversano timorosi ed ancora assonnati la strada, il fumo delle auto, l’odore della benzina nei travasi dalla cisterna, sensazioni ed immagini che sembrano esistere in sé, fuori dal flusso del tempo e della vita, sinòpie della nostra coscienza improvvisamente libere dalle stratificazioni che i giorni e gli anni vi hanno sovrapposto. Così preceduta da pagine di una intervista di Sandro Veronesi a Cancogni (che non è una intervista, ma un racconto prima del racconto), con profumi apuani e sapori di pane schietto e di acqua limpida, ci ritorna tra la marea della produzione narrativa prenatalizia lo smilzo libretto della ristampa di un racconto apparso nel ’48 nella rivista di Bassani “Botteghe Oscure”, Azorin e Mirò di Manlio Cancogni “uno dei racconti più belli del Novecento italiano”, secondo Baldacci, storia di una amicizia e di una vocazione di due giovani che cercano se stessi ed il loro destino di scrittori, ma anche la felicità cui si agogna negli anni giovani, il legame profondo e vero che tiene uniti alla vita. Attraverso le strade e gli scorci panoramici di una Roma mai nominata, negli anni tra la fine del fascismo e l’inquieto dopoguerra si svolge l’avventura di questa duplice educazione intellettuale e sentimentale, l’apprendistato e l’esercizio scrittorio, i discorsi sui valori dell’arte, l’inserimento faticoso nella società letteraria, la pubblicazione delle prime cose, le polemiche, le incomprensioni, i contrasti, le gioie di ineffabili scoperte: una vicenda che adombra neppure troppo velatamente il rapporto reale in quegli anni tra Cancogni e Cassola, le illusioni e le delusioni, fino alla morte precoce di quest’ultimo. Quante battaglie ed asprezze intorno alla posizione “subliminare” di quella narrativa, alla sua presunta negazione della storia in anni di egemonia dell’impegno e funzione civile della letteratura! Sembrano cose di un tempo neppure lontano, rimosso. Eppure toccavano un nervo scoperto, l’eterna dialettica dell’essere e del divenire, l’aspirazione ad una assoluta purezza. Nei discorsi tra i due giovani si scorgono e certificano via via le scoperte di un valore reale senza pari racchiuso nelle cose, invisibile allo sguardo distratto ch’è immerso nel flusso del tempo, mentre esso si disvela in momenti miracolosi di una atemporalità incantata e fascinosa: un muro scrostato, uno scorcio di cielo, una voce subito spenta, un odore. Così Azorin poteva dire che “val più quel colore laggiù, quel reame, di tutte le passioni politiche degli uomini, di tutte le loro rivoluzioni e di tutte le loro sofferenze…”! Perfino nelle cose già fissate dall’arte o dalla tecnica sembrava possibile distinguere il “reale” e il posticcio. Cassola avrebbe dichiarato (ma già Azorin lo preannunzia) che “il fondamento della bellezza di un quadro, di una stampa, di una fotografia è l’immobilità del personaggio. Immobilità apparente piena di moto sostanziale. Perché il personaggio immobile ha tutte le possibilità di movimento intatte, cioè tutte le possibilità di vita intatte. La sua immobilità allude al movimento, la sua mancanza di vita alla vita, l’assenza del tempo al fluire del tempo.” I brevi racconti dei due scrittori intendevano fissare cose e persone ristrette in una loro solitudine, colte in un gesto o in un breve dialogo, sullo sfondo di un paesaggio, nella suggestione di un’ora, forme elementari della vita. Ma proprio la dimensione di quotidiano profilo apparentemente trascurabile doveva generare effetti di forte intensità, depurati com’erano da ogni valenza di contesto, in una “subliminarità” al riparo dalla suggestione straniante della storia grande o piccola, strutture e forme essenziali della vita, scaturite dalla luce di un flash improvviso, sospese fuori del tempo, come le bottiglie ed i cocci che con altrettanta assolutezza in quegli stessi anni dipingeva Morandi. Come poteva essere accolta una siffatta poetica dell’essenzialità “subliminare”, quando fu chiamata a misurarsi con le ragioni del nascente neorealismo e con quelle assai forti di una narrativa testimonianza e denuncia quale le tragedie della guerra e la miseria del dopoguerra sembravano reclamare? La storia degli svolgimenti di Mirò e di Azorin registra le tensioni e le amarezze che seguirono e sembra di avvertire anche una finale delusione, se non un ravvedimento. Quella che s’intravede di Cancogni e di Cassola, pur dissimili tra loro, ne costituisce la conferma. Ma oltre quelle asprezze e tensioni, la limpida scrittura del vecchio racconto riporta ad una dimensione innocente della vita e quasi, nella contemplazione di una semplicità miracolosa, ne attenua ogni dolore.
– 12/11/1996
MANLIO CANCOGNI, Azorin e Mirò, introduz. di Sandro Veronesi, Fazi, Roma 1996, pp. 116, Lit 20.000.
Torna, a cura di Simone Caltabellota e con introduzione di Sandro Veronesi, un testo divenuto raro ‘Azorin e Mirò’, infatti, non veniva pubblicato dal 1968. scritto durante la guerra, era apparso a Roma , sul primo numero della rivista “Botteghe oscure”, 198: racconto anomalo, nel momento del neorealismo, di un esordiente Cancogni, narratore e poi giornalista famoso. Azorin e Mirò, entrambi studenti e scrittori, a diciannove anni “si sentivano diversi da tutti gli altri”. S’incontrano e stringono un sodalizio, un’amicizia che ne protegge la preziosa diversità e la solitudine. Durerà fino alla vecchiaia, fino alla morte di Mirò e oltre. L’intreccio è semplice, scarse le peripezie della vicenda, che s’aggira invece a lungo sulla “realtà subliminare”, la sfera comune ai due amici di quotidiane emozioni e di scrittura. Le passeggiate, spesso in quartieri di periferia, in strade che riescono negli orti, in paesaggi tanto concreti quanto enigmatici, sono rivolte appunto alla ricerca del “sub limine”. La vita qual è sotto la soglia (della coscienza pratica, dirà Cassola); non il capire, ma il sentire; non le teorie, ma i tenui messaggi che emanano dalle cose. La poetica del subliminare ebbe poi in Cassola sviluppo e spiegazioni. Ma Cancogni ne trovò, prima, il nome. Cancogni e Cassola, in vesti di giovani scrittori spagnoli , sono rispettivamente Azorin e Mirò. Questo si sa, ma non dal racconto: che punta alla rappresentazione della vita vera, essenziale, e perciò esclude la cronaca e i discorsi troppo espliciti. Sandro Veronesi, il quale sente in Cancogni un proprio affine e in Cassola un maestro, ha scritto una bella introduzione-racconto. S’intitola ‘Una giornata con Manlio Cancogni’, ha per tema l’amicizia ed è anch’essa “sub limine”, ma alla nuova maniera del narratore-cronista, il quale accetta la sfida della vita senza nocciolo. Ecco dunque il racconto di una passeggiata, su per le Apuane, ricca di intime emozioni, ma con minuziosi dettagli e toponomastica, da Ponte Stazzemese e dall’hotel Dilani fino alla possente parete di Pania della croce. Avanti cammina e continua a parlare il vecchio Cancogni; dietro arranca il nostro Veronesi, simpatico personaggio che corregge la buona volontà con la giusta dose di inettitudine.
– 12/10/1996
La riedizione di “Azorin e Mirò”
L’amicizia tra Cancogni e Cassola nel romanzo del dopoguerra
Senza aver preso congedo dal locale circoletto di artisti e letterati di zio cui era a capo e ispiratore, Mirò, nelle prime ore del mattino di un giorno di marzo, scese dal suo paese alla più vicina stazione ferroviaria e prese il tremo che andava alla capitale”. Inizia così “Azorin e Mirò” di Manlio Cancogni, appena ristampato da Fazi. È uno dei romanzi brevi o racconti lunghi considerati tra i più belli del dopoguerra e frutto di una stagione felice, che dette anche, per citare non a caso, “Il taglio del bosco” di Carlo Cassola. Non a caso, perché i due giovani nascosti sotto i due nomi acuti e leggeri cui si intitola il libro, Azorin e Mirò, sono proprio, rispettivamente, lo stesso Cancogni e Cassola, e il tema è la loro amicizia intensa, acuta e leggera, e la loro educazione magica alla vita di artisti alla ricerca di se stessi e del proprio destino, rapiti con intelligenza e sentimento dalle novità del mondo in nome del desiderio e del problema della felicità. Sono pagine che Baldacci ha finito “documento di autocritica appassionata e spietata al tempo stesso” documento di autocritica appassionata e spietata al tempo stesso”, e Simone Caltabellotta, nella postfazione che correda questa nuova edizione, annota: “C’è, nella giovinezza di ogni uomo almeno una verità irrinunciabile cui tendere come l’unica possibilità di verifica dei propri anni, della propria ansia di possesso: conoscere il proprio posto nel mondo, raggiungerlo”. I due scrittori spagnoli del racconto di Cancogni, racconto controcorrente in anni di neorealismo imperante, tanto che a suo tempo trovò spazio per la pubblicazione solo in rivista, nella benemerita “Botteghe oscure” diretta da Giorgio Bassani, arrivano a definire una propria poetica, quella del sub-liminarismo. Era questo l’attendere e cogliere “i rari istanti in cui il tessuto opaco delle cose si rompeva, e dal suo grigiore compatto scaturiva bello, puro, inimitabile, il sub-limine”, l’emozione di un attimo in cui cogliere il senso dell’assoluto, felici. C’è in loro una sorta di onnipotenza che è la forza dell’incanto giovanile e poetico di queste pagine, ma anche l’inevitabile seme sbagliato da cui germoglierà il dolore esistenziale, la rottura del sogno, prigioniero del proprio passato, eppure sempre punto di forza cui tornare. Se in questo racconto è oggi facile riconoscere l’educazione sentimentale di tutta una generazione che istintivamente e guardano all’arte e a se stessa reagì alla retorica fascista, è anche possibile rileggerlo fuori del tempo e riconoscervi necessità contemporanee; un qualcosa che anche i giovani del “sabato sera” cercano e avrebbero bisogno di sapere come recuperare. E la letteratura maestra di vita, se non addirittura la letteratura come vita, secondo l’assunto di Bo, si rivela valore vero in epoca di crisi di valori.
– 01/01/1997
Manlio Cancogni
Azorin e Mirò
La storia dell’amicizia tra Azorin e Mirò, giovani scrittori sotto cui si nascondono Cancogni e Cassola nei loro anni di gioventù prima della guerra, Manlio Cancogni la scrisse a Firenze, nei mesi successivi all’8 settembre 1943, ma vide la luce solo nel 1948, sulla rivista “Botteghe oscure” di Giorgio Bassani. Definito il racconto più importante del dopoguerra (Baldacci) e uno dei più belli su Roma (Siciliano),’Azorin e Mirò’ fissa in maniera indelebile, ma non aliena da autocritica, l’avventura di una giovinezza dedita alla letteratura, ed insieme il manifesto di una poetica che si opponeva agli orientamenti culturali dominanti (il neorealismo e la letteratura impegnata). Introduzione di Sandro Veronesi e postfazione di Simone Caltabellota.
– 11/03/1996
A caccia di un’emozione. Ragazzo, segui il suo sogno.
“Senza aver preso congedo dal locale circoletto di artisti e letterati di cui era a capo e ispiratore, Mirò, nelle prime ore del mattino di un giorno di marzo, scese dal suo paese alla più vicina stazione ferroviaria e prese il treno che andava alla capitale”. Iniziava così “Azorin e Mirò” di Manlio Cancogni, appena ristampato da Fazi. È uno dei romanzi più brevi o racconti più lunghi considerati tra i più belli del dopoguerra e frutto di una stagione felice, che dette anche, per citare non a caso, “Il taglio del bosco” di Carlo Cassola. Non a caso, perché i due giovani nascosti sotto nomi acuti e leggeri cui si intitola il libro, Azorin e Mirò, sono proprio, rispettivamente, lo stesso Cancogni e Cassola, e tema è la loro amicizia intensa, acuta e leggera, e la loro educazione magica alla vita di artisti alla ricerca di se stessi e il proprio destino, rapiti con intelligenza e sentimento dalle novità del mondo in nome del desiderio e del problema della felicità. Sono pagine che Baldacci ha definito “documento di autocritica appassionata e spietata al tempo stesso”, e Simone Caltabellotta, nella postfazione che correda questa nuova edizione, anche nota: “C’è, nella giovinezza di ogni uomo almeno una verità irrinunciabile cui tendere come l’unica possibilità di verifica dei propri anni, della propria ansia di possesso: conoscere il proprio posto nel mondo, raggiungerlo”. I due scrittori spagnoli del racconto di Cancogni, racconto controcorrente in anni di neorealismo imperante, tanto che a suo tempo trovò spazio per la pubblicazione solo in rivista, nella benemerita “Botteghe oscure”, diretta da Giorgio Bassani, arrivano a definire una propria poetica, quella del sub-liminarismo. Era questo l’attendere e cogliere “I rari istanti in cui il tessuto opaco delle cose si rompeva, e dal suo grigiore compatto scaturiva bello, puro, inimitabile, il sub-limine”, l’emozione di un attimo in cui cogliere il senso dell’assoluto, felici. C’è in loro una sorta di onnipotenza che è la forza dell’incanto giovanile e poetico di queste pagine, ma anche l’inevitabile seme sbagliato da cui germoglierà il dolore esistenziale, la rottura del sogno, prigioniero del proprio passato, eppure sempre punto di forza cui tornare. Se in questo racconto è oggi facile riconoscere l’educazione sentimentale di tutta una generazione che istintivamente e guardando all’arte e a se stessa reagì alla retorica fascista, è anche possibile rileggerlo fuori del tempo e riconoscervi necessità contemporanee, un qualcosa che anche i giovani del “sabato sera” cercano e avrebbero bisogno di sapere come recuperare. E la letteratura maestra di vita, se non addirittura la letteratura come vita, secondo l’assunto di Bo, si rivela valore vero in epoca di crisi di valori.
Azorin e Mirò
“Senza aver preso congedo dal locale circoletto di artisti e letterati di cui era a capo e ispiratore, Mirò nelle prime ore del mattino di un giorno di marzo, scese dal suo paese alla più vicina stazione ferroviaria e prese il treno che andava alla capitale”. Inizia così Azorin e Mirò di Manlio Cancogni. È uno dei romanzi brevi o racconti lunghi considerati tra i più belli del dopoguerra e frutto di una stagione felice, che dette anche, per citare non a caso, ‘Il taglio del bosco’ di Carlo Cassola. Non a caso perché i due giovani nascosti sotto i due nome, Azorin e Mirò sono proprio lo stesso Cancogni e Cossola, e tema è la loro amicizia intensa, acuta e leggera, e la loro educazione magica alla vita di artisti alla ricerca di se stessi rapiti con intelligenza e sentimento dalle novità del mondo in nome del desiderio e del problema della felicità. I due scrittori spagnoli del racconto di Cancogni racconto controcorrente in anni di neorealismo imperante arrivano a definire una propria poetica quella del sub – liminarismo. Se in questo racconto è facile riconoscere l’educazione sentimentale di tutta una generazione che istintivamente e guardando all’arte e a se stessa reagì alla retorica fascista è anche possibile rileggerlo fuori del tempo e riconoscervi necessità contemporanee. E la letteratura come vita, si rivela valore vero in epoca di crisi di valori.
E con Cassola ridevamo di Marx
Riapparirà agiorni in libreria “Azorin e Mirò”, un vecchio romanzo breve di Manlio Cancogni. Un piccolo classico. Edito nel 1948, poi di rado ristampato conserva il dono di una scrittura semplice, nitidamente poetica. Ma non soltanto questo. La parabola sull’amicizia, raccontata in quelle pagine, racchiude una situazione vera. Azorin e Mirò corrisp. Gusti e disgusti letterari, e un comune modo di vedere la vita, unirono per un lungo tempo i due scrittori. il libro, dicevamo, uscì nel 1948. Ma Cancogni aveva cominciato a scriverlo nel novembre del ‘43, quando si nascondeva a Firenze dalle retate di fascisti e nazisti, lavorava per il Partito d’Azione e faceva con Romano Bilenchi un giornaletto clandestino intitolato Fronte della Gioventù. Cancogni aveva ventisette anni. L’amicizia trasfigurata nelle pagine di quel racconto, benché solidissima, era agli inizi. Durerà ancora quarant’anni, anche se a un certo punto il destino della coppia si biforcherà. Senza abbandonare la letteratura, Cancogni diventerà un giornalista eminente e versatile, condotto dal suo lavoro a viaggiare e stabilirsi per anni all’estero. Cassola, partito da Roma per sposarsi, vivrà sempre nella provincia toscana coltivando quella sua vena narrativa amara e solitaria, legata quasi polemicamente a una quotidianità senza fronzoli, che gli darà la fama. L’incontro fra le loro due vite resta comunque fissato in questo Azorin e Mirò (edito ora da Fazi, pagg. 124, lire 20.000, a cura di Simone Caltabellota, introduzione molto bella di Sandro Veronesi), con tutte le aggiunte e sottrazioni che la fantasia di Cancogni volle apportarvi. E con almeno un dato profetico: verso la fine del racconto, Azorin-Cancogni assiste alla morte dell’amico. Ripercorrere quelle pagine in compagnia dello scrittore, oggi ottantenne, è un gioco che soddisfa più d’una curiosità. A cominciare dai nomi assegnati ai due personaggi. Cancogni è abituato a simili artifici. Si chiamava Cicicov, alla Gogol, il protagonista della sua inchiesta giornalistica più famosa, quella sullo scandalo romano dell’Immobiliare, pubblicata dall’Espresso nel 1955. Ma perché mezzo secolo fa, lui e Cassola diventarono Azorin e Mirò? “Durante quella parentesi di guerra a Firenze”, risponde Cancogni, “studiavo letteratura spagnola. Aspettando gli inglesi, mi sentivo molto spagnolo. Gabriel Mirò e Azorin sono infatti due scrittori spagnoli, fra Ottocento e Novecento. Molto diversi. Mirò – ne guardavo la fotografia nei suoi libri – era malinconico, scuro, profondo, raccolto in sé. Azorin (pseudonimo di Josè Martinez Ruiz), estroverso, brillante, letterariamente prolifico. Mi sembrava che quei due ci somigliassero. Carlo era sempre convinto di ciò che pensava e sentiva, di ogni istituzione faceva un assoluto. Io ero più incline ai dubbi. Anche se la pensavamo allo stesso modo. La politica ci coinvolse, insieme, nel 1938-39, accanto ai piccoli gruppi di aderenti a Giustizia e Libertà o al liberalsocialismo: i nostri amici erano Mario Alicata e Antonello Trombadori, che poi sarebbero entrati nel Pci. In seguito, la milizia partigiana di Carlo fu più decisa della mia. A dimostrazione che lui prendeva tutto sul serio: sia l’impegno, sia, poi, il disimpegno. Lui entrò nelle bande, andò in montagna”. Ma torniamo alla coppia formata da questi due aspiranti scrittori dai nomi spagnoli, nella Roma degli anni Trenta. UNa coppia un pò mitologica, benché odiatrice dei miti. La complicità che univa Cancogni e Cassola era un’intuizione raffinata, sofisticata e un pò difficile a spiegarsi. Lo chiamavano il “sublimine”. L’aggettivo “subliminare” designava tutto ciò che di positivo e suggestivo esistesse al mondo. Il resto andava trascurato, disprezzato, deriso. Insomma, Cancogni, che cos’era mai questo sublime? “Una sorta di rivelazione. La realtà che si rivela in un attimo. L’esistente che ti balza incontro nella sua immediatezza. Per noi la verità non era una creazione umana, am qualcosa che si manifesta inaspettata, all’improvviso. Ancora oggi quel punto di partenza mi sembra seducente, am guai a restargli attaccati. Eravamo anti-idealisti, anti-marxisti, anti-storicisti. Non sopportavamo le ideologie. I nostri amici erano tutti intrisi di Croce e Gentile. Si arrovellavano intorno a MArx. Noi ci ridevamo sopra, un pò fanciullescamente. Non è l’infanzia un’età antistorica, metafisica, che riceve intuitivamente i messaggi del sublime? A nostra insaputa, Joyce aveva definito tutto questo l’epifania. Il filosofo che, a ripensarci oggi, poteva presentare qualche somiglianza con quella nostra infatuazione era Bergson. E anche un pò gli esistenzialisti, che l’editore Bocca in quegli anni andava pubblicando in esili volumetti: da Kierkegaard in giù”. Il massimo subliminare, in letteratura, era Joyce. Ma soltanto quello dei Dubliners e di Dedalus. “L’Ulisse io lo lessi nella traduzione francese di Valery Larbaud e poi, con l’aiuto di un amico, in inglese. Mi sforzavo di farmelo piacere, ma invano”. Subliminari erano facce, situazioni, luoghi. Azorin e Mirò ribattezzarono “la vecchia Dublino” quella fila di stradine romane che vanno da via del Corso a piazza di Spagna. Dublino, vecchia per giunta, era il massimo del subliminare. “Attenzione, però”, specifica Cancogni, “fino a piazza di Spagna esclusa. Era un luogo troppo storico. E la storicità significava per noi il negativo assoluto”. Il “grande belvedere” dal quale Azorin e Mirò si affacciavano su Roma era Monte Mario. “Lì Carlo e io girammo un film a passo ridotto, che venne proiettato a Napoli durante i Littorali del ‘37. S’intitolava “La periferia”. Sulla carta geografica, il subliminare comprendeva pezzi del mondo anglosassone: l’Inghilterra, l’Irlanda, il Canda, l’Australia. “Non ci guidavano criteri politici, nella ,ostra scelta non entrava l’ammirazione per la Camera dei Comuni, l’habeas corpus e così via. Era un modo d’istinto, di gusto. Del mondo, d’altronde, non sapevamo nulla”. E le preferenze, in materia di letteratura italiana? Azorin e Mirò inventarono uno scrittore per il quale professavano un’ammirazione incetenibile: Giorgio Sinico. “Era il nomignolo che davamo a James Joyce. In un suo racconto c’è una signora Sinico. E un Sinico è ricordato nell’Ulisse; Gli scrittori italiani li odiavamo un pò tutti, per un loro presunto peccato di magniloquenza. Io, che oggi vivo con Dante accanto, mi riconoscevo allora soltanto in qualche suo verso. Come apprezzavo certi momenti dei Promessi Sposi e qualche frammento degli Idilli leopardiani: il che può farmi oggi pensare che eravamo crociani senza saperlo”. Quando Cassola morì, i due amici non si vedevano più da anni, per via d’un dissenso ideologico. Cassola era ossessionato dall’incubo atomico, con la sua nativa intransigenza predicava il “disarmo unilaterale”. Cancogni non era d’accordo. L’antico tandem Azorin-Mirò si scioglieva per desuetudine. Cancogni aveva letto in dattiloscritto tutti i libri dell’amico. Ora li ricorda ammirato, con qualche preferenza per i racconti giovanili della “Visita” e di “Alla periferia” e poi per quelli del “Taglio del bosco”. Fra i romanzi, trova bellissimo “Un cuore arido”. “Ferrovia locale” gli sembra un’opera di vera avanguardia. E il più celebre di tutti “La ragazza di Bube”? “Non è il mio preferito. Dopo il successo, anche Carlo sembrò disaffezionarsi a quel libro. Poi gli ripiacque. E’ un’opra priva di difetti. Ma forse, le imperfezioni sono un coefficente del romanzo, che nel suo corso deve trascinarsi dietro un pò di zavorra. Senza zavorra non c’è narrativa”. I rapporti tra Azorin e Mirò e il suo autore sono singolari. Complicati. “Non riesco a rileggerlo”, confessa Cancogni. “Mi dispiacerebbe che non mi piacesse più. Non ho avuto il coraggio di correggerne le bozze. Ho provato. Ho scorso le prima tre pagine, ho cambiato un aggettivo, e ho lasciato tutto lì. Rileggerlo tutto, quel racconto, significherebbe riscriverlo: e dopo cinquant’anni sarebbe una disonestà. Meglio lasciarlo così, con le ingenuità di una volta. Per vedere se ancora hanno un senso”.
Note su “Azorin e Mirò”
Cancogni e Cassola maestri di stile
Simone Caltabellota, nella postfazione alla ristampa di Azorin e Mirò di Manlio Cancogni (Fazi editore) corredata da un’ariosa introduzione tutta da artista, di Sandro Veronesi, mi richiama alla responsabilità di aver definito questo racconto lungo “il più importante del dopoguerra…qualcosa di unico”. Il mio primo incontro con Azorin e Mirò risale al ‘58, quando Bassani, che l’aveva accolto in “Botteghe Oscure” dieci anni prima, lo ripubblicò nella Biblioteca di Letteratura di Feltrinelli (con altri due pezzi e sotto il titolo complessivo Cos’è l’amicizia): un incontro che lasciò il segno, se in quelle pagine trovai la risposta al disagio che, in un clima di rarefatta purezza, aveva accompagnato la mia formazione fiorentina. Ero di fronte a un saggio di autocritica appassionata, che mi sollecitava a veder chiaro anche dentro me stesso. Confermiamo oggi i giudizi di ieri; pur insistendo a dire che, mentre Caltabellota propende a rilevare in questo romanzo – da riportare, nella sua redazione di base, al momento più buio del conflitto – la testimonianza di una giovinezza incandescente, noi abbiamo soprattutto sentito nella vicenda dei due protagonisti – gli spagnoli Azorin e Mirò, maestri di stile, nati tra il 1870 e l’ 80, che rappresentano rispettivamente Cancogni medesimo e Carlo Cassola – una dichiarazione di pentimento: condanna di ogni splendida fuga e di ogni torre d’avorio, e insieme rinuncia a quelle esperienze d’esistenza condensata traducibili in stati d’intermittenza, epifanie, forme rivelate del sublime; che per i nostri era diventato il subliminare, parola non registrata dai vocabolari (subliminale sì), ma il cui concetto, anzichè in termini etimologici (“significa…sotto la soglia della coscienza pratica”, dirà Cassola), può esser meglio illustrato da qualche esempio: “Mirò aveva il sub-limine della sera estiva, quando un riflesso di luce rimane a lungo nell’aria oscura…Azorin aveva il sub-limine di certi mattini invernali quando la luce viene fuori a fatica ma sicura dalla nebbia, i vetri sono appannati, secchi i rami del giardino in basso, e nella cucina nitida e pulita il latte bolle sopra il fornello”. Così aveva scritto la storia di una donna frustrata e di un fratello mascalzone, ma solo per arrivare “a quella luce mattinale, per quel frammento di sub-limine”. E infatti anche Azorin e Mirò sono condannati a inseguire il mito dell’essenzialità che aveva attraversato il Novecento dal futurismo in poi, quando Papini proclamava che dalla Divina commedia sarebbero sopravvissuti al massimo duecento versi. Procedono pertanto a “un esame degli autori più famosi” e ne risulta che “di questo si salvava un racconto, alcune pagine; di un altro i primi versi di una poesia, qualche verso qua e là. Di un romanzo di fama universale…due descrizioni di paesaggio”. ll vetero-crocianesimo si associa inconsapevomente all’orfismo, con in più la certezza che quel mondo d’ineffabili vertici sia la vita, essendo la vita magari fatta di niente, ma non mai di dramma, di passione, di idee politiche. I due amici consumano la loro orgia di separatezza immersi nella “vecchia Dublino”, che poi é un groviglio di vicoli della vecchia Roma, e i Dublinesi di Joyce sono il loro testo sacro; ma, diciamo per intossicazione letteraria (siamo alla fine della dittatura fascista), Azorin finisce in carcere: senza rendersenen conto e tuttavia con un forte sentimento di colpa. Siano consentiti allora tutti gli impulsi intimi della commozione nel rievocare una stagione trascorsa (anche se rievocazione vera non é, considerando che Cancogni non aveva ancora trent’anni), ma non possiamo rigettare il sospetto che aleggi sul fondo elegiaco il modello di Bouvard et Pecuchet col suo eroismo in negativo. Con ciò ci riallacciamo al nostro discorso sulla valenza autocritica del romanzo, nel quale il curatore, sebbene ne ammetta il carattere di ripensamento su “un’educazione sbagliata”, indica “il manifesto di una poetica, il sub-liminarismo, che Cancogni e Cassola opponevano agli orientamenti dominanti (neorealismo, letteratura, enfgagée)”. Cancogni non è così contraddittorio. Quell’esperienza, in quel momento, era per lui esaurita e pertanto non é lecito parlare di manifesto; né tantomeno il sub-limine, accettando che la prima stesura risalga alla fine del ‘43, poteva avere per bersaglio il neorealismo. Se poi si vuol dire che Cassola, e lo stesso Cancogni, si sono, anche in seguito, giovati di tale ottica nei suoi elementi comuni a tutta la scrittura moderna, ciò non toglie che l’autore di Azorin e Mirò abbia allora fatto il processo e non l’esaltazione di quel tempo di astratti furori. Caltabellota c’informa, quasi a sostegno del proprio punto di vista, che, al suo apparire, il racconto fu attaccato da alcuni recensori “per la sua poetica disimpegnata”. Sarebbe stato opportuno rendere palesi i nomi e le motivazioni di questi stroncatori che occhiutamente videro un invito alla bella astrazione in un pamphlet il cui senso è tutto di segno contrario. Forse era colpa del clima politico se ogni intenzione critica – fosse pure sottoforma do dolorosa confessione – veniva messa al bando e c’era posto soltanto per le dichiarazioni unanimi e positive. Ma oggi? Bisognerebbe credere ad un doppio registro della narrazione; denunciare e riproporre le medesime cose.
Soli contro il tempo
Cancogni e Cassola nella seconda metà degli anni trenta, elaborano la poetica del “sub-liminare”, che sembra avere qualche tratto in comune con la recente corrente minimalista; ma la somiglianza é solo alla lontana, perché il “sub-liminare” è soprattutto un problema di tono, di registro, uno strumento che tende a cogliere e rappresentare non il minimo vitale o la vitalità delle cose minime e secondarie, ma al contrario il massimo di vitalità, cioé proprio la vita nella sua essenza. Che poi questa si celi ai più rivelandosi in qualche momento è un problema pertinente alla metafisica ( laica, però) di questa poetica. Più tardi Cassola preciserà ulteriormente a se stesso la poetica della verità degli oggetti come risultato di un contrasto fra la vita e l’esistenza; l’amore che non diventa famiglia e quindi non sancisce la propria fine in nome dei figli, é la condizione felice dell’umanità. E ancora: la vita é la regola che governa il consorzio umano, con le sue finzioni e le sue aggregazioni castratorie e punitive nei confronti dell’individuo; la storia contrasta la biologia e, col tempo, la vince. Il tempo é il grande protagonista della sconfitta della vita. La poetica del sub-liminare era una delle forme moderne di contestazione dell’inautenticità del moderno. Era una poetica intrinsecamente antifascista, ma anche anticomunista, incompatibile con ogni programma politico che non fosse quello vagheggiato da Cassola ormai in età avanzata. Poetica tipicamente anni trenta ( o anche consona col primo ventennio del secolo), era già poco plausibile quando Cancogni iniziò il suo racconto (in Firenze occupata dai tedeschi, quindi nell’autunno del ‘43; e quando lo terminò?) e ancor meno nell’immediato dopoguerra. Avrebbe potuto essere interessante avere dalla postfazione di Simone Caltabellota – molto impegnato a stringere in poche pagine dei nessi fra i non pochi testi di Cancogni – delle informazioni più precise circa l’accoglienza di Azorin e Mirò. Qualche esempio di lettura ostile sarebbe stato istruttivo; così come anche qualche altro di correzioni subite dal testo. Il quale é uscito tre volte a a scadenza decennale. Da una collazione che ho limitato ai primi tre capitoli del racconto, con qualche incursione rapsodica anche oltre, mi sono reso conto che una revisione massiccia fu operatat nel passaggio dalla redazione in rivista alla prima in volume, non sempre nel senso di prosciugare il testo, ma anche in quello di sciogliere le oscurità, eliminare le incongruenze e le durezze, integrare i particolari. Ad apertura del libro, nel secondo capitolo, quando Mirò ha trovato casa, si leggeva nell’edizione del ‘48: “ Popolare il quartiere, modesta la casa, sciatta la padrona che venne ad aprirgli./ La camera lasciava molto a desiderare. Un letto di ferro altissimo (…)”. Nella prima edizione in volume Cancogni toglie il generico “La camera lascia molto a desiderare” perché fa subito la descrizione di questo interno. Nell’edizione del 1968 inserisce, dopo “modesta casa”, il segmento “buie e maleodoranti le scale che portavano al quinto piano”, con evidente intenzione di informare sul degrado dell’ambiente.Da ciò risulta evidente che, anche sul passaggio dalla seconda alla terza edizione, ci furono interventi correttori, pur se meno rilevanti di quelli fatti per l’edizione del ‘58. Questo per quanto riguarda la lettura autobiografica del testo, il quale però corre per conto suo come un grande racconto letterario in cui l’autobiografia finisce per non esserci più, tant’é che quando lo scrisse Cancogni aveva ventisette anni, mentre i due protagonisti sono visti invecchiare e morire, con una cattiveria che supera quella di Flaubert. Tutta la vita di questi due fanatici della vita vera – quella nascosta, semplice autentica ecc. – trascorre in attesa: Mirò obbedisce alle leggi del tempo che gli impone la fedeltà amorosa, la costituzione della famiglia, la vita in provincia, un lavoro di routine. Si comporta come l’islandese leopardiano pur facendo tutto il contrario: accettare e non fuggire. Azorin vive fuori dal sub-limine: viaggia, fa, cambia ambiente, parla e scrive molto, incontra gente; e inoltre si interessa di politica, che entrambi detestavano come una forma di inganno dell’autenticità. Ma se tira un bilancio, tutto si riduce a ben poco, o a nulla. Azorin e Mirò é un grande libro perché a distanza di quasi cinquant’anni dalla sua stesura regge perfettamente. Era allora un racconto anticonformista, cioé contro il proprio tempo (ma quale cosa bella non ha questo connotato?) e del pari era il testo di un autore che, scrivendolo, smentiva a se stesso: cospiratore azionista, sembrava rifiutare nella vita l’idea dell’inutilità di ogni politica, idea in cui invece aveva creduto come teorico del “sub-liminare”; oppure continuava a mantenervisi fedele solo perché é necessario credere ai sogni e alla necessità dei progetti. E’ un racconto moderno, in cui si accetta la contraddizione fino alla fine; anzi, i due protagonisti devono morire perché sia dichiarata l’eternità della contraddizione; che qui si chiama Tempo.
Azorin e Mirò
Ritratto degli artisti da giovani, e poi da adulti, fino alla vecchiaia e alla morte. Azorin e Mirò sono due scrittori alle prime armi. Si conoscono assistendo alle prove di una filodrammatica, capitati lì per caso e chiamati dal regista a dare una mano facendo una comparsata nei panni di due fraticelli. Le amicizie più salde non nascono quasi mai , almeno in prima battuta, dagli amori condivisi. Un comune nemico serve meglio allo scopo. E infatti entrambi detestano il teatro, così pieno ai loro occhi di enfasi, di falsità: poche frasi bastano per riconoscersi e avviare una lunga consuetudine di incontri e di chiacchere, nei caffè e per le vie della città, con in tasca le pagine nuove di zecca da leggere all’amico. Pubblicato nel ‘48 sulla rivista “Botteghe Oscure” ( nello stesso numero che ospitava “L’anguilla” di Eugenio Montale). “Azorin e Mirò” è per la prima parte un racconto a chiave, che cela sotto gli pseudonimi spagnoleschi l’amicizia dell’autore con Carlo Cassola. Ma per l’altra metà, è ovviamente un racconto di pura fantasia: quando lo scrive, Cancogni-Azorin ha appena qualche anno più dei suoi personaggi, e il suo destino di screittore “fuori dal comune” é lontano dall’essere tracciato. A vent’anni, è difficile resistere alla tentazione di smontare il mondo per poi rimontarlo a propria immagine e somiglianza. “Mi piace, non mi piace” ( con riferimento ai libri, alle persone) é la frase chiave del racconto, da collocare senz’altro tra le storie di formazione. Di speciale, c’è il fatto che parla di una formazione “a due”, mentre gli scrittori, di solito, o viaggiano solitari o si muovono in schiere più numerose, scegliendo di riunirsi in gruppo. La sensibilità, l’atteggiamento verso il mondo che Azorin e Mirò coltivano fin dai primi incontri ha un nome preciso: si chiama sub-liminare e, anche se il termine non é troppo invitante, ha qualche parentela con le epifanie joyciane. Il sub-limine si definisce, come tutte le cose davvero importanti, per esclusione. E’ quel che rimane dopo aver tolto di mezzo la retorica, i gesti e le parole esemplari, ma anche le grandi passioni ormai incanalate dentro schemi fissi, e soprattutto la coscienza che riflette e giudica. E’ una visione improvvisa, un colore, una screpolatura nel muro, la cresta di una collina. E’ uno stato di grazia, e quando all’improvviso si manifesta, i sensi paiono all’opera per la prima volta: invece di testimomiare la semplice esistenza delle cose ne rivelano l’essenza segreta. Nell’Italia del dopoguerra, infiammata da scontri ideologici che dal terreno politico scivolavano volentieri in quello della letteratura, una simile dichiarazione di poetica non poteva che procurare all’autore qualche nemico giurato. E lo stesso discorso vale per l’altro tema del libro, che ha a che fare con il sentimento privatissimo della felicità. Il lavoro, le amicizie, i giorni che passano, gli amori letterari e quelli per le donne sono altrettante tappe di un percorso che Cancogni, fedele alla sua poetica sub-liminare, disegna con piccoli tratti leggeri, sfidando il luogo comune secondo cui solo l’infelicità é davvero degna di occupare le pagine di un romanzo. Nelle pagine finali, il libro si fa più cupo, senza però rimpianti né nostalgie. I giorni dell’apprendistato sono ormai lontani, ma l’amicizia rimane, alimentata dal comune sentimento di appartenere a una generazione che agli scrittori e ai critici più giovani appare- nonostante il pochissimo tempo trascorso- remota e priva di interesse. Ma le vie della letteratura sono più tortuose e imprevedibili di quel che vorrebbero i manuali. Come mostra, in apertura del volumetto, l’introduzione di Sandro Veronesi, che racconta di aver dedicato un suo romanzo giovanile (mai pubblicato) proprio ai temi di “Azorin e Mirò”. Senza peraltro aver letto il racconto di Cancogni, scoperto e amato soltanto qualche anno più tardi.
– 11/10/1996
Riproposto l’interessante primo romanzo di Manlio Cancogni, scritto nel lontano 1948
Niente può intaccare questa amicizia
Azorin e Mirò: un rapporto all’insegna del sentire comune e dell’amore per la letteratura
Ritorna Azorin e Mirò, il breve romanzo che in pratica ha segnato l’esordio narrativo di Manlio Cancogni. Ritorna da Fazi, con una introduzione di Sandro Veronesi e una postfazione di Simone Caltabellota. Così, in genere, si curano i classici. E infatti Azorin e Mirò è un piccolo classico, uscito miracolosamente dalla congerie delle narrazioni neorealistiche, nel 1948. Perché “miracolosamente”? Perché intorno a quegli anni non c’era opera narrativa che non fosse “impegnata” a dare conto della guerra appena finita. Non abbiamo nulla contro la letteratura neorealistica, che aveva un’intima e urgente necessità di testimoniare lo sfacelo etico e fisico dall’Italia. Ma non si può tacere che la più parte di quelle narrazioni era stilisticamente poco agguerrita, e questo difetto finiva per rendere inerti anche i messaggi più alti. E tuttavia, non si può dimenticare che dall’esperienza neorealistica sono usciti scrittori di grande dignità come Bassani e Cassola (sbeffeggiati entrambi dall’intollerante neoavanguardia, Eco in testa). A proposito di Cassola, Azorin e Mirò é la storia dell’amicizia sentimentale e lettararia fra Cancogni e Cassola, nata negli anni Trenta e protrattasi nel tempo. Ma Azorin e Mirò non é un libro autobiografico, in questo caso avrebbe solo un valore di documento e non ce ne saremmo occupati. L’amicizia, quella di fatto, c’é, ma ciò che conta é la resa artistica della pagina. E allora salta subito agli occhi l’originale anomalia di questo romanzo, che invece di racconrtare la politica, la guerra e il dopoguerra (come si faceva allora), racconta i sentimenti ombrosi, quasi crepuscolari, di due individui, Azorin e Mirò, entrambi con la passione della letteratura. Mirò é Cassola, Azorin é Cancogni. Azorin e Mirò si incontrano a Roma. Sono entrambi studenti e amano frequentare i luoghi più defilati della capitale. La loro amicizia é fatta di silenzi, più che di parole. Ma sono in sintonia su tutto. Si leggono vicendevolmente i loro racconti. Tutto quello che accade di grosso nella città (il fascismo, la illibertà ecc.) non li tocca. Vivono a un livello superiore, quasi astrale. A tratti visitano le redazioni di piccoli giornali letterari, a cui collaborano. Ma i due desiderano soprattutto vivere appartati e silenziosi, godendo di emozioni ineffabili suscitate da un tramonto, uno spigolo di casa, una finestra illuminata nella notte, una voce che canta lontano. Questo modo di vivere e di provare emozioni, Azorin lo definisce “sub-liminare”, fatto cioé di sensazioni fuggevoli e intense, che non arrivano alla coscienza ma che valgono più di tutte le ideologie sparse sulla Terra. Un giorno Mirò si innammora, si sposa e va a vivere in campagna. Non scrive più. ha trovato il sub-limine nella vita domestica. Azorin invece si lascia travolgere dalla politica, viene imprigionato e sconta sei mesi di carcere. L’amicizia tra Azorin e Mirò sembra finita. Ma una tragedia riavvicina i due amici. Muore la moglie amatissima di Mirò e lui ritorna a Roma, riprende a frequentare i circoli letterari e Azorin. Riprende a scrivere. Qui c’é come una violenta accelerazione del tempo. I due amici invecchiano, Mirò muore e Azorin vive nel ricordo ineffabile dell’amico. La vera felicità è nel passato, come nella narrativa di Flaubert, alla quale tanto somiglia il libro di Cancogni. E lo diciamo con ammirazione. Un breve poscritto. Abbiamo letto attentamente la postfazione di Caltabellota ma non l’abbiamo capita: peccato.
– 01/02/1997
Piccoli classici
Azorin e Mirò, amici in solitudine
“Azorin e Mirò” fu pubblicato per la prima volta nel 1948 sulla rivista Botteghe Oscure, e segnò l’esordio narrativo di Manlio Cancogni, oggi ottantenne. La cura di questa riedizione è di Simone Caltabellota, che con passione annuncia due inediti dello scrittore di Fiumetto, che lo stesso editore Fazi darà alle stampe prossimamente. Azorin e Mirò è un racconto che per novanta pagine esatte narra la storia di un’amicizia, da prima che cominci (quando Mirò è ancora solo, senza Azorin) a dopo che è finita (quando Azorin è ormai solo, senza più Mirò); e lo fa partendo da un punto e arrivando all’altro come un intercity senza fermate che parte in orario e arriva in orario: senza indugiare in psicologismi, descrizioni, approfondimenti, disgressioni, presenza di altri personaggi che possano inserirsi per davvero nella “trama”, e quant’altro. Tutto quel che serve alla storia di questa amicizia viene raccontato con frasi essenziali, che servono perché modificheranno il rapporto tra i due protagonisti; il resto è sfocato o inesistente. La storia di Azorin e Mirò è fatta di silenzi, esclusività e antimonumentalità; e di più: è questa la loro filosofia, quella specie di gioco che è il sub-limine, termine che Sandro Veronesi, nell’appassionata introduzione, spiega: “una vera e propria poetica, quell’immenso serbatoio di cose indefinibili ma ugualmente percettibili che tiene insieme la formidabile amicizia di Azorin e Mirò”. Nonostante soffrissero “della normale non-subliminarietà delle cose”, essi sapevano che il sub-limine poteva essere dovunque, e ogni volta diverso: se Mirò lo sentiva in certe strade di periferia, ad Azorin capitava di sentirlo nelle vie centrali della città dove si erano incontrati e dove ora vivevano. Perché se pure nella finzione i due nomi sono spagnoli, la storia non soltanto è italianissima e vera – perché più che ispirata alla reale amicizia di Cancogni-Azorin con Cassola-Mirò – ma si svolge nella capitale e descrive (senza soffermarsi) luoghi come la Fontana di Trevi e Piazza di Spagna. Roma, insomma. E fin dall’inizio c’è l’odore delle stanze in affitto della Roma vecchia, come le sentiva chi vi giungeva dalla provincia. Così Mirò arriva a Roma, la sua stanza è triste, ma scrive, passeggia e pensa alla fidanzata. “Non sentiva il bisogno di avere amici”. Come Azorin, del resto. Infatti il loro è l’incontro tra due solitudini perfette, e l’iniziazione lenta all’amicizia è davvero straordinaria, e queste solitudini diventeranno unite, tanto da sfociare in una sola solitudine contro il resto del mondo – eppure i due conserveranno a lungo il loro pudore, che farà in modo di non farli mai inciampare in un abbraccio se non in tarda età, di non prendere appuntamenti pur vedendosi sempre, di non parlare del fidanzamento di Mirò fino al giorno in cui lui parte per andarsi a sposare. Così, è la passione per la scrittura – l’unico oggetto di confronto tra loro – che convoglia tutto il resto.
Libri dello stesso autore


Matelda
Manlio Cancogni