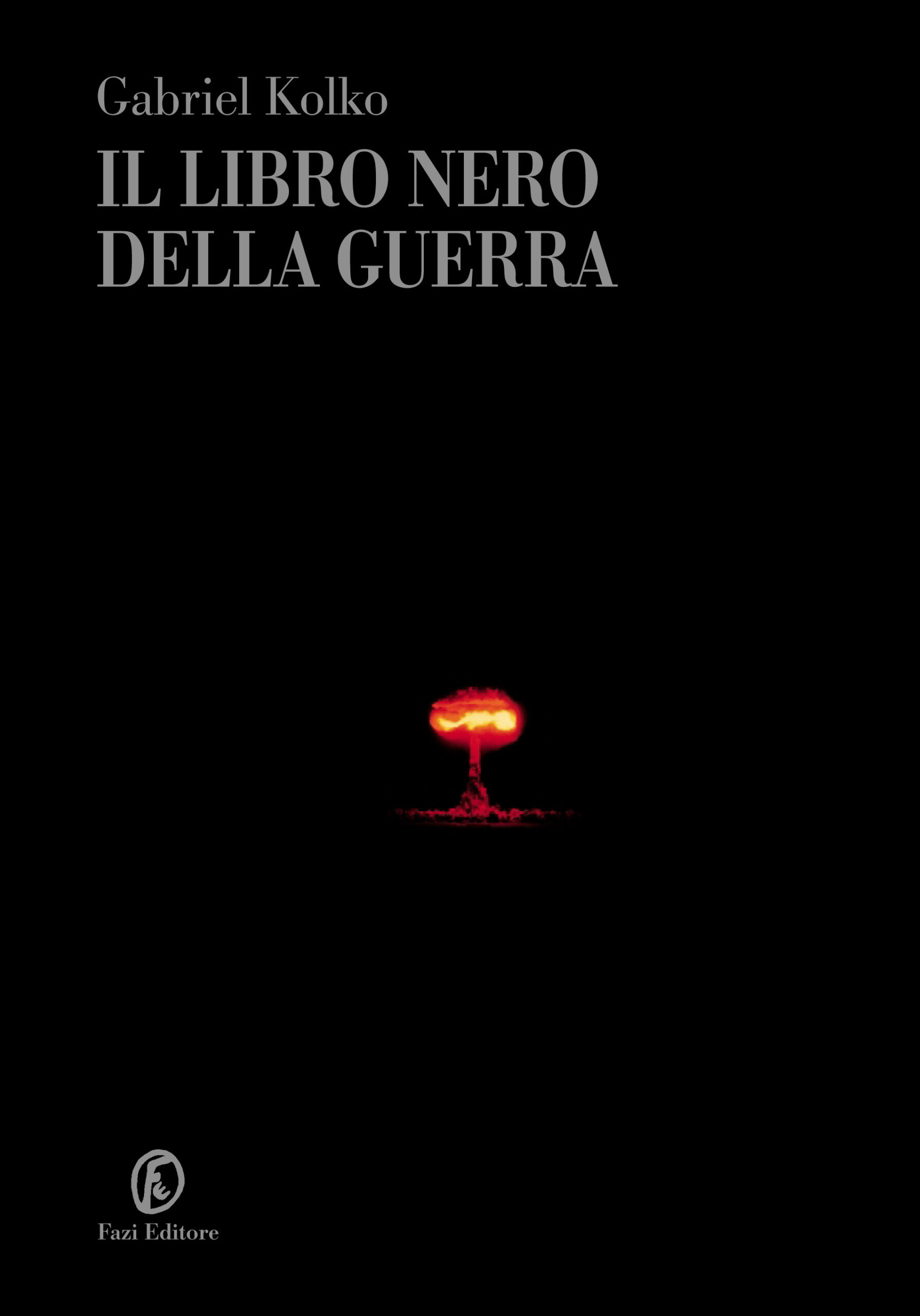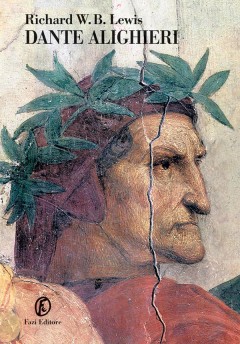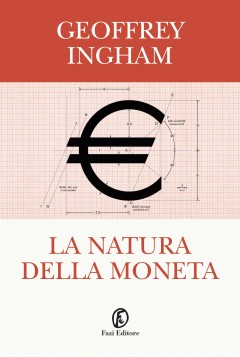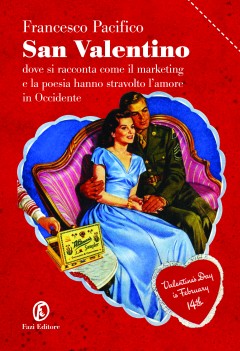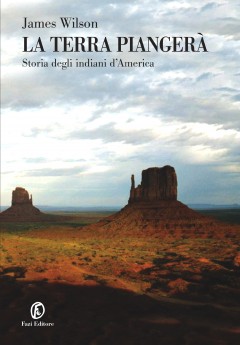
Gabriel Kolko
Il libro nero della guerra
Traduzione di Massimiliano Manganelli
In questo volume della fortunata serie dei “libri neri” Fazi, Gabriel Kolko, fra i migliori storici americani viventi, fornisce una sintesi magistrale e un panorama di impareggiabile ampiezza sulle guerre dell’ultimo secolo, e in particolare sui loro effetti politico-sociali. Tutti i maggiori conflitti sono esaminati dal punto di vista politico, militare, sociologico ed economico, e la loro trattazione getta nuova luce su aspetti fondamentali della storia dell’ultimo secolo, dal sorgere dei totalitarismi in Europa dell’Est, in Cina e in Estremo Oriente, ai rapporti fra il comunismo sovietico e il movimento comunista internazionale, fino ai recenti e inquietanti mutamenti nella politica estera statunitense e alla diffusione mondiale del potere militare, fenomeno che è per Kolko la fonte di maggior preoccupazione. Ma una tesi portante unifica il libro: l’attenzione di Kolko è difatti puntata sul ruolo dei leader politici e militari, i quali, a prescindere dalla loro nazionalità, hanno regolarmente sofferto delle medesime distorsioni e illusioni ideologiche, e di una sistematica e in molti casi incomprensibile sottovalutazione delle conseguenze delle guerre. Il libro nero della guerra è probabilmente il maggiore studio storico sulle guerre del ventesimo e ventunesimo secolo; un libro che cambierà il modo in cui guardiamo alle guerre del secolo trascorso ma anche la nostra visione del mondo d’oggi e delle sfide che ci troviamo a dover affrontare.
– 01/05/2006
La guerra e le illusioni delle élites
La lettura del libro di Gabriel Kolko, uno dei più importanti storici americani e uno dei maggiori studiosi delle guerre moderne, mi ha fatto tornare in mente un celebre aforisma di Karl Kraus: “Come viene governato il mondo e com’è che viene condotto in guerra? Dei diplomatici ingannano dei giornalisti e ci credono quando poi leggono il giornale”.(1) L’aforisma corrosivo di Kraus si rivela, alla luce della monumentale analisi di Kolko sulle guerre dell’ultimo secolo, piuttosto centrato e assai prossimo alla realtà dei fatti.
Il lavoro di Kolko, “Century of War. Politics, Conflicts, and Society since 1914”, tradotto in Italiano da Massimiliano Manganelli per Fazi Editore col titolo “Il libro nero della guerra. Politica, conflitti e società dal 1914 al nuovo millennio”, rappresenta un tentativo ambizioso e fuori del comune di interpretare la natura stessa della guerra nella modernità. In particolare la prospettiva relativamente originale scelta dallo storico americano è quella di approfondire esplicitamente l’analisi della guerra come processo sociale più che come evento politico militare. In altre parole non si tratta di guardare semplicemente il teatro del conflitto tra nazioni, ma di osservare le dinamiche e gli avvenimenti sociali, economici e politici che si scatenano con le guerre proiettandosi nel futuro e segnando lo sviluppo dei diversi paesi coinvolti a distanza di diversi decenni.
Prendendo in esame alcune guerre – la prima e la seconda guerra mondiale, la guerra di Corea, la guerra del Vietnam, la guerra civile nelle Filippine e in Grecia fino all’episodio più recente dell’Iraq – Kolko analizza gli effetti sui civili e sulla società mostrando come questi siano stati molto più ampi di quanto non fosse stato messo in conto, e come abbiano prodotto conseguenze profonde e radicali sull’assetto sociale e politico del Novecento.
Tra questi effetti ci sono quelli psicologici sugli uomini mobilitati per combattere, quelli economici sulle società coinvolte, come i fenomeni di inflazione con le relative conseguenze sul ceto medio e sulla classe operaia; quindi i traumi provocati dagli eserciti invasori, lo sradicamento e le migrazioni forzate che hanno ridefinito la composizione della popolazione in Europa, i processi di urbanizzazione, la crescita della disoccupazione, i conflitti sociali che ne conseguono, la carestia, la rovina o la distruzione di alcune classi sociali anche privilegiate, la concentrazione delle ricchezze e la spinta nella costituzione di grandi movimenti rivoluzionari, socialisti e fascisti non concepibili in tempo di pace, fino all’avvento dei regimi comunisti in Europa e in Estremo Oriente, più in generale la trasformazione del modo di vita della popolazione: “Dal momento che hanno trasformato la realtà umana e sociale, nel Novecento le guerre hanno ampiamente modellato il tempo e le dinamiche sociali. Hanno spesso spazzato via, o addirittura distrutto, vasti settori delle classi economicamente privilegiate e hanno influenzato operai e contadini in numerosi paesi, costringendoli a pensare e agire in modi inimmaginabili in tempo di pace”.(2)
Ma viste tali conseguenze, la questione da discutere – suggerisce Kolko – è il divario eccezionale tra le aspettative dei politici e degli strateghi, ovvero delle élites responsabili delle guerre, e la realtà storica effettiva che poi realmente si è prodotta. Qualunque fossero i paesi, le forze politiche e i piani strategici da essi predisposti le guerre – questo il principale tratto comune emergente – non hanno mai corrisposto alle loro previsioni. Le attese sono andate sempre deluse.
La logica della credibilità
Da qui si sviluppa l’analisi della guerra proposta dal lavoro di Kolko: “Il Novecento ebbe inizio con una profonda fiducia in se stesso. Quali che fossero gli obiettivi, tutti quelli che immaginavano il futuro condividevano un ottimismo e una fiducia nel fatto che avrebbero raggiunto i loro scopi”.(3) Questo ottimismo affonda le radici in parte nell’illuminismo, nella fede nella possibilità di una valutazione trasparente delle realtà, in parte nella sicurezza del potere e nell’incapacità di ipotizzare che le decisioni dei governanti si dimostrassero alla lunga così inesatte e negative da nuocere alle società cui appartenevano e da ultimo anche a se stessi. Nell’ambito delle guerre, in effetti, l’ampiezza dei cambiamenti ha sempre trasceso le capacità di analisi e di calcolo dei principali attori e smentito radicalmente le loro aspettative. In tutti i conflitti analizzati i piani non sono andati come previsto.
In questo modo Kolko suggerisce anche di distinguere le motivazioni e le cause delle guerre dalle dinamiche reali e dichiara il proprio interesse verso i processi piuttosto che verso le origini dei grandi conflitti. D’altra parte forse una delle origini delle guerre andrebbe ricercata proprio nella reiterata pretesa di prevedere e controllare le forme e le dinamiche della violenza e della guerra, e nell’incapacità di apprendere dalle smentite della storia: “Fu l’ingiustificato ottimismo di innumerevoli esponenti politici, convinti che sarebbero stati liberi dalle pressioni interne, a far sì che essi si imbarcassero nelle guerre per ragioni effimere e simboliche, le cui conseguenze si sarebbero rivelate devastanti per decine di milioni di persone”.(4)
Tra gli aspetti dei ragionamenti e delle valutazioni che ritornano con maggiore costanza nelle élites dirigenti, indipendentemente dalle idee politiche, c’è quella che Kolko chiama “la logica della credibilità”. Nelle decisioni assunte che hanno condotto nazioni e popoli alla guerra, la presunta necessità di salvaguardare un’immagine di forza, prestigio e credibilità internazionale ha avuto sempre un ruolo fondamentale. I capi di Stato si sono mossi per esempio con l’idea che se non si fossero riaffermati con i propri comportamenti e le proprie scelte i sistemi storici di alleanze politiche fra paesi con i doveri che esse implicavano si sarebbe messa in pericolo la condizione di equilibrio e stabilità del mondo.
Più in generale la logica della credibilità sembrava rendere necessario mostrare la disponibilità all’uso della forza da parte di un paese anche quando altre valutazioni lo avrebbero sconsigliato, pur di riconfermare simbolicamente il proprio ruolo politico e militare e incutere un senso di rispetto e di timore alle altre nazioni. Gli stessi interventi militari in zone non direttamente strategiche o in occasioni di non grande importanza dovevano servire a testimoniare il proprio vigore e la propria volontà di mantenere un certo ordine di cose. Insomma dietro certe scelte catastrofiche sul piano delle perdite umane, ambientali e sociali va registrata la volontà di mantenere anzitutto una propria immagine di fronte agli altri. Le questioni simboliche, legate all’immagine e al prestigio, dunque non sarebbero affatto secondarie, per esempio rispetto a motivazioni economiche o strategiche, ma al contrario sarebbero cruciali e fondanti.
Da questo punto di vista, dietro certe decisioni, sottolinea Kolko, ci sarebbe tutt’altro che un’analisi ponderata e razionale dei fattori in campo e delle conseguenze probabili. Nelle guerre del secolo scorso i diversi leader non avevano in realtà che idee assai scarse delle conseguenze degli eventi bellici per il loro popolo, per gli assetti sociali e politici e per loro stessi; soprattutto non avevano nozioni adeguate del tributo di sangue e dolori che le loro avventure militari avrebbero generato. Con pochissime eccezioni (una sola nei casi esaminati da Kolko), le élites politiche dei diversi paesi, sia democratici che dittatoriali, hanno dato inizio alle guerre con un carico impressionante di ignoranza, di illusioni e di aspettative inconsistenti.
Questa notevole miopia e sottovalutazione della realtà e l’incapacità di prevedere le conseguenze – sostanzialmente negative anche per loro stessi – è frutto in gran parte di un percorso decisionale in cui contano soprattutto gli interessi politici interni e le ambizioni personali. Questi interessi diventano dei filtri in ogni fase del processo di acquisizione e valutazione delle informazioni e delle costruzioni delle priorità strategiche nelle decisioni.
Kolko cita da questo punto di vista una messe di esempi – dalle guerre mondiali a quelle più recenti – in cui i preconcetti e pregiudizi ideologici delle classi di governo furono anteposti a qualsiasi analisi e valutazione realistica nelle decisioni da prendere di fronte alla guerra imminente o già in corso. L’atteggiamento di Hitler nella seconda guerra mondiale, in particolare nella campagna di Russia, per esempio, o l’atteggiamento dei governi statunitensi di fronte alla guerra del Vietnam, rivelano da questo punto di vista la medesima propensione a disconoscere l’esistenza di una realtà spiacevole: “la guerra dell’America contro l’Iraq del marzo 2003 – nota Kolko – rappresenta soltanto l’ultimo esempio di un simbolismo che definisce le strategie e del rifiuto di accettare la realtà, fattori che ne hanno guidato la politica estera per generazioni”.(5)
Da questo punto di vista la messa a disposizione di un’ingente mole di dati da parte dei moderni servizi segreti non sembra migliorare la situazione, anzi la semplice quantità di informazione prodotta garantisce il fatto che questa sarà verosimilmente trascurata quasi tutta: l’eccesso di informazione si traduce in un’incapacità di selezionare ed estrarre le (poche) informazioni rilevanti.
A questo proposito vale la pena confrontare le osservazioni di Kolko sul conflitto del Vietnam, dove gli americani vollero testare l’efficacia della guerra limitata e la credibilità della potenza americana, e di cui Kolko descrive accuratamente l’impasse spionistica e il divario tra realtà e politica, con le analisi che Hannah Arendt fece dei cosiddetti “Pentagon Papers”.(6)
I Pentagon Papers sono i quarantasette volumi della storia del processo decisionale americano sulla politica in Vietnam, realizzati su commissione del segretario alla Difesa Robert McNamara tra il 1967 e il 1968 e resi pubblici dal “New York Times” nel 1971. Dall’analisi dei “Pentagon Papers” emerge il ruolo nella conduzione della politica estera americana in Asia, dei cosiddetti “problem-solvers”, professionisti – esperti di “games theories”, modelli simulati, analisi dei sistemi – che erano stati chiamati al governo per risolvere le difficoltà dell’intervento americano. Ciò che è interessante notare è che il fallimento disastroso dell’impresa asiatica come emerge dai “Pentagon Papers” non può essere ricondotto semplicemente a degli sbagli, a errori di calcolo, a errate valutazioni. Dai documenti si percepisce invece l’importanza della dimensione di menzogna, falsità, dissimulazione, creata dallo staff tecnico dei governi Usa nell’intera gestione politica di contro alla straordinaria accuratezza dei continui rapporti redatti dai servizi segreti sulla situazione reale. Come nota Hannah Arendt, la politica della menzogna non era utilizzata solamente e nemmeno principalmente nei confronti del nemico, piuttosto veniva utilizzata nella propaganda interna rivolta a ingannare il Congresso e l’opinione pubblica.
Un secondo aspetto notato da Hannah Arendt fu il fatto che gli obiettivi e di conseguenza le decisioni tattiche mutavano continuamente. Gli obiettivi ufficiali furono in successione “l’autodeterminazione del Vietnam del sud”, “l’apporto contro il complotto comunista”, “il contenimento della Cina”, “evitare l’effetto domino”, “la reputazione dell’America nella lotta contro la sovversione”. Quando dopo il 1965 le possibilità di vittoria vennero meno, gli obiettivi diventarono “convincere il nemico che non può vincere”, “evitare un’umiliante sconfitta”, infine “far vedere al mondo fino a che punto gli Stati Uniti sono capaci di impegnarsi per un Governo amico” e “tener fede agli impegni”. Su tutto dominava la paura delle conseguenze sulla reputazione degli Stati Uniti e del loro Presidente. Dai “Pentagon Papers” emerge in definitiva che l’unico scopo permanente fin dall’inizio nell’impresa americana in Vietnam era quello di “comportarsi come la più grande potenza del mondo” per convincere il mondo di questo fatto. Come commenta Hannah Arendt, “lo scopo ultimo non era né il potere né il profitto. Non era neppure quello di esercitare un’influenza sul mondo per poter servire specifici, concreti interessi per salvaguardare il prestigio della ‘più grande potenza della terra’. Lo scopo a questo punto era l’immagine stessa, com’è evidente nel linguaggio stesso adoperato dai “problem-solvers”, con i loro ‘scenari’ e i loro ‘pubblici’, presi a prestito dal teatro. Per raggiungere questo fine ultimo, tutte le politiche divennero mezzi intercambiabili a breve termine, finché quando tutti i segni stavano a indicare che ci si avvicinava alla sconfitta in una guerra di logoramento, l’obiettivo non fu più quello di evitare una sconfitta umiliante ma di trovare i modi e i mezzi per evitare di ammetterla e ‘salvare la faccia'”.(7)
Per quanto incredibile possa sembrare, ciò che ha giustificato una guerra lunga e sanguinosa e la sua prosecuzione anche senza reali prospettive di vittoria, con tutto quello che ha significato in termini di vite umane, di sofferenza, di distruzione sociale e ambientale, di ripercussioni internazionali e interne, non fu altro che una questione di “immagine”.
Ma non sorprende di meno lo sforzo continuo e inesausto di quei “problem-solvers”, nel calcolare probabilità, immaginare scenari, pianificare delle strategie, costruire delle immagini, senza tenere conto della realtà dei fatti su cui i servizi di informazione fornivano dati dettagliati. Tra gli esperti della sicurezza nazionale americani, nelle alte burocrazie del potere, non hanno giocato alcun ruolo una valutazione pacata o il semplice buon senso. Piuttosto il deliberato disprezzo per tutti i fatti storici, politici, geografici, un totale distacco dalla realtà, una proiezione in un mondo defattualizzato, immaginario, virtuale. Hannah Arendt nota come in tutto il processo decisionale si è avuta una “micidiale combinazione di ‘arroganza del potere’ – il perseguimento di una mera immagine di onnipotenza – con l”arroganza della mente’, una fiducia assolutamente irrazionale nella possibilità di calcolare la realtà”.(8)
Fisionomia delle élites
Il Vietnam è solamente il caso più eclatante, ma se osserviamo quello che sta avvenendo in Iraq possiamo renderci facilmente conto che la storia non ha insegnato nulla. Le élites politiche sembrano leggere la realtà con lenti deformanti, mostrandosi incapaci di prendere atto degli errori di valutazione e delle contraddizioni prodotte.
Secondo Kolko ci sarebbe una connessione tra processi di selezione delle élites dirigenti e le performance politiche da esse prodotte: “Per intendere a fondo la causa dell’endemica e sistematica miopia delle classi dirigenti è decisivo sottolineare la somiglianza dei metodi formali e informali attraverso i quali in tutti gli Stati vengono selezionati e plasmati gli uomini di potere, indipendentemente dai sistemi politici. Tali processi di integrazione sociale non si fondano mai su una razionalità astratta e oggettiva oppure su norme di merito, ma sopprimono inesorabilmente sul nascere la carriera di quegli individui che, con tutta probabilità, trattano l’informazione come un mezzo neutrale e razionale per chiarire e contribuire a formulare politiche che devono ancora essere nettamente definite, per porre pertanto domande critiche e scomode su questioni fondamentali che interferiscono con i presupposti, gli obiettivi e gli interessi predeterminati di un sistema di classe e degli uomini che lo gestiscono”.(9) In sostanza secondo Kolko, “in ogni Stato moderno, il processo di integrazione sociale dei leader è fedele in maniera monolitica a quel consenso di fondo che al contempo definisce e vincola la sua classe dominante e, che sia o no spietato, è sempre altamente efficace”.(10)
In altre parole sarebbero i fattori del carrierismo e dell’ambizione personale a generare il consenso monolitico tra le élites dirigenti. Questi uomini si rapportano soltanto tra di loro, in un atteggiamento di fedeltà e di reverenza funzionale alla loro carriera politica e non tengono conto del resto. In questo modo le stesse informazioni disponibili, anche quando sono ampie e documentate, vengono spesso snobbate, censurate o addirittura manipolate. Vengono selezionate quelle che potrebbero confermare o giustificare la prospettiva già assunta, vengono nascoste quelle contrarie e vengono spesso anche create ad hoc informazioni false e tendenziose per supportare la propria linea politica autonomamente assunta. Si registrerebbe dunque, da questo punto di vista, una miscela particolarmente esplosiva di autoreferenzialità, di conformismo e di atteggiamento manipolatorio ricorrente nelle élites al potere.
Nella sostanza, nota Kolko, “alla guida degli interessi di una nazione non è mai esistita, né mai comparirà in futuro, una razionalità ‘intellettuale’ obiettiva e disinteressata” come quella presupposta dai teorici weberiani, anzi i criteri tecnici astratti “diventano infinitamente meno importanti del carrierismo e dell’ambizione, i quali rappresentano la peculiarità decisiva che proietta le persone verso il potere”.(11) Contraddicendo frontalmente alcuni degli assunti del pensiero politico ‘realista’, lo storico americano sottolinea che nell’ultimo secolo “le guerre sono state il prodotto non soltanto del retaggio di forze strutturali economiche o geopolitiche e del nazionalismo, ma anche delle strategie militari e degli assunti dei governanti riguardo alla natura, alla conduzione e ai rischi del conflitto armato in contesti istituzionali e storici eccessivamente complessi”.(12)
Si potrebbe sottolineare, incrociando ancora l’analisi di Kolko a quella della Arendt, come il ricorso eccessivo al segreto, alla menzogna, alla propaganda, all’immagine artefatta, non coinvolge solamente i cittadini e i loro rappresentanti ma coinvolge gli stessi protagonisti, le stesse élites. I politici, profondamente convinti di poter manipolare la realtà e le persone a loro piacimento, allontanata sempre più la realtà da sé, diventano infine incapaci di distinguere il vero dal falso, fino a rimanere ingannati dai loro stessi inganni. Si arriva così a un certo punto oltre il quale le menzogne non sono più una scelta o una strategia, ma sono dettate da una logica e una coerenza interna e divengono necessarie per la propria stessa sopravvivenza politica. A quel punto, quando la menzogna non è più uno strumento, ma è il mondo di fantasia da cui si dipende, si finisce col credere alla propria menzogna, a credere secondo quanto si è fatto e si è detto. Proprio come diceva Karl Kraus nel suo acuto aforisma.
D’altro canto, come ho cercato di sottolineare altrove(13), la questione dell’autoinganno non riguarda solamente i politici e il tema classico della propaganda e della manipolazione politica non basta a spiegare gli atteggiamenti dell’opinione pubblica verso le guerre nelle società contemporanee.
Dunque, perché una parte consistente della popolazione americana ed europea ha creduto a queste motivazioni platealmente artefatte? Non è solo questione di manipolazione. Se ci sono molte persone che hanno preferito negare la realtà della situazione e credere che Saddam Hussein possedesse nuove armi di distruzione di massa, o che avesse intrattenuto rapporti con al Qaida, significa molto semplicemente che esse hanno avuto bisogno di crederci. C’è stata cioè un’adesione volontaria a una visione delle cose perché è più tranquillizzante guardare le cose in quella prospettiva. Il non crederci comportava un costo emotivo e cognitivo pesante perché avrebbe costretto a fare i conti con le responsabilità del proprio paese. A questo proposito val la pena ricordare l’analisi del tema del “diniego” proposta dal sociologo Stanley Cohen nel suo libro “Stati di negazione”.(15) L’atteggiamento del diniego di fronte a una realtà dolorosa e umiliante e perciò difficile da riconoscere e affrontare non è una specialità delle classi dirigenti, né tanto meno dei soli dittatori, ma è un fenomeno piuttosto diffuso anche nella cosiddetta società civile dei paesi democratici.
Cecità sistematica delle classi dirigenti
Il punto dunque non è semplicemente la tendenza a guardare e interpretare la realtà in maniera selettiva e autoconfermante. La dimensione drammatica nasce invece dal fatto che con gli Stati moderni un numero limitato di persone sono chiamate a pronunciarsi su processi e problemi di sempre maggior ampiezza e complessità proprio nel momento storico in cui l’impatto delle tecnologie di produzione e distruzione sugli ambienti sociali e naturali ha assunto una dimensione inconcepibile rispetto al passato.
Nei fatti i problemi sarebbero due e tra loro intrecciati. Uno socio-politico che riguarda i sistemi politici, le caratteristiche dei processi decisionali, le caratteristiche dei soggetti che sono chiamati ad assumerle, la complessità dei processi in campo, l’ampiezza e le dimensioni delle decisioni assumibili e anche i limiti di sicurezza che da questo punto di vista si possono porre. Il secondo socio-tecnico, ovvero la divaricazione tra la capacità di impatto delle moderne tecnologie di produzione e distruzione e i limiti cognitivi ed emotivi degli esseri umani.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, oggi l’evoluzione delle tecnologie militari e delle armi di distruzione ci pongono in maniera ancora più forte che in passato di fronte a questo limite nella comprensione dei disastri che gli esseri umani stessi possono causare.
A questo aspetto si collega anche l’altra questione, quella socio-politica. Il modo in cui la pone Kolko è interessante ma insufficiente e per certi versi contraddittorio. Il punto di forza della sua analisi è la sottolineatura che “quasi ogni guerra del Novecento ha al contempo sorpreso e deluso tutti i governanti, indipendentemente dalla loro nazionalità. Considerati gli elementi di carattere politico, sociale e umano implicati in ogni conflitto, nonché la quasi certezza che questi ingredienti si combineranno provocando effetti imprevisti, i governi che valutano l’esito delle guerre in termini di eventi militari essenzialmente prevedibili sono immancabilmente condannati alla delusione. La teoria e la realtà effettiva della guerra contrastano fortemente fra loro, giacché i risultati di un conflitto non si possono mai conoscere in anticipo. Uomini e donne segnati dalla cecità sono stati il motore della storia moderna, oltre che fonte di sofferenze e distruzioni infinite”.(18) Le classi dirigenti, ossessionate dalla potenza e della forza, hanno dimostrato in tutti i tempi una “cecità sistemica” verso le conseguenze e i processi scatenati con le guerre.
Il paradosso sembra dunque così riassumibile: le élites dirigenti spingono il proprio paese alla guerra sulla base delle proprie aspettative, poiché credono di poter controllare e condurre gli eventi a loro favore; allo stesso tempo l’insegnamento fondamentale delle guerre novecentesche è che le guerre sono eventi complessi che tradiscono sempre le aspettative di chi le scatena e spesso travolgono le stesse élites che le hanno volute. Questo paradosso segnala a mio avviso un problema epistemologico che è implicito nel lavoro di Kolko ma non è ben messo a fuoco, in parte perché l’autore stesso non vuole rinnegare la fiducia in una razionalità illuministica che risolva la complessità del reale.
Egli infatti per un verso punta la sua attenzione sui criteri di reclutamento degli individui nella classe dirigente come spiegazione dell’atteggiamento manipolatorio e irrazionale delle élites di fronte a eventi di tale portata. Per quanto questo aspetto senz’altro può contribuire a esacerbare un certo tipo di comportamento c’è tuttavia una questione più ampia da sottolineare. In fin dei conti c’è un qualcosa di problematico in quelle strutture così verticistiche su cui si fondano tutti gli stati moderni indipendentemente dai regimi corrispondenti. Non si tratta semplicemente di selezionare individui migliori e più razionali in base alla fiducia che le persone giuste al posto giusto possano dirigere adeguatamente le vite e le speranze di milioni di altre persone ma al contrario di ripensare i sistemi e le istituzioni politiche in modo tale che le singole persone non possano assumere decisioni di tale importanza da sole o in ristretti consessi senza passare attraverso processi decisionali aperti, partecipativi che possano in qualche modo mettere in campo dei processi decisionali più collettivi, riflessivi, problematici e sostanzialmente più cauti.
Da questo punto di vista l’acquisizione per certi versi sorprendente degli ultimi decenni è che i regimi democratici non sembrano mostrare nessun elemento di contenimento e di moderazione particolare rispetto alle propensioni belliciste di una qualsivoglia classe dirigente.
Ora per tornare al punto fondamentale suggerito da Kolko – “chi inizia la guerra immancabilmente perde il controllo dei suoi aspetti decisivi”(19) – le possibili letture sono differenti.
In effetti io credo che la guerra sia espressione della convinzione radicata negli esseri umani che la violenza sia controllabile o quanto meno indirizzabile. Gli uomini fanno la guerra perché sono convinti di poter gestire e dominare la violenza. Ciò che caratterizza il ricorso alla guerra è proprio la convinzione che la violenza possa rimanere mezzo, strumento, ovvero che non prenda il sopravvento e che non si ritorca contro se stessi. Sono pochi quelli che affermano apertamente che la guerra è una buona cosa. La maggioranza deplora questo strumento e tuttavia ritiene che “in certe circostanze…”, “a certe condizioni…”, “entro certi limiti…”, “esercitando una certa responsabilità…”, sia legittima e inevitabile. Insomma l’epistemologia che sta alla base dei sostenitori della guerra è quella per cui la violenza se misurata e controllata può essere “funzionale” o “accettabile”. Alla base di ogni guerra c’è l’illusione dell’autocontrollo rispetto alla violenza. Si crede che si eserciterà soltanto la violenza “necessaria”, la violenza “legittima”, ovvero la violenza razionale, proporzionata al fine. Naturalmente non è mai così. Nella guerra la violenza segue dei meccanismi propri che tendono all’assuefazione, all’escalation, allo scatenamento. Ogni guerra dimostra che la violenza, una volta scatenata, non è affatto controllabile.
Spesso si crede che nel riconoscimento e nell’accettazione della violenza vi sia un elemento di realismo, di pragmatismo politico. Da questo punto di vista il lavoro di Kolko contribuisce a mostrare come nella realtà le cose siano piuttosto diverse. Le guerre rappresentano sorprese incontrollabili per chi le avvia. Quanto al realismo, la guerra non ne rappresenta l’essenza ma la sua antitesi. D’altra parte non è chiaro fino a che punto Kolko voglia mettere in discussione gli assunti antropologici e politici degli attori che egli
vuole criticare di fronte alle aspettative di pianificazione e controllo. L’idea cioè che sia possibile un processo più razionale, oggettivo, impersonale di valutazione che avrebbe permesso di evitare almeno in parte questi disastri. Nella parte finale del libro, soprattutto, Kolko sembra rimettere nuovamente le speranze di superare la tragedia della guerra nell’avvento di una civiltà razionale e trasparente. Egli torna a guardare alla tradizione razionalista, internazionalista, umanitaria e radicale, contro la minaccia dell’insorgenza di forze politiche irrazionali e reazionarie, distruttive sul piano materiale.(20) Auspica l’avvento di un socialismo rinnovato come proposta di una nuova organizzazione economica, capace di favorire un’equa distribuzione del reddito e della ricchezza come condizione preliminare della stabilità sociale e della pace tra gli Stati.
È curioso che Kolko proprio nelle conclusioni rischi di ricadere nella stessa illusione di ordinare la realtà e di controllare gli eventi che ha mietuto tante vittime nel Novecento, riproponendo senza alcuna cautela e mediazione critica il progetto di un regime superiore – “di gran lunga la migliore delle alternative date” – capace di imporsi sulla complessità e le contraddizioni del reale.
Non si può evitare di domandare cosa fonda in Kolko la fiducia che un progetto complessivo di questo genere – ancora riproposto nei termini di uno scenario trasparente, di un’alternativa economica razionale ed equa, che si potrebbe definire semplicemente sulla valutazione di mezzi e fini adeguati, ovvero di un soggetto politico razionale che crede di poter trasformare il mondo – non vada incontro alle stesse delusioni che egli ha così finemente analizzato nei processi bellici e politici del Novecento.
Per Kolko la questione più ardua sarebbe semplicemente quella del “controllo della leadership e del ceto politico”: “occorre cioè imporre alle persone e alle istituzioni di governo meccanismi di verifica infallibili, tali da impedire il ripetersi dell’opportunismo, della doppiezza, dell’egoismo e di tanti altri atteggiamenti negativi. […] solo in tal modo è possibile vigilare sui rappresentanti del popolo e impedirne il tradimento del potere e della fiducia di chi ha conferito loro una tale responsabilità”.(21) In altre parole nella visione di Kolko non viene messa in discussione l’idea di un soggetto politico razionale e presente a se stesso e di un mondo trasparente che può essere ordinato se solo ci si mettesse di buona volontà.
Dietro ogni guerra ci sono persone che credono con piani e scenari di controllare la vita e la morte, eserciti e obiettivi, bombardamenti e soccorsi, perdite e profughi, missili intelligenti, accordi possibili, rischi calcolati, persone “expendable”, prezzi da pagare. Ma a questa illusione controllista non se ne può opporre semplicemente una simmetrica e di segno opposto.
Da questo punto di vista la conclusione di Kolko è carente proprio sul piano epistemologico. Attacca il disprezzo per la realtà e l’atteggiamento manipolatorio dei politici ma non rinuncia all’illusione illuminista di poter con le migliori intenzioni coscienti controllare e prevedere questa realtà, financo di fronte a fenomeni politici altamente complessi.
Quello che va messo in causa invece sono proprio le pretese di un paradigma razionalista e meccanicista nel modo di guardare alla guerra e ai processi politici in generale: la pretesa di un soggetto buono e razionale che crede di agire oggettivamente su una realtà esterna disconoscendo le infinite connessioni che legano ogni essere e ogni società alla realtà che pretende di plasmare. Dunque la pretesa di un soggetto razionale di controllare e dirigere fenomeni così ampi e radicali quali le guerre moderne o i grandi processi politici. La via della pace al contrario non può che essere quella di una diminuzione della “hybris” politica, di una rinuncia a plasmare il mondo secondo i propri progetti, di una prassi politica in cui l’obiettivo non sia definito a priori ma nasca dal coinvolgimento, dal confronto e dalla interazione di una pluralità di esseri umani. Da questo punto di vista, come ha ben argomentato Tzvetan Todorov, bisogna guardarsi anche dalla “tentazione del bene”, dal desiderio di imporre il bene agli esseri umani, anziché cercarlo assieme a loro.(22)
– 18/02/2006
La guerra genera la guerra e logora la nostra intelligenza
– 30/12/2005
Il Novecento messo a ferro e fuoco
Immaginare la guerra come un catalizzatore delle grandi trasformazioni politiche e sociali, cercando di individuare i nuovi caratteri di modernità. E’il punto di partenza del saggio di Gabriel Kolko, considerato il maggiore storico delle guerre moderne: una rigorosa analisi sui conflitti che percorre tutto il 900 e che si affaccia alle porte del XXI secolo.