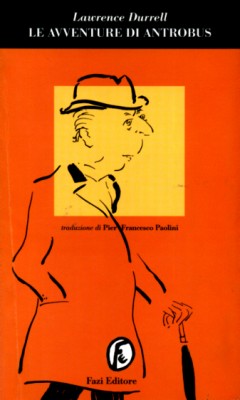Ray Bradbury
Verdi ombre, balena bianca
A cura di Alessandro Zaccuri
Traduzione di Chiara Vatteroni
È il 1953 e Ray Bradbury arriva in Irlanda invitato dal grande regista John Huston per scrivere la sceneggiatura di Moby Dick. Il giovane scrittore scopre, non appena mette piede sull’isola, di essersi imbarcato in un’avventura ben più grande di quanto immaginato: penetrare l’enigma di una terra permanentemente avvolta dalla nebbia e della sua gente confusionaria e irritante. Così comprende che qui la magia è di casa, la poesia è lingua innata e la vita una tragedia che, alla fine, riesce sempre a farci ridere. «”La ragione della sua presenza in Irlanda?”. L’ispettore leccò la matita e marchiò il taccuino. “La ragione non c’entra per nulla”, sbottai… Sono qui per scuoiare la Balena Bianca ed estrarne l’olio”. “Scuoiare”. Scarabocchiò. “Estrarre l’olio. Balena Bianca. Sarebbe Moby Dick, allora?”».
«Verdi ombre, balena bianca è una scoperta bellissima».
Alberto Rollo, «Diario della settimana»
«Una delle cose più divertenti che vi possa capitare di leggere di questi tempi… una delizia».
Francesco Durante, «D di Repubblica»
«Un’operazione straordinaria, quella di Bradbury».
Ruggero Bianchi, «Tuttolibri – La Stampa»
– 27/11/2007
Che l’universo esploda. Basta avere Shakespeare
Un’impresa titanica, un conflitto profondo fra lo sceneggiatore e il regista. Ray Bradbury, chiamato a “ridurre” il romanzo di Melville, racconta come nacque “Moby Dick” di John Huston.
Epico e fastoso. Titanico. Enigmatico e barbarico. Quando parlano del ‘Moby Dick’ (1956) di John Huston, le storie del cinema lo ricordano così: come una Bibbia della rivolta. Come una sfida impossibile. Come magnifica ossessione. È lo stesso regista, del resto, a suggerire questa interpretazione: “Questo film”, sono parole sue, “rappresenta la più importante dichiarazione di principi che abbia mai fatto. Si tratta, nero su bianco, di un’immensa bestemmia. Achab è l’uomo che odia Dio e che vede nella balena bianca la maschera della perfidia del Creatore. Considera il Creatore un assassino e vede in se stesso colui che ha la missione di ucciderlo. Achab è l’uomo che ha compreso l’impostura di Dio”. Una lettura “blasfema”, non c’è che dire. Affascinante e provocatoria, radicale e disorientante. Che aggiunge un elemento di interesse in più a un libro già di per sé magnetico e imprescindibile. Certo non era facile portare sullo schermo un capolavoro come quello di Melville, con la sua prosa forgiata nell’acciaio, le sue aggettivazioni estreme, le sue impuntature mistiche, i suoi trapassi metaforici e analogici. Si trattava di trasformare la complessività in semplicità e, appunto, di rovesciare il senso del racconto. Per farlo, John Huston scritturò uno sceneggiatore d’eccezione, lo scrittore e romanziere Ray Bradbury (‘Cronache marziane’, ‘Fahrenheit 451’), che nel 1953, poco più che trentenne, passò lunghi mesi in Irlanda, assieme a Huston e ai suoi collaboratori, per mettere a punto la sceneggiatura del film. La storia di questa esperienza (e di questo rapporto esclusivo e ossessivo con un testo da trasformare in cinema) è ora narrata dallo stesso Bradbury in un libro (Verdi ombre, balena bianca”) uscito in edizione inglese nel ’92 e finalmente disponibile anche in italiano nella traduzione di Chiara Zatteroni. Un po’ diario di viaggio, un po’ autobiografia intellettuale e un po’ saggio critico su Melville (ma anche su Huston, e sulla macchina – cinema), ‘Verdi ombre, balena bianca’ è uno di quei rari libri di cinema in cui il lettore cinèphile trova di che alimentare la propria passione. Bradbury non è uno sceneggiatore che si limiti a taglia re e ricucire, amplificare e semplificare. A venire nitidamente in primo piano dal suo racconto, appassionante come un romanzo giallo, rigoroso come un saggio critico, è infatti lo scontro “ermeneutico” che attorno al ‘Moby Dick’ si scatena fra lui e Huston. Huston sta con Achab, Bradbury sta con Starbuck (il coscienzioso primo ufficiale che arriva a un passo dall’ammutinamento, ma anche alla fine rimane fedele al principio d’autorità). Per Huston Moby Dick è un Dio da uccidere, per Bradbury è l’ultimo discendente dell’innocenza primitiva. Il film nasce dal conflitto di questo duplice sguardo. Dalla tensione fra due letture che si respingono e si attraggono a vicenda. Da due ipotesi interpretative apparentemente inconciliabili che riescono miracolosamente a trovare un punto di equilibrio. Forse anche per questo Moby Dick di John Huston continua ad essere, per tutti, un grande film.
E mentre Huston bestemmiava “perseguitato da Dio”, Bradbury si defilava tremando tra le voci e le nebbie dell’”isola verde”
L’arpione negli occhi
Pestando a sangue sulla tastiera la balena di Huston
Il primo verbo è “guardai”, l’ultimo è “vidi”. C’è come un’ossessione scopica – o un’inevitabile centralità dello sguardo – nel libro che Ray Bradbury dedica ai mesi tumultuosi della sua vita trascorsi in Irlanda, nel 1953, impegnato nell’impresa apparentemente impossibile di scrivere la sceneggiatura del “Moby Dick” di Melville per conto e su incarico del regista John Huston. Vedere, guardare, scrutare. Far lavorare gli occhi (quelli del corpo, ma anche quelli della mente). Tessere relazioni di volta in volta rabbiose, delicate e penetranti fra il mondo e lo sguardo. Tenendo “Moby Dick” – il suo mito, il suo mistero – sempre sullo sfondo: opera-mondo gigantesca che sfida la capacità dello sguardo di ridurla in immagini, testo mitico che sfugge alle lusinghe del cinema e alla voglia del cinema di farne soltanto un film. Ray Bradbury ci prova. È il 1953, l’anno di grazia di Farhenheit 451, e la sola idea che un mito vivente come John Huston abbia scelto per lui – scrittore poco più che trentenne – per sceneggiare il “Moby Dick” eccita e galvanizza il giovane Bradbury. Come racconta, appunto, in “Verdi ombre, balena bianca” (Green Shadows, White Whale, 1992, ora pubblicato da Fazi Editore nella bella traduzione di Chiara Vatteroni, pp. 308, L. 29.000). “Verdi ombre, balena bianca”: fin dal titolo, il diario-saggio-romanzo di Bradbury evoca un chiasmo (in italiano) o un parallelismo (in inglese). In ogni caso: un cortocircuito fra il un luogo (la verde Irlanda che appare agli occhi dello scrittore appena sceso dal traghetto) e un mito (il cetaceo-isola che egli si appresta a trasformare in film). Verde-bianco / ombre-balena: due colori che cozzano, due fantasmi (ombra e balena) che si incontrano. Se Moby Dick è un’isola – come scrive Alessandro Zaccuri nella postfazione – non si poteva che scegliere un’altra isola (un’isola “vera”: l’Irlanda) per provare a lavorarci su. Così, “Verdi ombre, balena bianca” è prima di tutto un libro sull’Irlanda vista dagli occhi di uno scrittore americano. Poi è l’anamnesi di uno scrittore che racconta il proprio lavoro come se fosse un romanzo. Infine è il resoconto appassionante di una delle pagine più titaniche della storia del cinema: per le difficoltà oggettive e per gli ostacoli che il testo di Melville pone a ogni tentativo di “riduzione”, ma anche per la diversità di vedute tra il giovane sceneggiatore e il vecchio regista. Per Huston la balena bianca è un Dio, da uccidere, per Ray Bradbury è l’ultimo emblema dell’innocenza perduta. Huston sta dalla parte di Achab e della sua smania blasfema, Bradbury da quella di Starduck (il coscienzioso primo ufficiale del romanzo di Melville che prende il mare tormentato dal pensiero della famiglia rimasta a casa). Il conflitto è aperto, aspro, non conciliabile. Il libro di Bradbury lo racconta con appassionata onestà. E raggiunge il sua climax nelle pagine dove descrive come la sceneggiatura si sia fatta quasi da sé, in una sorta di raptus creativo che all’improvviso scioglie problemi su cui il lavoro si era incagliato. Scrive Bradbury: “Rimasi seduto alla macchina da scrivere e nelle successive sette ore scrissi e riscrissi l’ultimo terzo della sceneggiatura. (…) Borbottai, bofonchiai, mi lamentai e gridai (…). Ma non c’era stanchezza, soltanto il tenace, continuo, gioioso e trionfante pestare sulla macchina mentre le pagine coprivano il pavimento: Achab piangeva distruzione sopra la mia spalla destra, Melville incitava a costruire da sopra la sinistra”. Il “Moby Dick” di Huston nasce da questo conflitto. Non lo esorcizza, lo mette in scena. Ma forse è proprio per questo che il film continua a parlarci. In una doppia lingua che inevitabilmente “ci riguarda”. Adesso lo sappiamo perché il “Moby Dick” di John Huston (1956) non è riuscito a essere un grande film. Credevamo che si trattasse della solita, scontata regola per cui un Mostro raffigurato, sulla tela, sullo schermo o come illustrazione sulla pagina, non vale in genere a spaventarci come un mostro di cui sentiamo parlare, e la cui presenza imminente viene via via minacciata o promessa: come scrive lo stesso Melville nel capitolo LV, “un ritratto può colpire nel segno più di un altro, ma nessuno potrà mai far centro esattamente; e il solo modo di avere una qualche ragionevole idea di scoprire a cosa somigli veramente la balena è di andare a caccia personalmente”. Dati gli ovvi rischi dell’impresa e le difficoltà opposte dal WWF, oggi ci resta una ragionevole via di mezzo, che è quella di leggere il romanzo: magari non tutti riescono ad arrivare in fondo, come succede a Woody Allen in “Zelig”, ma chi ci si immerge dal principio alla fine, dagli Estratti e dalle Etimologie fornite da un vice-vice bibliotecario alla finale e distruttiva presentificazione del Mostro, ne viene ampiamente ricompensato, non foss’altro dai momenti davvero vertiginosi in cui crede di stare leggendo un’astratta e schematica descrizione anatomica di una balena ipotetica, e poi, quando siamo arrivati a montare su una scaletta, a dare un’occhiata dentro la bocca, tenendoci a un dente finché Tashtego, Daggoo o Queequeg, “dentisti provetti”, non provvedono a segare anche quello, ci rendiamo invece conto di essere dentro, anche noi, a “una” balena particolare. Beh, sì, non era un compito facile farne un film. Probabilmente la balena gigante realizzata dalla de Havilland Aircraft per il film di Huston, e poi sostituita per le riprese ravvicinate da una serie di modellini di legno e acciaio ricoperti di lattice, era tecnicamente più avanzata delle props di cui disponeva il vecchio film il bianco e nero con John e Lionel Barrymore, quello del 1930 diretto da Lloyd Bacon (e da Michael Curtiz per la versione tedesca) in cui Achab aveva una fidanzata (Joan Bennett) e persino un cognome (Ceeley): ma tutto sommato neanche quella di Huston riusciva a fare una grande impressione, e c’è da pensare che la soluzione migliore fosse quella, adottata da Orson Welles nella sua versione per le scene, di mettere le mani avanti con qualche precauzione di tipo pirandelliano e metateatrale. “Tanto per chiarire – domandava un Attore Scettico -, dovremmo forse offrire un naufragio, un tifone e un’enorme balena bianca sulle tavole di questo palcoscenico, e tutto per due dollari la poltrona?”. In ogni caso, il problema specifico del film di Huston era un altro, come adesso scopriamo dal libro di Ray Bradbury, chiamato a suo tempo dal regista in Irlanda, dove si sarebbero svolte gran parte delle riprese del film, per scrivere una sceneggiatura che a lui, Huston, sarebbe sempre sembrata inadeguata e deludente. Forse lo “script” era davvero modesto, rispetto non tanto a Melville (il che era ovvio) quanto allo standard del Bradbury autore di meravigliosi racconti di sciencefiction: ma il fatto è che all’interno della troupe impegnata nella preparazione del film si era prevedibilmente riprodotta una situazione di conflitto fra un regista-capitano Ahab, rotto a tutte le esperienze, e un timido narratore-Ismaele che aveva paura di tutto, e soprattutto di lui. Nelle sue memorie del 1980, che gli Editori Riuniti hanno imperdonabilmente intitolato “Cinque mogli e sessanta film” (1982), Huston ammette che durante le riprese di “Moby-Dick” si era quasi convinto che l’aiuto regista o altri tramassero contro di lui finché non si era accorto che a perseguitarlo era Dio, irritato per la versione cinematografica di un’opera così blasfema; ma non perde occasione di biasimare lo sceneggiatore che aveva scelto, “decisamente originale nei suoi scritti”, ma nella vita privata tutto banalità e frasi fatte, e poi pauroso fino alle lacrime quando si andava in automobile, per non parlare dell’aereo dove rifiutava assolutamente di salire anche per il breve volo dall’aeroporto di Shannon a Gatwick. E cinque anni dopo la morte del regista, nel 1992, lo scrittore avrebbe risposto con “Verdi ombre, balena bianca”, che ora Fazi presenta nella traduzione di Chiara Vatteroni e con un’infomatissima e appassionata postfazione di Alessandro Zaccuri. Come si difende Bradbury? Non si difende affatto: ricorda, soffrendone ancora, gli scherzi a suo avviso feroci del regista, non nasconde le sue paure, i suoi imbarazzi e le sue lacrime, si consola con un’Irlanda non tanto verde quanto rosea, dove tutto, dalla religione alle rivolte contadine o alle bevute al pub, diventa occasione festosa e vociante, popolata da garrule comparse che sembrano uscite da uno spettacolo dell’Abbey Theatre o dal nostalgico film di John Ford “Un uomo tranquillo”. E si vendica mandando il suo boss ad affrontare in una notte di nebbia fitta, nei giardini della sua villa isolata e nel silenzio della mezzanotte, un “banshee”, un vendicativo fantasma irlandese in agguato nel buio, tra la foschia e “grandi ragnatele spettrali” senza che intorno si vedesse un solo ragno. È un bel racconto intitolato appunto “Banshee”, che Bradbury a suo onore aveva già pubblicato a parte. E del resto, bisogna capirlo: a differenza di Huston, che a quanto pare non aveva paura di niente (e forse ne aveva “troppo” poca, per poter rendere sullo schermo la grande metafora melvilliana), Bradbury aveva già scritto qualche anno prima di imbarcarsi per l’Irlanda, uno splendido racconto intitolato “Il veldt” (1950): dove i piccoli, innocenti Peter e Wendy giocavano con leoni immaginari nel tecnologico ciclorama della loro stanza, ma poi finivano per farli “diventare veri”, con fatali conseguenze per i loro genitori. Proprio come l’Ahab del romanzo, a ben vedere: che si dichiarava disposto, in mezzo a un fortunale, a “piazzare parafulmini sulle Ande e sull’Himalaya, perché il mondo potesse stare al sicuro”, ma sulla sua nave non voleva privilegi, e aspettava solo lo scontro frontale.
Ray Bradbury
Verdi ombre, balena bianca
I racconti fanno più effetto in una bella cornice. Lo sapeva Giovanni Boccaccio, lo sapeva Geoffrey Chauser, lo sapevano gli anonimi compilatori delle Mille e una notte. Lo sa Ray Bradbury. Nel 1956 Bradbury, che ha trentasei anni, che ha già pubblicato “Cronache marziane” (1950) e “Fahrenheit 451” (1953), arriva in Irlanda per lavorare con il regista John Huston alla sceneggiatura di Moby Dick. Dal mare, l’Irlanda si presenta verde come nei cartelloni pubblicitari. Alla dogana si annuncia con un doganiere filosofo. Poi il verde si muta nel grigio di una pioggia eterna. Filosofo si rivela anche il taxista, che abbandonato per strada dalla macchina scassata, tira fuori dal bagagliaio una bicicletta perché il cliente arrivi con le sue gambe alla meta. Non prima di avere fatto una sosta al pub di Finn. Il pub di Finn a Kilcock sarà il maggior scrigno dei racconti, la lente con cui Bradbury guarderà in quella scatola magica dalle prospettive illusorie che è ancora l’Irlanda degli anni Cinquanta. Ancora estraneo, non ancora neofita, nel pub di Finn assiste agli effetti ferali di uno dei non rari frontali tra due ciclisti che pedalavano all’impazzata a fari spenti nella notte. In Irlanda tutto è strano, persino gli stranieri. È strano Tom, gran bel Yankee cinquantenne, che non sa resistere all’intimazione di Huston di sposarsi in Irlanda in uno scervellato matrimonio alla cacciatora. È strano quel David Snell-Orkney che per anni ha girato il mondo da un parallelo all’altro, da un meridiano all’altro, inseguendo l’estate con un gruppo di efebi senza età dalla meravigliosa voce di soprano. Che sente la nostalgia estetica dell’autunno sotto la neve, delle foglie rosse coperte dal ghiaccio. Che appaga il suo desiderio a Dublino, in una visita di un’unica giornata che non dimenticherà, che gli amici del pub di Finn neppure. È misterioso il potere della musica, che nasce dalla ragnatela effimera tessuta sulle corde dell’arpa da un mendicante che ha imparato a suonare dal padre, che del padre ha applicato il consiglio di non suonare mai in un luogo chiuso, per un pubblico pagante. È misterioso il cieco che suona la fisarmonica sul ponte, unico a Dublino a non possedere un berretto per ripararsi dalla pioggia. È misterioso l’impulso che spinge Bradbury, che al cieco non ha mai dato un penny, mentre lascia cadere con la malagrazia del pudore un profluvio di monete nelle mani di tutti i mendicanti della città, di comprargli un berretto di Tweed il giorno stesso che scompare. È misterioso il bambino stracciato che una mendicante esibisce sulle scale dell’hotel, che è rimasto identico al bambino stracciato che Bradbury anni prima aveva visto in braccio alla stessa donna. Che intanto è invece invecchiata. Nei racconti irlandesi Bradbury anni prima aveva visto in braccio alla stessa donna. Che intanto è invece invecchiata. Nei racconti irlandesi di Bradbury la cornice non è però neutra. Huston, con la sua immagine vistosa di cavallerizzo impenitente, di donnaiolo ingordo, di genio consapevole, entra spesso nel racconto. È ispiratore e protagonista persino dell’unico pezzo esplicitamente di invenzione che Bradbury inserisce nel libro. In un moto di ribellione alla personalità prepotente di Huston, Bradbury lo fa protagonista di una storia con una banshee, una delle donne soprannaturali che nel folklore e nelle convinzioni irlandesi attraverso suoni striduli e lamentosi annunciano una morte. La rivincita è un piatto che si consuma caldo, nell’eccitazione di un risveglio in cui lo spirito di Melville si impadronisce dell’autore e della sua macchina da scrivere, per ricomporre nella sceneggiatura (sotto la grande metafora della moneta d’oro inchiodata all’albero come premio per colui che avvisterà per primo la balena bianca) tutte le metafore minori di Moby Dick. Il lavoro è concluso. Non restano che gli addii più asciutti e commoventi agli amici del pub di Finn.
– 02/01/1999
Dall’Irlanda
RAY BRADBURY, Verdi ombre, balena bianca, Fazi , Roma 1998, pp. 312. L. 29.000.
Chi l’avrebbe detto che tra le pieghe della letteratura si nascondesse anche questo gioiello? Lievita, qui, una magica sintesi di elementi, una miscela imprevedibile che incanta il lettore. “Verdi ombre” è l’Irlanda, terra di uomini spicci e sentimenti schietti, luogo di coincidenze fatali e di cordiali follie. “Balena bianca” è il Leviatano, Moby Dick, quella del romanzo di Melville, qui più simbolica che mai dato che vive una sua esistenza autonoma dal romanzo in attesa di essere catturata nelle maglie di una sceneggiatura cinematografica. E quella virgola umile che nel titolo si frappone tra due soggetti tanto ingombranti, compressa ma non schiacciata, è Ray Bradbury, scrittore che fra i primi ha condotto la fantascienza al rango della letteratura: il suo “Fahrenheit 451” è un romanzo importante e un bel romanzo. Bradbury ha saputo applicare a parecchi soggetti le sue doti di puntiglio e di ironia. Ma in questo libro è successo quel “qualcosa” che accade quando la perizia di chi racconta si imbatte in una materia speciale. Su un episodio realmente accaduto – il viaggio di Bradbury in Irlanda, nel 1953, per lavorare a una sceneggiatura del romanzo melvilliano, da cui John Huston trarrà un film – la memoria innesta un sovraccarico di emozioni e di impressioni, fino a strasfigurare una catena di fatterelli non memorabili in una canzone indimenticabile. C’è tantissima Irlanda, qui, per un omaggio appassionato e un po’ sarcastico, sempre perdonabile perché le stoccate d’apertura riguardano ogni volta quello “yankee”spaesato che è l’autore. Si procede per immagini, per istanti fermati nella loro provvisorietà, già dai primi, fenomenali dialoghi alla dogana (p.8, opportunamente riportati in quarta di copertina): <<“La ragione della sua presenza in Irlanda?”…”La ragione non c’entra per nulla”>>. E tutto quel che segue, sul doppio binario del ritratto ambientale e di quello umano, obbedisce alla logica misteriosa ma infallibile per la quale nessun verde è più verde di quello irlandese quando c’è il sole, e nessun verde lo è di meno non appena il sole si cela. Il popolo dei pub, le leggi della guida, i mendicanti, i lord, le donne fatali, le mogli assennate, le cacce alla volpe, le sbronze funebri, la quotidianità, il meraviglioso: tutto, di colpo, può assumere sembianze opposte. Basta un attimo. Un raggio di sole. Un sorso di whisky. Una stretta di mano. Tutto questo per trecento pagine fitte e catturanti, da innamorarsene per sempre. E a da ringraziarne l’autore, soprattutto perché l’epicentro del racconto, la terraferma che gli consente di inarcarsi e decollare, è proprio un suo personale buonsenso, misura sommessa ma solida della realtà mutevole. Lo si avverte in certe affermazioni pacate ma decise su temi esistenzialmente capitali come la decisione di fedeltà coniugale (“A casa ho una moglie che mi ha sposato, e che forse arriverà presto. Non troverà rossetto sul mio colletto né capelli lunghi sulla mia giacca”, p.129) e la consapevolezza del proprio posto nel mondo (Corsi in albergo per ringraziarla nell’unico modo che conoscevo: fare il mio lavoro e farlo bene”, p.155). E’ anche per questo che nel racconto il sorriso è tanto frequente e mai sguaiato; dignitoso, comprensivo, qualche volta tenero come un pianto travestito, come un allegro struggimento. Quello scritto (datato 1992) non è un romanzo, non è un diario: è un atto di amore tributato con le armi affilate del narratore che crede nel suo mestiere. Gli italiani ne debbono la scoperta ad Alessandro Zaccuri, che lo ha trovato, proposto e curato e che firma un saggio-postfazione perspicuo e informato.
Verdi ombre, balena bianca
Ray Bradbury ha legato il suo nome soprattutto a romanzi di fantascienza come “Cronache marziane”, “Fahrenheit 451” (da cui Francois Truffaut trasse un film) e “Canto il corpo elettrico”. “Verdi ombre, balena bianca”, invece, nasce dalla sua esperienza come sceneggiatore di “Moby Dick” il film che John Huston, registra tanto geniale quanto dispotico, girò in Irlanda sul finire degli Anni Cinquanta. Bradbury si rea in Irlanda per curare la sceneggiatura di “Moby Dick” nel 1953 e da quel viaggio di lavoro trasse un ‘esperienza di vita unica e da raccontare. Con occhi incantati Bradbury guarda questa terra di un verde unico e inconfondibile e rimane stregato dai suoi infiniti misteri resi ancora più affascinanti dalla nebbia che l’avvolge e dalla gente che la popola, confusionaria e spesso irritante. E con la penna del narratore attento e raffinato racconta le storie diverse e accattivanti di terroristi romantici, di preti beoni, di donne sedotte e abbandonate e di quella straordinaria corte dei miracoli che popola le strade di Dublino. Ne nasce un affresco unico di una terra che nei secoli ha conservato intatta la sua magia e dove la poesia è lingua quotidiana. “Verdi ombre balena bianca” viene edito da Elido Fazi per la prima volta in Italia. E sicuramente questo libro non mancherà di riscuotere successo colmando allo stesso tempo un vuoto nella narrativa straniera importata nel nostro Paese,opera alla quale il giovane Fazi si è dedicato da tempo con molta figura.
– 04/01/1999
Melville, Bradbury, Huston Cavalieri D’Irlanda
Herman Melville, Ray Bradbury, John Huston. Un trittico magnifico! Melville, il più grande narratore americano, autore di quel Moby Dick che Pavese ha trasformato in un testo fondamentale per la cultura italiana del secondo dopoguerra. Ray Bradbury, esponente di spicco della letteratura fantastica fantascientifica, creatore di Fahrenheit 451, un roamnzo trasformato in cult-movie da François Truffaut nel 1966, e di Cronache Marziane, una delle prime riscritture della conquista dell’America vista dagli occhi dei nativi, vinti e sterminati. John Huston, uno dei più classici (e, per i suoi tempi, ribelli) registi del nuovo Continente. Tutti e tre insieme in un volume (a cura di Alessandro Zaccuri), il cui sfondo e il cui elemento unificante è l’Irlanda, un territorio oggi di gran moda che si propone come campo di un nuovo rinascimento letterario volto a sovvertire, anche se non a cancellare del tutto, l’immagine proposta da John Ford nel 1952 con Un uomo tranquillo, splendidamente interpretato da John Wayne e Maureen O’Hara. Artefice di questa straordinaria operazione è l’unico dei tre che è sopravvissuto: quel Bradbury che, negli ultimi temo, sembrava in qualche modo aver tradito i propri lettori, volgendosi a una scrittura assai letteraria che, ai lettori di testi come L’uomo illustrato o come ancora il whitmaniano Canto il corpo elettrico, pareva una dolorosa regressione dalla grandi problematiche agli esercizi di stile. Un’operazione straordinaria, quella di Bradbury, non soltanto per i nomi che chiama in causa e per il paesaggio geografico e umano che evoca nelle sue pagine; ma anche e soprattutto per la sua capacità di ritornare (e risentirsi) giovane, di rivivere un’esperienza ormai lontana nel tempo non già con lo sguardo disincantato della persona anziana (è nato nel 1920), bensì con l’occhio vivace e curioso dello sceneggiatore esordiente, cui viene offerta l’occasione della sua vita. Per il narratore americano, Melville è ancora il grande classico studiato al college che Huston (come gli rimprovereranno in seguito colleghi e critici) trasforma in un ribelle, in una figura maledetta che ignora la logica della gnosi e rifiuta un concetto di Dio/Natura che apre condannare l’uomo a una metafisica e infinita sofferenza. Ma quella medesima vena che lo porta a litigare (per poi fare pace) con il grande regista del Nevada è già la stessa dei suoi scritti maggiori. Quella, ad esempio, che lo fa diffidare degli aerei e lo induce a convincersi che essi, aldilà di ogni apparenza, non riescano comunque a volare e che, in ogni caso, siano destinati a schiantarsi a terra. O quella che, in coerenza con il suo gusto del magico e del meraviglioso, lo porta a identificarsi con i frequentatori delle bettole d’Irlanda, per i quali il minor rischio di incidenti si ha quando si verificano nell’ordine alcune condizioni fondamentali: usare la bicicletta, anziché l’automobile; procedere nei punti pericolosi a fari spenti; pedalare contromano alla massima velocità consentita dalle gambe. Tre condizioni che da un lato chiamano in causa il destino e si appellano al fatalismo; ma, dall’altro, si appoggiano a misteriose leggi della probabilità, secondo le quali le maggiori speranza di salvezza si realizzano attraverso la massima esasperazione dell’incoscienza. Un messaggio valido per la vecchia Irlanda di John Wayne e Maureen O’Hara, ma pure per certe sue novecentesche logiche irredentiste (come documentano, una volta ancora, taluni film, questa volta recenti); e valido anche per un Ray Bradbury orami più che settantenne, che prova per qualche istante nostalgia e rimpianto per i tempi in cui, scrittore quasi in erba, credeva nell’assurdo e nel mistero come autentica e forse autentica possibilità di crescita.
– 11/03/1998
Nal labirinto di Bradbury
Memoria, fiction, cinema e un dorso di balena
Ray Bradbury non è solo l’autore di Fahrenheit 451 e Cronache marziane, né – val la pena di aggiungerlo – è solo autore di fantascienza: basti ricordare quelromanzo sottovalutato, di ambientazione hollywoodiana, che è Death is a lonely business semplificato in italiano come Morte a Venice. Verdi ombre, balena bianca non è un romanzo ma neanche un libro di memorie: attinge a un materiale auto-biografico (il soggiorno in Irlanda con John Huston durante la stesura dello script del film Moby Dick, la balena bianca, ma rivela insolita solidità strutturale, un andamento per segmenti ed episodi, una drammatizzazione di dialoghi e situazioni che fanno dimenticare la referenzialità del tema e calamita-no l’attenzione a universo narrativo. Il protagonista si trova faccia a faccia con tre mostri: il com-pito che gli è stato affidato (trarre dal romanzo di Melville una vicenda cinematograficamente credibile e compatta), il regista che glielo ha affidato (un John Huston vitale e aggressivo, umiliatore di amici e congiunti, feroce e imprevedibile), l’Irlanda (Paese impenetrabile e magicamente semplice, ottuso come una lunga sbornia e ostinato come un’idea fissa, affogato nella pioggia e nella nebbia). Bradbury insomma vede, sin dal suo sbarco sull’isola (terna ricorrente è la sua paura di volare), moltiplicarsi il mostro per eccellenza: quella balena bianca che. leggendo e rileggendo il romanzo, sembra sottrarsi alla vista del suo lettore e interprete. Un incontro-scontro con la natura dell’isola e la psicologia degli abitanti trova un luogo-filtro, il pub di Herbeer Finn, coi clienti fissi e l’erogazione quotidiana di alcol, storie e saggezza. Alla scena del pub si alterna quella dell’albergo di Dublino dove Bradbury ingaggia la sua battaglia con la macchina per scrivere. Compare ogni tanto sulla scena John Huston, e sempre per recitare, con violenza e passione, la parte del dominatore: coi suoi collaboratori, con gli amici, con la consorte. Lo si vede digrignare i denti sotto i lancinanti dolori di una caduta da cavallo ma anche ordinare alla moglie di rimontare subito sul cavallo da cui era stata sbalzata a terra. Lo si vede ordire un matrimonio protestante per due amici americani chiamati con la consueta imperiosità a celebrare le nozze lì, con la sua benedizione. Se ne sente l’alito forte di scotch, la voce tonante e il sapore di sfida che esala da ogni gesto, anche nella maligna determinazione con cui, nel finale, vorrebbe che lo sceneggiatore lo raggiungesse a Londra vincendo la paura di volare. La sua figura professionale è assorbita dentro la monumentalità di una abbaiata avventura esistenziale, né a Bradbury interessa sottolineare gli aspetti più conflittuali che hanno contrassegnato la relazione durante la stesura della sceneggiatura e la lavorazione del film. Allo scrittore preme di più lo scontro col mostro che il regista incarna e col mostro letterario che Huston gli ha messo fra le mani. La contiguità dei due fronti viene ribadita dalla bella successione romanzesca dei capitoli conclusivi: l’attesa ispirazione dà forma alle ultime quaranta pagine di sceneggiatura e viene abbattuto il muro di silenzio che il regista ha finito per opporre al testardo collaboratore. In questo contesto, il controcanto, a volte drammatico a volte comico, del faticoso ambientamento (esistenziale e intellettuale) in terra d’Irlanda suona ancora più decisivo e si porta appresso aneddoti gustosi (il racconto dei rivoltosi piegati dalla pigra nonchalance di un aristocratico), episodi esilaranti (il funerale di un lord raffinato bevitore, innaffiato di vino pregiato) e affondi drammatici (le bellissime pagine sui mendicanti di Dublino e in particolare le storie del cantante senza cappello sotto la pioggia battente e della suonatrice d’arpa inaridita dalle lodi con cui Bradbury vorrebbe consapevolizzare il suo talento). Come sottolinea il curatore Alessandro Zaccuri nella bella post-fazione, questi sono episodi rifluiti in gran parte in racconti autonomi a testi-monianza di un work in progress caratteristico dell’intelligenza e della creatività dell’autore di Fahrenheit 451. Eppure Verdi ombre, balena bianca è una scoperta bellissima, più di una curiosità: è il romanzo di un uomo dentro un paesaggio, dentro un labirinto di abitudini impastate d’alcol, religione, politica, un dorso verdissimo di balena immobile davanti all’ocea
Un incontro ravvicinato
Dalla parte dei marziani
Torna in libreria Ray Bradbury che già nei primi anni ‘60 era considerato il più grande scrittore di fantascienza
L’ultimo Ray Bradbury viene periodicamente riscoperto. Anche adesso, presso Fazi, con Verdi ombre, bianca balena, sul giraggio del Moby Dick di Melville che diventò un portentoso filmone di John Huston con Gregory Pecca e Orson Welles e un pretenzioso bric-à-brac di icone e culti e simboli. Ma su e giù per la California, nei beati anni del più squisito on the road tra San Francisco e Los Angeles, i pensatori intellettuali erano in realtà scarsi e rari come boutiques di conversazioni e di idee in una gaia sarabanda materiale di bei corpi e di divertimenti intensissimi. E Bradbury, giovane autore di Fahrenheit 451, già in quei primi anni Sessanta veniva celebrato come il più emerito autore di fantascienza al mondo. Abitava a Beverly Hills, preparava grandi film dal suo Cronache Marziane, da girare nelle città morte del medio Oriente; e lo si vedeva abbastanza in giro. Nei fastosi ristoranti dei produttori classici: tutti in cravatta a colazione fra enormi sigari e immense bistecche e lumini pallidi nel buio sepolcrale, con vecchi camerieri tipici come caratteristi di serie B. Nei teatrini di posa dei Desilu Studios, dove una troupe d’attori-cowboys televisivi praticava il teatro di idee non remunerato (cioè i suoi atti unici, a invito) come un contravveleno per non atrofizzarsi l’anima. E poi parties formalissimi (nella loro informality «venite come volete»), in certe casine veramente marziane, interamente di cristallo su agghiaccianti palafitte avvinghiate ai cocuzzoli più terremotabili in fondo la sunset boulevard., verso il mare. Biondo, bisteccone, energico, Bradbury parlava con gran calore e una tremenda forza di persuasione. e mettendo bene in chiaro: sono un intellettuale progressivo americano che scrivendo di marziani e di mostri fa in pratica un discorso di Real Politik. e i nostri pericoli sono attualmente due e terribili, insisteva, il commercialismo e l’intellettualismo. Ma nel pragmatismo appassionato di tutto quanto dicesse, oltre l’antica sollecitudine umanitaria degli autori di Utopie si sentivano fisicamente rivivere in versione “yankee” (!) contemporanea due linee tradizionalmente piuttosto inglesi di generosità disinteressata per gli “altri” prima che per il proprio self. O “ego”. soprattutto quell’ombrosa minoranza di moralisti puritani alla D.H. Lawrence, alkal Dr. Leavis, e naturalmente alla Orwell (e anche Koestler?) a cui non piace niente, non va bene niente. Non salvano niente. Ma il loro tormentoso e profetico rappel a l’ordre scuote e riempie di rimorso la acoscienza inquieta dei “clan dirigenti” scettici ed epicurei che hanno in mano i famosi “bottoni” del mondo dela cultura, fanno i propri buoni affari producendo best-seller consolatori con recensioni impegnate, si godono i propri facili successi in un intreccio di consensi «da cocktail» di destra e di sinistra, e con tutto ciò sperano ancora di riuscire a Salvar l’Anima. e inoltre la linea dei Buoni Vecchi Zii Liberali della E.M. Forster. Magari possono sottovalutare Joseph Conrad che non è dei loro, e compatire dall’alto in basso i vertiginosi «anomali» come Roland Firbank o T.E. Lawrence; facendo anche qualche violenza di troppo a Virginia Woolf e anche a un “tutto Bloomsbury” di seconda e di terza. E il loro limite sarà certamente quello di non osare spalancare gli occhi sulle violenze e sui drammi che nascono dalle contraddizioni nel mondo moderno. Però continuano a credere in assoluta buona fede nel valore edificante e illuminante della letteratura nello «spezzare le barriere», nel «connettere», nel «capire». E come G.B. Shaw o Angus Wilson possono trasformarsi in santi pastori laici dell’etica laburista e del progresso sociale. Ma Bradbury insisteva sui pericoli del commercialismo: cioè, il far cose che non piacciono, di cui non si è convinti, per obbedire al produttore, per compiacere l’editore, per fare un favore all’editore del giornale… E i pericoli dell’intellettualismo?… «Sinistri: lasciarsi influenzare dagli autori che si ammiriamo, dai libri che sia mano, dai giudizi dei colleghi che si stimano… anche illudersi di salvarsi l’anima facendo un “secondo mestiere” sedicente intellettuale, tipo l’insegnante». Non si usava ancor alla villania di ribattere: si spieghi meglio. ma Bradbury si spiegava benissimo: «Sono molto contrario a un secondo mestiere di natura letterari. Drena le migliori risorse, porta via troppo tempo se fatto con onestà, in complesso diminuisce a abbassa il potenziale creativo!» Altro che spiegarsi meglio… «Non credo affatto all’insegnamento della letteratura! Capita continuamente in America che lo scrittore più o meno celebre sia avvicinato da madri ansiose di consigli per un figlio con tendenze letterarie. La risposta onesta è una sola: comprategli una macchina da scrivere. Poi che s’arrangi. Le lezioni private di un Premio Nobel non servono a nulla!». Qui lo si sentiva non meno decisamente empirico e pragmatico di tutta la vecchia generazione di scrittori anti-intellettuali e autodidatti fra Sherwwod Anderson e Thomas Wolfe: «uomini che si sono fatti da sé», come gli industriali loro coetanei. Ma orami i futuri letterati e i futuri businessmen non vendono certo pop-corn gli angoli della strada. fanno compiti di letteratura creativa e ricerche di mercato in due istituti adiacenti allo stesso college. «Ma se proprio io ho venduto i giornali in strada per tre anni», dichiara fieramente Bradbury, «e sono convinto che invece di frequentare le classi di letteratura si impara molto di più nelle biblioteche pubbliche. Anche solo passeggiando e eleggendo; e annusando libri; e aprendone uno ogni tanto». Mi sembra un momento così alla Vasco Pratolini che gli chiedo subito come era da teenager. Dice che è venuto qui a tredici anni dall’Illinois, vicino Chicago, durante la Depressione; suo padre era uno dei molti milioni di disoccupati, equi Los Angeles la vita costava meno. Però diffida sistematicamente die pericoli di una grande città come New York. Troppi eventi culturali a tutte le ore, anche abbastanza attraenti, “da non perdere”: mostre, convegni, spettacoli. e in più, il “giro letterario”, tutti che si conoscono e telefonano e invitano: il pettegolezzo, il farsi vedere, in non potere dire sempre di no, il gioco del prestigio basato sul numero di presenza… «Uno scrittore, bisogna che abbaia un giroscopio dentro, che lo avverta quando sta perdendo tempo, fa cose non giuste , vede, gente sbagliata… Dopo tutto sono le qualità umane che contano, non l’ambiente. Perciò: è un luogo comune superficiale dire che siccome si vive a Los Angeles si debbono fare per forza cose ignobili per la televisore o il cinema. Ci si abita perché ci si sta bene, e si può lavorare in pace». (Beccatevi questa, voi scrittori francesi o italiani che “salivate” a Parigi o a Milano in cerca di Ispirazione?) «Uno non si vende se proprio non vuole. Bisogna vedere se ha personalità, se ha spina dorsale, a che tipo di successo tiene»… La vita morale, l’integrità professionale dei letterati: sono temi che lo attraggono, mescolati a una sua problematica psico-religiosa (la speranza, la compassione, il perdono) aldilà dei soliti schemi puritani o cattolici-irlandesi. Lo trovo severo, e curioso per certi aspetti del cattolicesimo: quanta saggezza, dice molto seriamente, nel rendere quasi indissolubile il matrimonio. «Altro che la pratica sbrigativa dei bruschi divorzi». Lavora tanto? «Tutto il giorno, da quando avevo sedici anni. Ogni racconto, in media, lo scrivo in una giornata. Poi lo metto da parte, magari per anni; lo riprendo, lo riscrivo; finché non trovo “la frase decisiva”. spesso il guaio è di non saper trovare da che parte incominciare. quattro o cinque idee al giorno, ma non si possono scrivere quattro o cinque racconti al giorno…». Si illumina di gioia parlando dell’entusiasmo di lavorare: «Magari occupandosi della morte, ma con una vitalità tremenda, come Goya». Proprio dopo questo riferimento a Goya, fatto in un articolo di giornale, gli arrivò una lettera di Berenson, che cominciava così: «Questa è la prima fan letter che scrivo in 88 anni…». Bradbury è venuto a trovarlo a Firenze, e hanno passato insieme parecchi giorni, dice. «Mi ha svelato il Rinascimento, allargato le mie prospettive, m’ha dato una consapevolezza… come Aldous Huxley qui in California, e più tardi Bertrand Russell a Londra. sono gli amici-maestri più cari». Guarda giù la vallata. «…E questa Los Angeles che esiste praticamente solo da questo dopoguerra sviluppandosi in maniere totalmente folli, in fondo sta attraversando un fenomeno molto simile al rinascimento. È il suo turno. come quando L’Italia e l’Olanda insegnavano pittura al mondo; e poi la lezione passa a New York che incomincia a sua volta a insegnare… Anche per questo ritengo giusto vivere qui». E ripete volentieri: «Perché so bene quello che voglio!». «Influenzare una comunità mentre di sta formando!… agire per il loro bene, prima che se ne rendano conto!… Aiutare a costruire un nuovo Rinascimento!… coi libri, coi saggi, certo: ma anche con racconti sulle riviste, con articoli sui giornali… Servendosi di ogni mezzo di espressione: cinema, teatro, televisione.. Scrivere oggi di trasporti pubblici e di gallerie d’arte, di pubbliche relazioni e urban planning è un modo di insegnare a essere umani… Ecco perché trovo irrilevante e inutile ogni letteratura dell’Assurdo. E deploro che non esista in America un teatro di idee». È chiaro che il famoso narrativo di fascinosi miti fantascientifici si considera eminentemente un saggista che ha scelto di esprimersi in a una forma simbolica immediata e diretta come Samuel Butler e Swift. «Se scrivo automobile o ascensore, tutti capiscono subito senza dover spiegare la carrozzeria e i carburatori, senza dover riepilogare ogni volta il funzionamento del motore a scoppio… E senza paura di bagnarsi: entrare, entrare nel fiume, non stare come spettatori sulla riva, se si intende influenzare le masse per il loro bene! e provare ad amare al chincaglieria, la mediocrità, la paccottiglia… Non disprezzarla; e non rifiutarsi di capire il senso dei media più popolari, come i comics, nelle loro forma vignettistiche e paradossali si occupano degli aspetti sconcertanti della vita americana d’oggi più profondamente delle riviste radicali accademiche (a cui peraltro collaboro), ma tutte così lontane dalla realtà, incapaci di ironia… come del resto al maggior parte degli scrittori americani moderni: seriosi, aggrottati, acritici, magari intellettualmente modesti… Però come si prendono sul serio. E come si amministrano: scrivono poco, e sempre con l’aria di scrittori maggiori che per il momento pubblicano solo opere minori…». «È vero che poveretti… (riflette a proposito di alcuni suoi colleghi)… spesso si trovano oppressi da problemi personali talmente gravi che non c’è da meravigliarsi se non vedono la realtà o la vedono stravolta. Nessuno però che si degni di occuparsi di fantascienza: come se fosse un “genere” inferiore o folle… mentre per esempio, fantascienza significa la scoperta dell’America o l’invenzione dell’automobile, la sua influenza sulla vita di tutti i giorni. Come l’auto può modifica re un rapporto amoroso, gli affetti famigliari, la struttura stessa della famiglia, l’influenza che può avere sulla sociologia del lavoro, il fatto stesso che in questa città il pedone sia considerato una bizzarria… e senza il largo margine d’imprevisto, glia spetti incompetenti e grotteschi in ogni scoperta, da Colombo a Cortez… e la conquista dello spazio! e nessuno si occupa delle trasformazioni straordinarie che avvengono in conseguenza della conquista dello spazio: in filosofia, in psicologia, nelle arti, nella teologia stessa! Discorsi come quello di Pio XII sullo spazio sarebbero stati inconcepibili un secolo fa…» «E i problemi che sorgono?… Per esempio si vive talmente condizionati dall’aspetto esteriore che per molti di noi un negro sembra appartenere a un altra razza… e se in un altro mondo si trovasse una spaventosa razza di ragni con tre teste che però vivesse eticamente, cristianamente, umanamente… Saremo disposti a distruggerla perché con conta l’essenza umana ma il loro aspetto?» Accarezzava il progetto di un romanzo o di un film su u papa spaziale che parte con la sua astronave dal Vaticano per il cosmo la ricerca della Verità. e quantunque si definisca “un battista rinnegato” si confessa affascinato dalla teologia cattolica. Ma soprattutto dai problemi teologici spaziali così come la filosofia lo attrae sotto specie di questioni metafisiche-spaziali. e quindi pare ironico che la radio annunci l’arrivo del presidente Kennedy in elicottero sul tetto del Beverly Hilton qua di fronte. Sembra una situazione ala Bradbury: si sentono i motociclisti del servizio d’ordine qua sul boulevard, poi il fracasso dell’elicottero che scende, mentre i camerieri continuano a servire con facce da vecchia Paramount. (Si era ancora nel 1963).
– 02/01/1999
Ray Bradbury
John Huston ra Dio e la Balena bianca
Nel finale del “Decameron”, vestendo panni di Giotto, Pier Paolo Pasolini si domandava: «Perché realizzare un’opera d’arte quando è così bello sognarla soltanto?». Parlando di John Huston, potremmo parafrasare Pasolini così: «Perché vedere un film quando è così bello limitarsi a raccontarlo?» John Huston, assieme a James Stewart e Robert Mitchum, è il massimo di leggenda che siamo riusciti a sfiorare nel nostro lavoro di cronisti di cinema. Lo andammo a intervistare durante un’edizione di Cannes, in quella specie di Versailles sul mare che l’Hotel du Cap vicino Antibes. Portava al festival il film “Sotto il vulcano”, ma soprattutto portava su di sé l’onore e l’onere di una vita avventurosa ed eccessiva. Vincendo l’emozione, riuscimmo a fargli una domanda scherzosa, partendo dal fatto che “sotto il vulcano” (ispirato al romanzo di Malcolm Lowry) era girato nei luoghi più suggestivi del Messico. Signor Huston, gli dicemmo, confessi. Lei ha fatto alcuni film solo perché aveva l’occasione di andarlo a girare in posti stupendi. Lui ridacchiò e rispose: «Lei ha ragione, mio caro, tranne che per un particolare: non è stato così per alcuni film, è stato così per tutti». Se persino la nostra mezz’oretta nella stanza dell’Hotel du Cap è occasione di ricordi indelebili e di narcisistiche memorie, figurarsi cosa dovrebbero far persone che hanno seguito John Huston per mesi, durante le riprese di un film o la scrittura di una sceneggiature. Ecco perché “Verdi ombre, balena bianca” era un libro irrinunciabile. Del resto Ray Bradbury, l’autore, è sempre stato un grafomane: la sua bibliografia è sterminata, è uno dei più bravi autori di fantascienza, e trovarsi a lavorare per mesi con Huston dev’essergli sembrato come andare su Marte. ”Verdi ombre, balena bianca” è (salvo omissioni) il terzo libro che rende la lavorazione di i un film di Huston simile a un romanzo. Nel caso, il film è “Moby Dick”, quindi il romanzo è al cubo. Un grande scrittore americano di oggi (Bradbury) viene convocato in Irlanda, dove Huston vive, per prendere il libro del più grande scrittore americano di ieri (Melville) e trasformarlo in una sceneggiatura. Letto il libro, ci siamo procurati “Moby Dick” in cassetta e rivederlo è stata una sorpresa: non è un capolavoro, ma un film assolutamente teatrale in cui la scrittura è tutto, la tensione linguistica è enorme e i celeberrimi dieci minuti riservati al monologo di padre Mapple sono stupefacenti (c’è poco da stupirsi, l’attore che lo recita è Orson Welles). Un film profondamente letterario, come letterario è il libro di Bradbury che ne racconta la genesi. In poche parole, i film di Huston sono avventurosi nel loro farsi, quasi più di quanto lo siano, dopo, sullo schermo. Lo dimostrano gli altri due libri in questione: Peter Viertel ha scritto un romanzo sulla lavorazione della Regina d’Africa, “Cacciatore bianco, cuore nero”, che è più solenne del film (che invece era pura commedia); e non a caso Clint Eastwood ne ha tratto un film in cui si diverte a interpretare Huston rendendolo ancora più ieratico dell'”originale”. La giornalista americana Lilian Ross, invece, ha raccontato la lavorazione di “The Red Badge of Courage” (in italiano “La prova del fuoco”) in un volume intitolato “Picture” e pubblicato d Faber&Faber: un resoconto quasi notarile che riesce a farsi epico, come epico era il film, tratto dalla meravigliosa novella di Stephen Crane sul “battesimo di fuoco” di una recluta durante la guerra di Secessione. Secondo molti (incluso chi scrive) il miglior lavoro di Huston, un regista che ha diretto decine di film diversissimi fra loro, quasi divertendosi a “schivare” qual capolavoro che in fondo inseguiva davvero solo in quella lunga e ininterrotta sceneggiatura che era la sua vita. Fra questi tre libri, quello da leggere assolutamente è “Verdi ombre, balena bianca”: perché è Bradbury, e perché c’è l’Irlanda. Lo scrittore di “Fahrenheit 451” parla tutto sommato poco di Huston e di Melville, ma gode come un pazzo a descrivere l’Irlanda con toni che vanno dalla sue “Cronache marziane” all'”Uomo tranquillo” di John Ford. È un’immersione nella follia e nel surrealismo (che in Irlanda è realismo, tout court) che farà ala gioia di chiunque abbia visitato, e amato, questo stupendo paese. Diciamo che Bradbury racconta il lato solare di “Moby Dick”, lasciando che sia Huston a definire quella che era, per lui, la natura profonda del romanzo del film: la Bestemmia, il desiderio di uccidere Dio, impersonato naturalmente dalla balena. Del resto in “Cacciatore bianco, cuore nero” Viertel descriveva Huston distratto rispetto al film, e ossessionato dal desiderio di compiere un sacrilegio uccidendo un elefante. Huston il bestemmiatore. A Hollywood, in Africa, in Irlanda. Dovunque ci fosse un Dio da affrontare.
– 11/10/1998
L’intervista / Parla il mastro della fantascienza. E spara zero sul degrado dell’istruzione, su Internet e sul suo “nemico” John Huston al quale ha dedicato un libro avvelenato. Mentre si entusiasma per le prospettive di una corsa nello spazio
Ray Bradbury: il futuro è un weekend sulla Luna
New York «IL DUEMILA? Ma è l’anno sbagliato! Le celebrazioni per l’inizio del Terzo Millennio dovrebbero svolgersi il primo gennaio del 2001. È quella la giusta ricorrenza che dovrebbe essere festeggiata perché il secolo non avrà termine se non alla fine dell’anno 2000. Il ventunesimo secolo comincerà soltan-to il primo gennaio del 2001 ma l’errore è stato fatto e così sarà celebrato il giorno sbagliato. Imbarazzante, no?» Ride, Ray Bradbury con l’irriverenza di sempre. È il più grande autore di fanta-scienza vivente. Walt Disney lo volle consulente quando decise di creare Eta Beta, l’inarrivabile progenitore di E.T. dal fisico inesistente e tutto cervello, inesausto divoratore di naftalina. La Nasa gli ha spesso chiesto di tenere lezioni o conferenze agli astronauti. Abita a Los Angeles con la moglie Maggie, ed è uno dei rarissimi “angelenos” a non avere un’aiuto. La sua popolarità è immensa almeno quanto la sua influenza sulla cultura contemporanea da quando ha pubblicato Cronache marziane e Fahrenheit 451. Adesso è uscito in Italia Verdi ombre, balena bianca (Fazi, 279 pagine, 29.000 lire), in cui Bradbury racconta con penna avvelenata la sua collaborazione con John Huston come sceneggiatore di Moby Dick versione cinematografica del capolavoro di Melville diretta nel 1956 dal regista americano-irlandese (“Una delle più spiacevoli esperienze, se non la più spiacevole, della mia vita!”, ricorda io scrittore). Pronto alla battuta come pochi, sulla soglia degli ottant’anni, il maestro della science fiction è rimasto un eterno bambino, vivacissimo, candido, paradossale, come si conviene a chi voglia arsi beffe dell’età. Prendere o lasciare». Comunque ci siamo, mister Bradbury. L’appuntamento-mito, errori celebrativi o no, è ormai alle porte. Quali saranno, a suo giudizio le sfide più importanti che ci riserva il futuro? «L’istruzione, prima di ogni altra cosa. In ogni angolo del mondo. Negli Stati Uniti, l’istruzione è andata al diavolo, non riusciamo più a insegnare adeguatamente a leggere e a scrivere, stiamo crescendo una generazione di idioti. Non so quale sia la situazione in Italia ma problemi simili esistono anche in Inghilterra. In Francia, in ogni pane del pianeta. E senza istruzione, non c’è futuro. Né, tanto meno cambiamento». D’accordo. Ma che tipo di istruzione, mister Bradbury? «Viviamo in una società tecnologica. E se non sappiamo leggere e scrivere. Non possiamo neanche usare e padroneggiare queste macchine che stanno influenzando le nostre vite. Non ha senso avere un computer se non si a farlo funzionare e non si sa quale tipo di informazione dargli o tirarne fuori. È da imbecilli, no?» Non prova molta simpatia simpatia per i nuovi media. Sembra piuttosto scettico al riguardo… «Scettico, è dire poco. Io sono un nemico di Internet. Lo trovo uno stupido esercizio per occupare il tempo di molti giovani che hanno voglia di sprecarne e credono di fare ricerca ma non la stanno facendo affatto! Ho sufficiente esperienza con Internet per dire che è un demenziale spreco di tempo. Che potrebbe essere meglio impiegato a una biblioteca o in libreria. Leggere un libro è molto meglio che giocherellare o “fare ricerca” con Internet». La conquista dello spazio, invece, la trova tra i sostenitori più accesi… «Spero che sia possibile compiere al più presto un’altra missione sulla Luna. Ma per restarci! E poi, farne un’altra su Marte, però con un equipaggio umano e non con i robot o altri macchinari. La corsa nello spazio deve continuare grazie all’iniziativa di esseri umani che possano descriverci cosa hanno fatto e visto e possano quindi coinvolgere nell’impresa altri abitanti del pianeta a prescindere dalla loro nazionalità. Quando raggiungeremo la Luna diverse volte, magari per il weekend, l’interesse sulla Terra sarà fantastico e sarà chiaro che gli astronauti presenteranno l’intera umanità e non soltanto un Paese. Insomma, non cambio idea Il nostro futuro sta nella conquista dello spazio». Il ventesimo secolo ha visto gli esseri umani raggiungere poteri impensabili, quasi divini, dalla scoperta dell’energia atomica alle manipolazioni genetiche. A proposito di conquiste, ipotizziamo la più azzardata e folle: diventeremo immortali, mister Bradbury? «Non ritengo che sia possibile o che qualcuno ci creda davvero, se debbo essere sincero. Penso invece che quello dell’età e dell’invecchiamento sia un problema di salute e di memoria. Purtroppo con il passare degli anni, ricordiamo soltanto le cose spiacevoli e non quelle buone mentre dovremmo trovare il modo per liberarci dai cattivi ricordi che spesso ci ossessionano. Chi sono varie etnie e comunità che per duecento anni si sono scontrate sinistramente e non riescono a dimenticare, con le conseguenze che sappiamo. Allora, il vero problema dell’età sarà di stare bene con il nostro corpo e soprattutto con la nostra mente a 90 o 100 anni, visto che sarà sempre più facile raggiungere questo traguardo. Ma io sono ottimista: nel XXI secolo lo sapremmo risolvere». A giudicare da “Verdi ombre, balena bianca”, lei però, non ha dimenticato affatto il lato oscuro di John Huston e io ha descritto come un mostro… «Temo proprio che lo fosse… Lo dico con amarezza perché era stato uno dei miei eroi giovanili, lo considero ancora uno dei più grandi registi di tutti i tempi e sono orgoglioso di essere stato scelto da lui per la sceneggiatura del film. Ma la mia ammirazione va solo all’artista, non all’uomo. In privato, Huston era crudele con la moglie, con gli amici, lo fu con me… Faceva di tutto per scoprire le debolezze degli altri, e, poi, li attaccava in modo meschino. Si serviva delle sue “scoperte” come armi. È difficile descrivere cosa fosse capace di fare con la sua perfidia». Tornando al futuro, qual è il suo sogno per il Terzo Millennio, mister Bradbury? «Beh, il mio sogno è ovviamente che non ci siano otto o nove guerre contemporaneamente, come è adesso. L’Africa è un disastro…credo che sia il sogno di tutti: un mondo finalmente unito, dove ognuno – individuo o nazione – possa vivere in pace e non ci siano guerre in India o in Pakistan, in Iran, o in Iraq, in Congo, o in Ruanda. Mio Dio, la storia è proprio orribile. Ma bando ai cattivi pensieri, sto per compiere ottant’anni e mi farebbe piacere vivere almeno per altri dieci anni. Perché, potrei sbagliarmi, ma il primo decennio del Nuovo Millennio dovrebbe essere molto bello. Potrebbe darci un mondo meraviglioso. Just a wonderful world».
Libri dello stesso autore