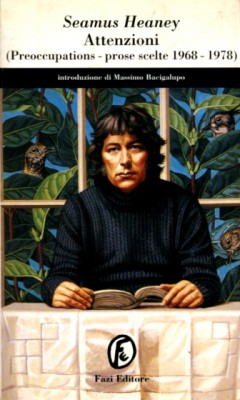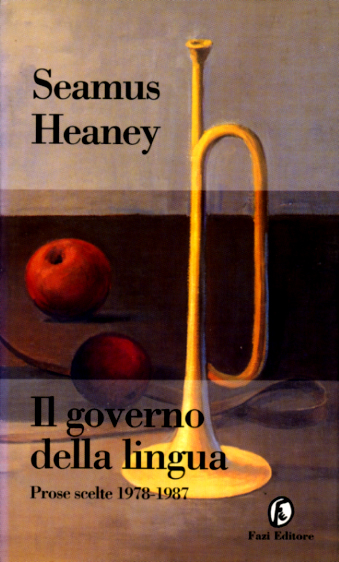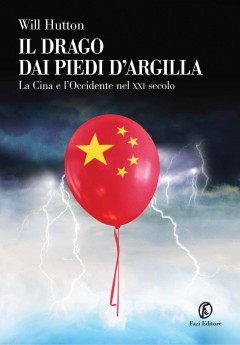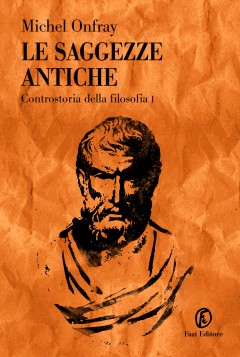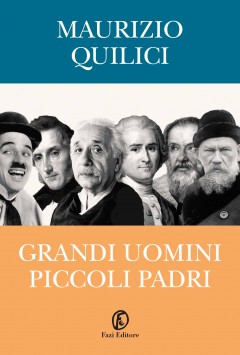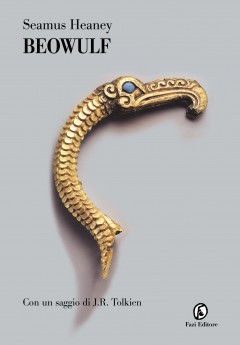
Seamus Heaney
Il governo della lingua
Prose scelte 1978-1987
A cura di Massimiliano Bacigalupo
«Nel 1939, l’anno che Patrick Kavanagh arrivò a Dublino, una mia zia piantò una castagna in un vasetto di marmellata. Quando cominciò a schiudersi la zia ruppe il vasetto, fece una buca e trapiantò la piantina sotto una siepe davanti a casa. Col passare degli anni, la pianta divenne un alberello che crebbe sempre più alto sopra la siepe di bossi. E col passare degli anni cominciai a identificare la mia vita con quella del castagno».
Il governo della lingua raccoglie una scelta delle migliori prose di Heaney, scritte tra il 1978 e il 1987. Il grande poeta, Premio Nobel 1995, si volge al tema complesso del compito della poesia nel mondo moderno. Partendo dal principio che la lingua governa e crea il mondo, ma che la forza della stessa lingua è nella sua misura, la sua riflessione si muove tra questi due poli: libertà e governo. Commentando gli anglosassoni Eliot, Larkin, Walcott, Kavanagh, Auden, e poi i poeti dell’Est europeo Mandel’stam, Milosz, Holub, Herbert e le poetesse Plath e Bishop, Heaney ci offe una sensibilissima guida critica all’etica della poesia, ma anche lo straordinario bilancio di un secolo di lirica.
«Heaney ci conduce qui alla motivazione profonda del suo fare poesia».
Saverio Simonelli, «L’Avvenire»
«In queste pagine c’è la curiosità predatoria di chi cerca di scoprire i segreti del mestiere degli altri… le questioni principali rimbalzano da una parte all’altra del libro: nel tempo che cancella e annienta, la poesia moderna acquista l’incomparabile valore di ciò che è sopravvissuto».
Ermanno Krumm, «Il Corriere della Sera»
– 04/09/1998
Alle origini della poesia: riflettendo sulla genesi e il significato del “canto”
VISIONI A BRACCETTO DI DANTE
Una raccolta di saggi del Premio Nobel Seamus Heaney
Essere poeta per un uomo come Seamus Heaney, la cui identità coincide inevitabilmente con la terra d’origine, è una scelta difficile e tormentata, perché i suoi versi riflettono le molteplici tensioni di una regione carica di storia come l’Ulster, dove si intrecciano due lingue e due sensibilità in un equilibrio instabile, minato dalle conseguenze di una guerra civile violenta e sanguinaria”. Con queste parole un critico presentò nel 1992 al pubblico di lingua e cultura italiana il futuro premio Nobel per la letteratura introducendo “Station Island”, la prima raccolta tradotta nella nostra lingua. Da tempo figura centrale nella cultura inglese contemporanea, Heaney ha trovato spazio nella nostra area culturale solo dopo aver ricevuto il Nobel nel 1995. Oltre ai versi, ora stanno uscendo anche le prose, che costituiscono una parte affatto secondaria della produzione di un autore che ha insegnato a lungo all’Università di Oxford. Come avevamo anticipato su queste colonne nel febbraio scorso (si veda l’edizione del “Corriere del Ticino” del 28 febbraio), l’editore Fazi, che già aveva proposto “Preoccupazioni”, un’antologia di interventi composti tra il 1968 e il 1978, ha mandato in libreria “Il governo della lingua” ( 227 pagine, 32.000 lire), riflessioni sul tema dei compiti e dei limiti della poesia nel mondo moderno, apparse tra il 1978 e il 1987. Il curatore Massimo Bacigalupo spiega in un nota introduttiva: “Leggiamo questi saggi con attenzione sospesa, come un’opera poetica. Vi troviamo spesso affermazioni memorabili, una straordinaria capacità di organizzare senza fatica un vasto materiale. Heaney è sempre personalmente impegnato, non si nasconde dietro i “si dice”, i giudizi acquisiti, sa andare oltre il personalismo. E poi ci racconta le sue parabole fondanti: quella dell’albero di castagno suo coevo, che non a caso apre il libro, e quella dell’evoluzione del poeta, interpretata sulla base dell’esperienza di Wordsworth. Da ciò emerge la conclusione imprescindibile che la poesia deve saper trovare la propria autonomia, perché solo così è in grado di rispondere alle pressioni del quotidiano”. L’autonomia, a giudizio di Heaney, si conquista proprio mediante “il governo della lingua”, un fiume in cui gli piace nuotare, dove egli si trova particolarmente a suo agio. La ricerca sulla parola accomuna da un secolo molti artisti irlandesi pur diversi tra loro (Wilde, Joyce, Yeats, Beckett, Roddy Doyle o Tom Paulin), tutti capaci di affascinare il pubblico con invenzioni sorprendenti, a volte al limite della comprensibilità. Le ragioni di questa caratteristica sono complesse, ma possono essere radicate nel rilievo dato, nelle scuole irlandesi, alla filologia, al latino e all’italiano, e nell’amore per Dante. L’interesse di Heaney per il grande poeta trecentesco, cosa che lo accomuna a Joyce, ha implicazioni formidabili nell’invenzione linguistica e soprattutto nell’aspetto visionario dei suoi versi. Con il risultato che trascendenza e storia, presente e passato, riescono a raggiungere una forza espressiva che sorprende anche per sua non comune continuità. E’ una scelta che Heaney ha maturato dopo essersi lasciato alle spalle un’intesa militanza politica. “A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta – spiegò in un’intervista rilasciata in Italia in occasione della consegna del Premio Flaiano – ero impegnatissimo, facevo dimostrazioni, scrivevo sui giornali, avevo abbracciato ogni forma di resistenza pacifica per difendere i diritti civili. Quando l’IRA cominciò le sue azioni terroristiche sentii e dissi che avevamo perso i nostri riferimenti morali. Fu allora che pensai che le minoranze avevano dato uno schiaffo psicologico alle maggioranze. E oggi io non credo che ci sia più bisogno del linguaggio polemico delle minoranze: anzi, tra un secolo sarà l’attuale maggioranza ad essere diventata minoranza. Quindi occorre porsi in una prospettiva di lungo respiro. Mandelstam diceva che un artista deve lavorare per la posterità ed io condivido la sua opinione”. Proprio il poeta russo Osip Mandelstam, preso in esame in contrapposizione a Stalin, è una delle figure centrali di questo volume di saggi. Il conflitto tra i due uomini – il primo chiamato a rappresentare la poesia, il secondo la politica e il potere si è concluso, a giudizio di Heaney, con la vittoria di Mandelstam. Lo stesso contrasto e il medesimo esito si ritrovano negli interventi dedicati agli artisti contemporanei dell’Est (i polacchi Milosz e Herbert, il cèco Holub), dove il conflitto si ripropone in chiave solo un po’ meno drammatica, e nello studio su Dante e sulla funzione esercitata dagli intellettuali nell’Italia del Trecento. “Mandelstam – rileva Heaney – diceva che era responsabilità del poeta lasciare che le poesie divenissero lingua dentro di lui, come cristalli che prendono forma in una soluzione. Egli era il veicolo della lingua, che doveva rispondere non allo stato ma al suono, non ai programmi quinquennali, ma alla fonetica. Morì perché non poté sopprimere in se stesso il bisogno di cantare a suo modo. Si dà il caso che non avesse idee anticomuniste da esprimere, eppure, poiché non cantava come voleva il Cremino, rappresentava una minaccia al potere del tiranno, una minaccia da stroncare. Perciò egli rappresenta l’efficacia del canto in sé, un emblema del poeta come potente ombra sonora. Se pensiamo alla nota del soprano che incrina il cristallo, abbiamo un’altra metafora del modo in cui l’espressione puramente artistica può incrinare la forma ufficialmente modellata dalla verità in un paese totalitario”. E’ attraverso i Mandelstam della conversazione su Dante che Heaney approda dalla “Divina Commedia”: uno dei modelli della sua opera, come egli stesso rivela, il punto di riferimento per conciliare il politico e il trascendente. Anche per lui il percorso da compiere è essenzialmente interiore: i saggi costituiscono altrettante tappe di un confronto con alcuni tra i maggiori esponenti della cultura europea dell’ultimo secolo, a cui si aggiungono le americane Bishop e Plath. Così ogni pagina raccoglie e trasmette ad altri testi una visione del mondo, una griglia per interpretare una realtà intricata e complessa com’è quella contemporanea. O almeno così Heaney auspica che sia. Riassumendo il suo lavoro teorico con una frase di Robert Frost, egli afferma infatti che il suo scopo di fondo è offrire a se stesso e al lettore “una stasi momentanea contro la confusione imperante”.
– 03/07/1998
Una serie di saggi del premio Nobel Seamus Heaney
SEGNI SULLA SABBIA D’ IRLANDA
La poesia di Seamus Heaney, Nobel nel ’95, nato da genitori cattolici nell’Ulster protestante, raccoglie la tradizionale commistione letteraria inglese di quotidiano e soprannaturale ma la risciacqua nella freschezza poetica della sua terra. Così l’apporto irlandese, che ha spesso rivitalizzato le letterature d’Oltremanica, diviene in Heaney simbolo di un modo di salvare e rilanciare la missione della poesia più volte messa in questione in questo secolo dominato da disincanto e sperimentalismo. Nel “Governo della Lingua”, pubblicato in questi giorni da Fazi e che raccoglie saggi e conferenze che risalgono al decennio scorso, Heaney ci conduce alla motivazione profonda del suo fare poesia, illustrandone la capacità paradossale e quasi contraddittoria di realizzarsi come fatto estetico e autonomo. Per ottenere questo risultato è necessaria la compresenza di due requisiti all’interno del mezzo espressivo. Il poeta ha cioè bisogno di una lingua forte e schietta, che legiferi e governi, che abbia la pretesa, come un nuovo Adamo, di dare vita alle cose che essa sola può nominare; ma una lingua che sappia assieme essere anche umile, facendosi governare, modulare e lavorare al tornio dell’esperienza reale e brutale della vita. Governo della lingua, allora, che deve essere contemporaneamente inteso come governo sulla lingua. Heaney si trova in sostanza ad uno dei bivi abituali del Novecento letterario e che, banalizzando, si può semplificare nella scelta tra il predominio della dimensione estetica oppure dell’impegno, tra un’arte orgogliosa e bastevole a sé o un’espressione che sacrifichi la propria interiorità a favore del “messaggio”. Heaney, però, come accennavamo, è l’uomo che evoca e alimenta gli elementi e gli aspetti contraddittori del reale e dell’anima. Lui che in una poesia di “Seeing Things” aveva confidato di aver fede nei contrari, ci spiega ora cosa vuol dire applicare questa poetica e lo fa portando a testimonianza quelle voci che rappresentano il suo Novecento, la sua fonte di ispirazione e confronto programmatico: Yeats, Auden, Eliot, gli americani Lowell e Plath, artisti dell’Est come Zbigniew Herbert, Milosz e Osip Mandel’stam. Si tratta di poeti accomunati da una profonda moralità del messaggio artistico e insieme dalla ricerca dell’espressione pura, di un io radicale, di “versi profondamente veri che ci aiutano a dire nella parte più segreta e presociale della nostra natura “qualcosa del genere lo so anch’io. Sì, è giusto. Grazie per averlo espresso così in parole e così reso in qualche modo pubblico”. Toccando allora il limite più riposto e inviolabile della sua coscienza il poeta si mette misteriosamente ma realmente in contatto con chiunque voglia farsi raggiungere nello stesso luogo della propria, e quell’arte “che mette le considerazioni poetiche ed espressive al primo posto” diventa anche fatto politico, e pur essendo atto presociale diviene socialmente condivisibile. Per questo Heaney ama indugiare su artisti dell’Est, gente che come Mandel’stam ha sperimentato la censura staliniana, i diktat di piani quinquennali che pretendevano dal poeta odi al tiranno o lodi delle centrali idroelettriche. Citando Herbert, Heaney avverte allora che compito attuale del poeta è recuperare dalla catastrofe della storia almeno due parole, senza le quali tutta la poesia è un vuoto gioco di significati e di apparenze: giustizia e verità. Ma nello stesso tempo ci insegna come la poesia in sé sia un atto di liberazione, una rivendicazione e una definizione di quella materia preziosa dell’io che nulla può scalfire. La poesia – per Heaney, che rievoca l’episodio evangelico dell’adultera – è come quei segni vergati da Gesù sulla sabbia: un atto di fronte al quale accusati e accusatori rimangono ammutoliti e che cattura la loro concentrazione: “La poesia assorbe per un certo tempo l’attenzione, funziona non come distrazione ma come concentrazione pura, un punto focale dove il nostro potere di concentrazione si riconcentra su di noi”.
Seamus Heaney
IL GOVERNO DELLA LINGUA PREOCCUPATIONS. PROSE SCELTE
(1968 – 1978) Fazi – pag. 219 – Lire 30.000
I precedenti premi Nobel irlandesi, George Bernard Shaw, William Butler Yeats e Samuel Beckett erano protestanti anglo-irlandese (normanno) cattolico ma fu obbligato a ricreare e dare statura nazionale a quel che era considerato argot dublinese in esilio. Il premio Nobel per la poesia Seamus Heanoy, di estrazione contadina cattolica del Nord Irlanda, sottolinea invece la piena indipendenza e identità della cultura cattolico-irlandese. Finalmente gli irlandesi “governano” la loro lingua. Heaney usa l’inglese nel modo in cui il vincitore del Nobel Wole Soyinca nato in Nigeria, lo scrive. La raccolta di saggi curata da Massimo Bacigalupo, copre il periodo in cui il futuro Nobel veniva conquistando una sua reputazione internazionale; quando la poesia gli sembrava “un piacere colpevole” da far convivere, però con il suo opposto: un certo giubilio. L’amato Osip Mandel’štam, il cui nome compare spesso nel libro cantava nella notte stalinista, credeva nella responsabilità dello scrittore: la poesia doveva divenire una lingua interiore. Per Heaney la creazione di una composizione in versi è un’esperienza di liberazione equidistante dall’autogiustificazione e dall’autocancellazione : “scrivere questi saggi mi ha aiutato a combattere quest’ansia e a verificare ciò che comunque credo: che la poesia come l’amore, è potenzialmente salvifica e possibilmente illusoria” . o come conclude in una sua poesia “crediamo a ciò che sentiamo”. Il saggio “Il paradiso senza luogo. Uno sguardo a Kavanagh” è la celebrazione di un altro poeta della sua rurale contea di Monaghan, il primo che Heaney lesse col piacere della scoperta che il mondo può diventare una parola. Da Kavanagh, Heaney imparò a fondere memoria e immaginazione. Nell'”orbita della luce” Heaney considera la poesia del britannico Philiph Larkin “dove la verità vince la sua bellezza, ai punti”. È lo stesso segno di certa letteratura delle Ex colonie, la cui fedeltà alla parlata delle Indie Occidentali conduca vicino al genio della lingua inglese , al punto di possederlo pure più profondamente. Heaney parla poi di traduzione e della letteratura oppressa dell’Europa comunista. Czeslaw Milosz, Zbigniew Herbert e Osip e Nadezda Mandel’štam. “Poco a poco, i poeti di lingua inglese hanno sentito la necessità di guardare a Est e sono stati costretti ad ammettere che il baricentro della grandezza sta lasciando la loro lingua. Siamo tanto più sensibili alle traduzioni che giungono come messaggi da coloro che sono avari di parole e sono molti più avanti sulla strada da noi non presa… quando leggiamo traduzioni di poeti russi e dell’Europa orientale siamo proprio sull’orlo e ancora l’interrogazione continua”.
– 03/01/1998
Heaney, la poesia al potere per rendere libero il mondo
” I poeti sono i legislatori non riconosciuti del mondo”, diceva Shelley. E il motto riecheggia anche nelle pagine del libro “Il governo della lingua” (Fazi; pagg. 227, lire 32 mila) che raccoglie saggi diversi e un corso di quattro lezioni tenute all’università di Kent da Seamus Heaney, poeta e premio Nobel per la letteratura nel 1995. Si tratta di una serie di riflessioni, tutte puntate sul contemporaneo, avverte subito Massimo Bagicalupo nell’introduzione, e di tono squisitamente politico: Heaney si sofferma infatti su quei poeti che si sono confrontati con i grandi sistemi autoritari, fino a sacrificare la vita, come Osip Mandelstam sotto il regime staliniano, per mantenere alla lingua la sua autonomia. Heaney parla anche degli anglosassoni Eliot, Larkin, Walcott, Kavanagh, Auden, Lowell, come dei poeti dell’Est europeo Milsz, Holub, Herbert e di due grandi poetesse come Bishop e Plath: ne viene fuori una grande panoramica della lirica del ‘900 e un ammonimento che l’autore rivolge innanzi tutto a se stesso: “Che io possa sfuggire il miasma del sangue versato / governare la lingua, temere l’hybris, temere il dio / finché non parli nella mia bocca senza impacci “. Il “potere” di governare, per Heaney, è soprattutto un privilegio della poesia: “Nella frattura fra ciò che accadrà e qualsiasi cosa vorremmo accadesse – scrive – la poesia assorbe per un certo tempo l’attenzi0one, funziona non come distrazione ma come concentrazione pura, un punto focale dove il nostro potere di concentrazione si riconcentra su di noi. Questo dà alla poesia il suo potere di governare. Al suo culmine essa vorrebbe, come dice Yeats, afferrare in un unico pensiero realtà e giustizia. Ma anche allora la sua funzione non è di evocazione, transitiva. La poesia è una soglia più che un sentiero, una soglia cui ci si avvicina sempre e da cui sempre ci si allontana, sulla quale lettore e autore subiscono in modi diversi l’esperienza di essere allo stesso tempo convocati e affrancati.
– 03/01/1998
La poesia al potere
Riflessioni di Seamus Haeney
“I poeti sono i legislatori non riconosciuti del mondo”, diceva Shelley. E il motto riecheggia anche nelle pagine del libro “Il governo della lingua” (Fazi; pagg. 227, lire 32 mila) che raccoglie saggi diversi e un corso di quattro lezioni tenute all’università di Kent da Seamus Heaney, poeta e premio Nobel per la letteratura nel 1995. Si tratta di una serie di riflessioni, tutte puntate sul contemporaneo, avverte subito Massimo Bagicalupo nell’introduzione, e di tono squisitamente politico: Heaney si sofferma infatti su quei poeti che si sono confrontati con i grandi sistemi autoritari, fino a sacrificare la vita, come Osip Mandelstam sotto il regime staliniano, per mantenere alla lingua la sua autonomia. Heaney parla anche degli anglosassoni Eliot, Larkin, Walcott, Kavanagh, Auden, Lowell, come dei poeti dell’Est europeo Milsz, Holub, Herbert e di due grandi poetesse come Bishop e Plath: ne viene fuori una grande panoramica della lirica del ‘900 e un ammonimento che l’autore rivolge innanzi tutto a se stesso: “Che io possa sfuggire il miasma del sangue versato / governare la lingua, temere l’hybris, temere il dio / finché non parli nella mia bocca senza impacci “. Il “potere” di governare, per Heaney, è soprattutto un privilegio della poesia: “Nella frattura fra ciò che accadrà e qualsiasi cosa vorremmo accadesse – scrive – la poesia assorbe per un certo tempo l’attenzi0one, funziona non come distrazione ma come concentrazione pura, un punto focale dove il nostro potere di concentrazione si riconcentra su di noi. Questo dà alla poesia il suo potere di governare. Al suo culmine essa vorrebbe, come dice Yeats, afferrare in un unico pensiero realtà e giustizia.
– 03/07/1998
Il Nobel Seamus Heaney e la guerra civile nell’Irlanda del Nord
L’autonomia della lingua e i sistemi autoritari
“I poeti sono i legislatori non riconosciuti del mondo”, diceva Shelley. E il motto riecheggia in queste pagine che raccolgono saggi diversi e un corso di quattro lezioni tenute all’università di Kent da Seamus Heaney, poeta e premio Nobel per la letteratura nel 1995. E’ una serie di riflessioni tutte puntate sul contemporaneo, avverte subito Massimo Bagicalupo nell’introduzione, e di tono squisitamente politico: Heaney si sofferma infatti su quei poeti che si sono confrontati con i grandi sistemi autoritari, fino a sacrificare la vita, come Osip Mandelstam sotto il regime staliniano, per mantenere alla lingua la sua autonomia. Heaney parla degli anglosassoni Eliot, Larkin, Walcott, Kavanagh, Auden, Lowell, come dei poeti dell’Est europeo Milosz, Holub, Herbert e di due grandi poetesse come Bishop e Plath: ne vengono fuori una grande panoramica della lirica del ‘900 e un ammonimento che l’autore rivolge tutto innanzi a se stesso: “Che io possa sfuggire il miasma del sangue versato/governare la lingua, temere l”hibris’, temere il dio/finché non parli nella mia bocca senza impacci”. Il ‘potere’ di governare, per Heaney, è soprattutto un privilegio della poesia: “Nella frattura fra ciò che accadrà e qualsiasi cosa vorremmo accadesse scrive – la poesia assorbe per un certo tempo l’attenzione, funziona non come distrazione ma come concentrazione pura, un punto focale dove il nostro potere di concentrazione si riconcentra su di noi. Questo dà alla poesia il suo potere di governare. Al suo culmine essa vorrebbe, come dice Yeats, afferrare in un unico pensiero realtà e giustizia. Ma anche allora la sua funzione non è di evocazione, transitiva. La poesia è una soglia più che un sentiero, una soglia cui ci si avvicina sempre e da cui sempre ci si allontana, sulla quale lettore e autore subiscono in modi diversi l’esperienza di essere allo stesso tempo convocati e affrancati.
– 05/03/1998
I grandi poeti indagati dal Nobel iralndese
Con Heaney inseguendo Coleridge
Patate d’Irlanda e sassolini che scricchiolano sotto le suole di Wordsworth e Coleridge: è così che Seamus Heaney parla di poesia. Distingue il rumore dei loro passi sulla ghiaia, come il suono dei loro versi. E’ soprattutto qualcosa di fisico, di biologico che cerca, anche se la sua fronte continua a sbattere sulla vetrina della letteratura. Ma la mente, per fortuna, è più veloce e aggira l’ostacolo. Inseguendo le interruzioni della pagina, i passaggi e i buchi “che conducono il lettore dall’altra parte” del vetro, arriva in un luogo in cui la poesia ha un solo comando e dice “devi cambiare la tua vita”. Niente lirismo, dunque, solo la responsabilità di dire il vero. Tra quanti ci hanno provato, tre poeti, il russo emigrato Iosif Brodskij, il caraibico Derek Walcott e l’irlandese Seamus Heaney – premi Nobel, rispettivamente, nell’87,’92 e ’95 – incominciano un dialogo a distanza. Dalla loro posizione insieme istituzionale e lontana dal centro dell’impero, tracciano delle linee di forza, individuando quella che oggi possiamo chiamare la grande tradizione poetica del Novecento. Morto Brodskij il discorso comune si interrompe. Lo possiamo ricostruire nei saggi adelphiani del russo e negli scritti di Heaney, prima Iattenzioni e ora Il governo della lingua. In queste pagine, scritte fra il ’78 e l’87, c’è la “curiosità predatoria” di chi cerca di scoprire i segreti del mestiere degli altri. L’orizzonte è ampio: da Hopkins a Eliot, Lowell, Plath, Auden, Mandel’stam, Hebert e Milosz. Le questioni principali rimbalzano da una parte all’altra del libro: nel tempo che cancella e annienta, la poesia moderna acquista l’incomparabile valore di ciò che è sopravvissuto. E non è poco, “nel vasto panorama di violenza e futilità” (Eliot) che è la storia contemporanea.
– 05/01/1998
Orecchio e pensiero, la poesia é contraddizione
A dieci anni dall’edizione originale esce, presso Fazi, a cura di Massimo Bacigalupo, “Il governo della lingua”. Sono diciassette saggi dell’irlandese Seamus Heaney, premio Nobel per la letteratura 1995, uno dei massimi poeti di lingua inglese viventi. “Governo della lingua” significa due cose opposte: “lingua governatrice” e “lingua governata” (dall’intelletto o dallo Stato). Il libro esplica ciò che il titolo implica: fa convivere i due opposti, illustra le ragioni dell’uno e dell’altro, e i modi in cui si sono incontrati e scontrati in alcune voci decisive di questo secolo. L’orecchio che ausculta quelle voci, e all’interno delle voci la guerra civile degli opposti pretendenti al governo, é palesemente dotato, per dirla con Wordsworth, di una “sensibilità organica superiore al comune”; ma altrettanto palesemente il possessore di quell’orecchio ha “pensato a lungo e profondamente”. Di conseguenza, in questi saggi orecchio e pensiero, come i consoli della repubblica romana, risultano esercitare contemporanenamente una doppia magistratura suprema. Bisogna anche dire, però, che l’autore ha goduto del, diciamo, privilegio di vivere alcune contraddizioni come contraddizioni concrete e immediate, prima che come oggetto di riflessione, il che non ha mancato di andare a vantaggio dell’interesse della riflessione stessa. Il libri inizia con un ricordo del 1972, mentre l’autore, a Belfast, sta per entrare negli studi della BBC per registrare delle poesie. Lo accomagna il cantante David Hammond, che deve registrare delle canzoni. Ma prima di entrare si sentono esplosioni, sirene, ambulanze: ci sono dei morti, gli agenti di sicurezza all’ingresso manifestano “una certa aggressività”. In questa atmosfera né Hammond né Heaney riescono a “tirar fuori la voce”, perché entrambi si sentono, “a livello del tutto immediato e ovvio”, che la voce sarebbe suonata come “irrispettosa del dolore”. Ma perché? si chiede Heaney, passando a una considerazione riflessa dell’immediato e dell’ovvio. Perché mai le “gioiose affermazioni della musica e della poesia” dovrebbero cstituire “un’offesa alla vita”? E nel tentativo di rispondere si ritrova a capire da dentro la situazione di Wilfred Owen e di quei poeti della prima guerra mondiale che per primi, nel XX secolo, sentirono incrinata la certezza circa la keatsiana consonanza di verità e bellezza, e che nel tentativo di far prevalere e governare la verità si ritrovarono paradossalmente a produrre una nuova bellezza… E, continuando a riflettere su queste e consimili contraddizioni, Heaney si ritrova a capire in qualche modo da dentro anche la situazione dei poeti dell’est, perché “vi é qualcosa nella loro situazione che li rende vicini a un lettore che si é formato soprattutto in Irlanda”. Così quei poeti tornano spesso nel libro, a comiciare da Mandel’stam, per il quale Heaney sembra nutrire una venerazione non inferiore a quella tributatagli da Brodskij. C’é da dire, tuttavia, che nel fervore con cui Heaney porge orecchio alla poesia di Mandel’stam, Milosz, Holub e Herbert la distanza della loro situazione sembra giocare un ruolo certo non inferiore a quello della “vicinanza”. E infatti, di fronte alla nota “credibile, desolata e vivificante” che vibra nela voce di alcuni di quei poeti, “il letterato di professione” dell’Occidente non può non provare una certa ambivalenza. Il poeta occidentale non può non sapere che “la macchina che crea reputazioni e distribuisce libri”, benché lo promuova con astuzia ed estro, é comunque del tutto indifferente alla “forza etica e morale della poesia che tratta”, il che certo non poteva dirsi dei veccchi censori totalitari. Ed ecco che il fruitore della “libertà consumistica” giunge quasi a invidiare l’autenticità delle “vite tragicamente saggiate” di coloro cui toccò inoltrarsi per una strada che non abbiamo preso “perché fortunatamente non ci era aperta”. Mandel’stam, per esempio, dove avrebbe trovato tutta quella “libertà interiore”, quell’ “assoluto sentimento di essere nel giusto” nell’atto stesso di abbandonarsi al più sfrenato gioco e di assoggettarsi completamente al governo della lingua governatrice, se non in presenza di un governo che pretendeva invece di governarla lui? Solo nel totalitarismo, infatti, una lingua e una poesia che rifiutano di venir governate diventano per ciò stesso “una forma di governo alternativo, o di governo in esilio”. Così quando Heaney passa invece ad ascoltare la poesia dell’Occidente liberale e anglosassone, ecco il governo far capolino, introiettato, sotto forma di “autodisciplina”, di “autolimitazione” – e cioé la necessità di appagare comunque, anche se in altro modo, le “inclinazioni morali” e il “nobile cavaliere dell’intelletto”, i quali vogliono anche loro partecipare al governo, e non riescono più a venir soddisfatti dalla mera opposizione al governo altrui. Ecco dunque Eliot, che nei “Quartetti” passa ad assumere il governo sulla sua stessa lingua “come un mesto grand seigneur”, meditativo, autorevole, ma anche un po’ tristemente consapevole di una perduta “vitalità e noncuranza”. Ecco Larkin, in cui “la verità vince ai punti sulla bellezza”, anche se Heaney ha poi un occhio di lince nell’individuare tutte le “imprevedibili incursioni nel puro essere”, tutti gli struggenti “buchi simbolisti” di cui é crivellato lo “splendore infinitamente neutro” della sua scrupolosa e disillusa poesia. Ecco l’ “Orfeo” di Auden che chiede: “Cosa desidera il canto…Essere confuso e felice/ o soprattutto conoscere la vita?”. Ed ecco il giovane Auden abbandonarsi felicemente alla libertà di Ariele, ma solo per rivelare che le sue confuse promesse di liberazione “sono in definitiva illusorie”. Ed ecco l’Auden maturo cosegnarsi invece a Prospero, imbrigliando la propria poesia “nel progetto razionale di assicurare all’umanità una sicurezza cosmica”. Ecco la meravigliosa Elizabeth Bishop, poeta “tra i più reticenti e controllati”, che si sottomette alla disciplina dell’osservazione, perché “l’osservazione é di per sé una manifestazione di obbedienza, un’attività contraria a sommergere i fenomeni con la soggettività”. Ma in un’acutissima analisi di “At the Fishhouses” vediamo al rallentatore quella stessa soggettività che, a lungo trattenuta, alla fin fine trabocca e travalica in un grande e unico salto “il proprio pudore obbediente”. Il libro, di una ricchezza e originalità di cui é impossibile dar conto, finisce in un drammatico crescendo con un’analisi di alcune delle ultime poesie scritte prima dl suicidio da Sylvia Plath, la poetessa che “giunse al punto di permettersi l’indentificazione con l’oracolo e si concesse come veicolo di possessione”. Sono poesie in cui “la lingua assume con ebbrezza il ruolo di governatore”, e che rappresentano dunque “il trionfo dell’ambizione romantica”. Heaney riesce ad ascoltare con orecchio completamente partecipe e aperto tutto l’irrefutabile trionfo di quelle poesie. Di fronte a questo estremo esito occidentale di dittatura della lingua, comunque, Heaney torna a sentire l’attrazione per l’Est, e cioé per la saggezza di una poesia che ha avuto il privilegio di essere “tragicamente saggiata” da un nemico esterno invece che interno. Le considerazioni puramente poetiche, ribadisce Heaney, vanno mantenute al primo posto, alla lingua deve essere concessa la sua libertà se vogliamo che la poesia sia viva. E tuttavia é possibile sentire tutto questo e al tempo stesso condividere con Czeslaw Milosz l’insofferenza per la “tirannia” della “presunzione romantica”. Heaney procede a citare per intero “Ars Poetica”, e in effetti la poesia risulta stranamente appropriata dopo quelle della Plath. Mitosz vi manifesta spudoratamente la sua apisrazione a una firma che permetta di “comprendersi senza esporre nessuno/né l’autore né il lettore, a sofferenze sublimi”. Nella poesia c’é “qualcosa di indecente”, balza fuori da dentro come “una tigre”, e perciò “giustamente si dice che é dettata da un daimon,/benché sia esagerato sostenere che debba trattarsi di un angelo”. E tuttavia “quale uomo ragionevole vuole essere dominio di demoni/ che si comportano in lui come in casa propria” e “cercano per proprio comodo di cambiarne il destino?”. Il fatto che “ciò che é morboso é oggi apprezzato” non toglie che ci sia stato un tempo “in cui si leggevano solo libri saggi/che ci aiutavano a sopportare il dolore e l’infelicità”. Di conseguenza “é lecito scrivere versi di rado e controvoglia,/spinti da una costrizione insopportabile e solo con la speranza/che spiriti buoni, non maligni, facciano di noi il loro strumento”. Il libro si chiude con un lungo brano della prosa potentemente tortuosa e goffa di Wordsworth, che con fatica e serietà cerca di sprigionare discorsivamente quel qualcosa di fondamentale importanza che con tanta leggerezza e perspicuità prende alle volte il volto nella sua lirica. E’ un brano fin troppo celebre, ma il contesto in cui Heaney lo inserisce gli ridà freschezza e urgenza. “Tutta la buona poesia”, scrive tra l’altro Wordsworth, “é il traboccare spontaneo di sentimenti forti; ma per quanto ciò sai vero, nessuna poesia a cui si attribuisca qualche valore fu mai scritta su qulasiasi argomento, se non da uomo che, possedendo una sensibilità organica superiore al comune, abbiia anche pensato a lungo e profondamente”. Il flusso dei sentimenti, infatti, viene modificato dai nostri pensieri, per il buon motivo che quei pensieri non sono a loro volta altro che il frutto e i rappresentanti di “tutti i nostri sentimenti passati…”. La poesia, conclude Heaney, resta dunque “un raid nell’inespresso”, ma il valore del bottino riportato dipenderà anche dalle “capacità emotive, le risorse intellettuali e la civiltà generale che il poeta saprà conservare tra un raid e l’altro”.
– 09/01/1998
Seamus Heaney
Il governo della lingua
“Lo scrittore deve guadagnarsi il diritto di esercitare l’arte, deve pagare come Cechov, il suo debito alla medicina. Così facendo, non sarà mortificato dal dolore che lo circonda perché ne avrà assunto senza battere ciglio la responsabilità”. Sin dal primo saggio che apre questa seconda, straordinaria raccolta di saggi critici di Seamus Heaney, pubblicata con rara sollecitudine editoriale a breve distanza dalla prima, a cura e con lucida introduzione da Massimo Bagicalupo, il lettore è direttamente introdotto ai temi centrali della riflessione artistica del poeta irlandese. La considerazione della funzione, del ruolo e della responsabilità del poeta nei confronti della comunità di appartenenza e della società in genere in rapporto tanto al piacere generato dall’esercizio dell’arte quanto alle compatibilità dei doveri che tale pratica impone. Si tratta di preoccupazioni che tengono insieme la prima silloge critica, Preoccupations (Attenzioni, vedi “Poesia” n.116, aprile 1998) del 1980 e che informa anche l’ultima, The Redress of Poetry, del 1995, altro splendido excursus nel campo del meraviglioso. Il doppio genitivo del titolo si riferisce a due forme di governo: quello della lingua romanticamente e visionariamente legislatrice e quello in cui la lingua è governata sia da circostanze esterne sia dalla stessa propensione del poeta a sottoporla all’inventario della ragione”. Si tratta di saggi che sono, come avverte il curatore, da considerarsi opera poetica a tutti gli effetti e in cui uno dei tratti rilevanti è l’apparente assenza di ogni forma di “ansia d’influenza”. Il poeta-critico accompagna il lettore alla scoperta e al godimento delle istanze esemplari di governo della lingua nelle opere dei suoi antecedenti. Nella prima sezione sono, queste istanze, rappresentate dalla poesia della “libertà interiore” del contemporaneo Kavanagh, dalla incursioni nel visionario, di un poeta, Larkin, programmaticamente refrattario a simili avventure; dalle “visioni di sogno” di Derek Walcott, e infine dalla produzione di tre grandi poeti dell’Europa orientale, Holub, Milosz, Herbert. Figure cui, al pari di Wilfred Owen e Osip Mandel’stam, è toccato in sorte il ruolo del testimone. Non hanno dominato la lingua per adeguarsi alle durissime circostanze esterne o per compiacere i potenti di turno. Hanno lasciato che la lingua governasse, persino quando sembravano affermare il contrario, come nel caso di Owen o Herbert. Sia per loro sia per Heaney, Osip Mandel’stam si staglia come mentore ideale, figura esemplare di artista e di testimone. La sua opera è allo stesso tempo modello di libertà conquistata a caro prezzo, dono che non può essere governato, poesia che si scrive da sola. Non manca, Heaney, di rendere omaggio al coraggio e all’integrità di Nadezda Mandel’stam, compagna e incrollabile custode dei versi del poeta, garante del suo lascito attraverso l’alta qualità della sua scrittura. La seconda sezione, che contiene il ciclo di conferenze intitolate a T.S. Eliot e tenute all’università di Kent nel 1986, si apre col saggio che dà il titolo al libro ed è seguito dagli interventi su Auden, Lowell e Sylvia Plath. Anche in questi magistrali “sondaggi” l’attenzione del critico è volta a segnalare quei momenti in cui il “governo della lingua” s’impone: il primo Auden, le raccolte centrali per Lowell, e l’ultima straordinaria fase creativa per Plath, con poesie “che sembrano essere venute alla luce in un obbedienza a un comando imprevedibile ma assolutamente irresistibile”. Un “tumultuoso affare”, la definizione che Heaney dà della “Conversazione su Dante” di Osip Mandel’stam, si può applicare per ragioni diverse anche a questo libro, ma in particolare al saggio eponimo che contiene lo sfavillante close reading di “At the Fishhouses” di Elizabeth Bishop e che è tra quanto di più alto sia stato mai scritto sul magistero della poetessa. Le due forme di governo vi sono rilevate e illustrate mentre si mostra quasi al rallentatore il passaggio dal controllo equilibrato del verso da parte della mente vigile del poeta ai primi segnali della “irruzione visionaria”, fino al montare irrefrenabile della marea che travolge le barriere razionali. L’immagine di Heaney riporta alla mente la definizione di Mario Luzi in un’intervista con Doriano Fasoli: “Il punto di partenza di una poesia è qualcosa che viene dal fondo, è come il baricentro di un piccolo terremoto, come un’onda che sale”. Il poeta diviene allora, secondo le parole di Anna Swir, “l’antenna che capta le voci del mondo, un medium che esprime alo stesso tempo il suo inconscio e quello collettivo”. “What is my apology for poetry?”, si domandava Heaney in uno dei sonetti di Glanmore in Field Work. Questi saggi costituiscono la migliore risposta a quella domanda.
Libri dello stesso autore
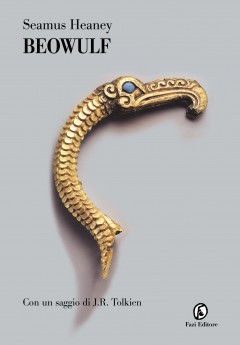
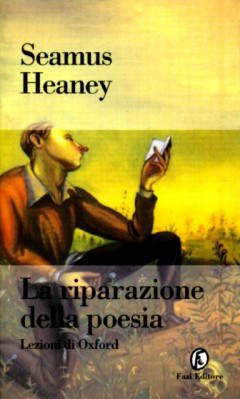
La riparazione della poesia
Seamus Heaney