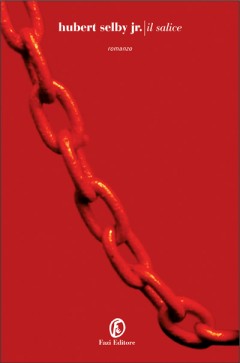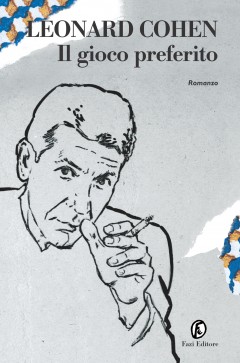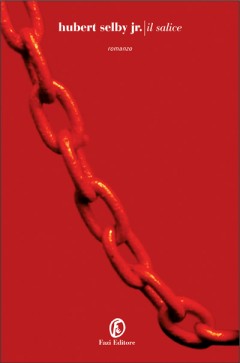
Hubert Selby Jr.
Requiem per un sogno
Traduzione di Adelaide Cioni e Grazia Giua
Il sogno americano è morto. Da un pezzo. Ma ognuno ha la sua droga per continuare a sognare: l’eroina, la televisione, il cibo. “Burqua” occidentali per evitare di guardare in faccia la realtà. Requiem per un sogno è la storia del “risveglio” di quattro personaggi, legati dalle illusioni di cui si nutrono per sopravvivere, e della loro lenta discesa all’inferno. Un “risveglio” scandito in varie stagioni. L’estate: Sara Goldfarb è una vedova che ha fatto della televisione il centro della sua esistenza e “comunica” solamente col presentatore di un improbabile show televisivo, profeta di una dieta miracolosa. Sara ha grandi sogni per il figlio ventenne Harry, che passa le giornate a fantasticare di aprire un café bohemien insieme a Marion, la sua ragazza. Che abbiano bisogno della loro dose quotidiana di eroina per sognare non sembra essere un problema per il momento. Insieme all’amico Tyrone C. riescono a mettere da parte un mucchio di soldi smerciando eroina e tutto sembra andare alla grande. Ma l’estate se ne va velocemente. È arrivato l’inverno, e con esso la fine dei sogni. Il delicato castello di sabbia che i quattro protagonisti hanno costrutito intorno a sé comincia a sgretolarsi. Caratterizzato da una scrittura vibrante e “sensoriale”, Requiem per un sogno rappresenta l’altra faccia del sogno americano con una crudezza che non ha pari, ma forte di una commovente capacità di penetrare e descrivere la psicologia umana, le sue debolezze, il suo bisogno d’amare e di credere, nei suoi momenti di pura grazia, nella fede che ci sarà comunque, altrove, un’altra possibilità. Questa è la prima traduzione italiana di Requiem per un sogno che, pubblicato originariamente nel 1978 e da molti considerato il vertice dell’opera di Selby jr, ha ispirato il film cult di Darren Aronofsky con Jared Leto e Jennifer Connelly.
– 01/06/2004
HUBERTSELBYJR.
Quando Hubert Selby Jr. è morto, a 75 anni, il 26 aprile scorso per le conseguenze di una vecchia tisi mai guarita, gli restavano solo il titolo di “grande della letteratura americana”,un pezzo di polmone e pochi volumi pubblicati come tracce dei suo percorso dentro un mondo privo d’amore: “E’ la mancanza d’amore il tema di tutti i miei libri”, disse più di una volta “perché un mondo senza amore è un mondo terribile”. E, come un patologo che guarda un cadavere, Selby Jr. osservava la carogna in decomposizione dei bassifondi dentro cui era vissuto. Quei ghetti dell’umanità che marcisce e si degrada, ridotti a ciò proprio dagli amori negati per mancanza di responsabilità o per l’ambizione di costruire la vita sull’illusione. New York, e più precisamente Brooklyn: era questo il corpo duplicato nei corpi dei suoi antieroi, anonimi individui che si mettono ai margini dell’esistenza perché ne perdono implacabilmente il controllo che lui, con il linguaggio della vita così com’è, raccontava. Lo sbando di gente come Tralala, la puttana di Ultima Fermata A Brooklyn che finisce violentata; il sindacalista omosessuale Harry, che adesca un ragazzino e poi viene crocifisso a un cartellone dai ragazzi del bar del Greco,”e loro giù a dargli pugni e calci fino a che si stacca dall’insegna”; la ‘finocchiona’ Georgette con le sue illusioni sentimentali. O come il recluso de La Stanza con le ossessioni del suo isolamento; la ricoverata in clinica psichiatrica di Sto Buona, dentro la paranoia delle voci che spera “non tornino più”; il personaggio di Rumore nella raccolta di racconti Canto Della Neve Silenziosa preda delle allucinazioni, “che urlava isterico e si rannicchiava contro la parete intanto che il rumore avanzava”; come i tre tossici che sprofondano nel carcere, la dipendenza, la cancrena e la prostituzione; Sara internata in manicomio per anfetamine da dieta in Requiem Per Un Sogno. Selby Jr. parla sempre e comunque di colpe individuali. Le stesse responsabilità che si attribuì per la malattia contratta quando i suoi pensieri erano infetti e colpevoli. “Ho passato parte della mia vita a combattere Dio” disse in un’intervista “per accorgermi poi che non potevo vincere”. E allora tutto il suo universo è un Inferno reso tale quando rinnega Dio, o meglio, quando non se ne cura, Selby Jr. sta lì a guardare con pietà, sapendo che l’unico tentativo di redenzione è nel penetrare così profondamente in punti talmente vulnerabili da costringere ad una visione tanto profonda da rivoltare la coscienza fino allo stomaco. “Spero di far vomitare, disse dopo l’uscita di Ultima Fermata A Brooklyn. Hubert Selby Jr, decise di scrivere quando gli dissero che doveva morire. Decise di scrivere per rigettare il suo male. Con l’esordio di Ultima Fermata A Brooklyn nel ‘64, col successo di una letteratura che avrebbe influenzato gente come Lou Reed (“Burroughs e Selby: cerco di adattare il loro sangue alle mie melodie”), Henry Rollins – che pubblicò per la propria etichetta un disco dei suoi reading del tour europeo dell’89 -, Sting – che l’omaggiò nel nome della sua prima band, i Last Exit – fino al cinema che tradusse l’Ultima Fermata a Brooklyn e Requiem Per Un sogno in due film, la malattia si placò senza guarire mai – Selby poteva solo accettarla, con la consapevolezza che, appunto, non si può vincere contro Dio. Per questo i suoi personaggi soccombono: perché si lasciano andare all’illusione che si possa fare a meno dei divino, o che il divino sia dentro una partita di droga o un quiz televisivo, nella prepotenza o nel tirare avanti le giornate dietro un sogno materiale. Ognuno dei sei racconti di Ultima Fermata A Brooklyn ha come epigrafe un verso dall’Antico Testamento per esseri che “son schiacciati prima di metter l’ali”. E’ una letteratura del Sacro, dunque, accusata più volte di oscenità, quella di uno scrittore che non può “fare a meno di rappresentare tutto quell’orrore”, come disse ancora. L’orrore e il suo rumore di fondo, le “urla in cerca di una bocca”, per giungere, alla fine, al silenzio. Hubert Selby Jr., ormai da più di trent’anni, viveva a Los Angeles per via dell’asma che non gli permetteva di respirare più l’aria di New York. Eppure quell’aria non ha mai smesso di arrivare fino a lui, portando con sé le urla degli esseri perduti che continuava a registrare nei suoi libri cercando sempre il silenzio che avrebbe cancellato tutto. Il Canto Della Neve Silenziosa che nel finale del racconto omonimo avrebbe finalmente dato pace a tutte quelle grida. Un canto sereno e gioioso da dividere con la persona che si ama. “Per tenerle la mano”.
– 01/02/2004
Hubert Selby jr.
Hubert Selby Jr è stato il primo scrittore ad affrontare i temi più luridi della società americana, senza nascondersi nella prospettiva sociologica di chi guarda verso il basso armato di cultura. Per chi ha letto Irvine Welsh, Requiem per un sogno potrebbe sembrare apparentemente datato, visto che il romanzo risale al 1978 ed esce nel nostro paese solo adesso, fuori tempo massimo per essere ancora innovativo dal punto di vista del linguaggio. Ma la qualità spietata dell’autore di Brooklyn, oggi quasi ottantenne, arriva tutta nello stomaco. E a differenza dell’autore scozzese, Selby non racconta il lato grottesco del marcio, ma quello disperato. Non ci sono nemmeno virgolette, paragrafi, giri di punteggiatura: solo blocchi inesorabili di parole che scorrono a velocità costante verso la base della spirale. Un gruppo di tossici che si ritrovano a farsi all’obitorio del Bronx, una casalinga ossessionata dalla tv e dalle pillole dimagranti, Harry, Tyrone e Marion che non riescono a vedere lo sfascio delle loro vite: tutti vivono di speranze, dipendenze e fallimenti. È una lettura tosta, ma i calci sono dati talmente bene, che prenderli nello stomaco è un piacere.
– 12/12/2003
A ciascuno la sua droga
La cosa che interessa di meno, in questo “Requiem per un sogno” di Hubert Selby jr. (Fazi) – romanzo uscito negli States venticinque anni fa, e portato sugli schermi nel 2000 dal sopravvalutato Danner Aronofsky, interpreti Ellen Burstyn, Jennifer Connelly e Jared Leto – è la storia, il plot, la vicenda. Uno spaccato fine Settanta della Coney Island cara a Lou Reed (che di Selby jr. è fanatico, oltre che amico), fra madri drogate dalla televisione e figli che si sbattono da mane a sera per procurarsi ben altra droga – fino a impegnare la “droga” materna, appunto la scatola televisiva, in cambio di pochi spiccioli vitali. La contrapposizione fra questi due tipi di tossicodipendenza (mediatica e chimica) è già uno schemino tutt’altro che inutile a mettere a fuoco la temperie del libro (ognuno ha la sua droga, non si scappa). Libro la cui trama, dicevamo, non è poi così decisiva. Primo: perché per ambientazione, motivi e sviluppi – non si discosta granché da quella del capolavoro riconosciuto dell’ormai settantacinquenne narratore newyorkese, “Ultima fermata a Brooklyn”. Secondo: perché i cultori di Selby si saranno già visti (su Tele + o in Vhs: il film non è mai uscito nelle nostre sale) la pellicola. E poi insomma, diciamolo una volta per tutte, non sta nella “materia” l’originialità di questo scrittore…
Giacché di romanzi che ci raccontano come il nostro universo sia ormai preda di droghe che lo svuotano di senso riducendolo al simulacro virtuale (e malato) di se stesso, ne abbiamo letti millanta e uno (a partire da quelli del sommo Philip K. Dick).
Idem dicasi per le storie destinate a finir male: reietti che annaspano nel pantano, poi arriva un grande sogno (fosse anche la partecipazione a un quiz televisivo) che potrebbe ripulirli dalla melma: ma è tardi; troppo tardi – e per il sogno non si può recitare che un livido requiem. No. L’originalità di Selby jr. sta nella micidiale macchina da guerra della prosa con cui veniamo affrontati: una colata lavica che impasta e porta al calor bianco, nel suo magma, ogni altro elemento: flash decrittivi, mozziconi di dialoghi, slang; barlumi subito soffocati di interiorità, desideri carnali incontrollabili e nausee omeriche – e allarme, furore, fetore, paura, disgusto. La lezione del miglior Céline viene esasperata da una carica di rabbia e di odio che mette a disagio: l’occhio sbanda schizzato come la “camera” dell’Oliver Stone di “Natural born killers”, le raffiche della paratassi crivellano con esatta ferocia la pagina – e quel poco di luce che più avanti, a Ottanta inoltrati, arriverà a rischiarare il “Canto della neve silenziosa”, qui è ancora sanguinosamente ghermito e sfigurato dagli artigli di un’oscura necessità che non dà tregua a nessuno.
– 01/03/2004
Hubert Selby jr, Il pugile dolce
Un’ipotetica cartografia del romanzo americano contemporaneo, per la voce “Mister Hubert Selby jr.”, potrebbe contare su una certezza geografica, ma soffrirebbe di svariati problemi di collocazione e gerarchie. Se infatti sarebbe facile, persino scontato, etichettarlo come Il Cantore di Brooklyn, assai meno facile risulterebbe individuarne il territorio di azione nel mondo “letterario”, la mappa di lezioni imparate e di lezioni impartite, e ancor meno facile incasellarlo in uno status, in un albero genealogico di filiazioni, eredità, debiti, o affibbiargli addirittura una comoda patente di “maestro”, o “minore”, o “autore cult”. Questo perché Mister Selby, per vocazione, istinto, e direi per la sua stessa storia di scrittore, è estremamente refrattario a stare in un posto qualsiasi di una scacchiera qualsiasi, che non sia quella puramente geosociale del microcosmo urbano di quella parte della Grande Mela che è Brooklyn. Dall’esordio esplosivo di alcuni racconti (uno su una storica antologia di “scrittori beat”, The Beats, 1960, a cura di Seymour Krim) e soprattutto del primo romanzo, Ultima fermata a Brooklyn (e dove, altrimenti?), Selby ha centellinato la sua produzione, ha ottenuto vampate di attenzioni critiche alternate a lunghi soggiorni nell’Oscurità, è stato antipresenzialista per eccellenza, eppure così presente da guadagnarsi da più parti, e da parti talora insospettabili, riconoscimenti di maestro (si veda ad esempio come ne parla Lou Reed nel libretto che accompagna The Raven, ove lo accomuna a Poe e Burroughs, come suoi mentori). Maestro laconico, dunque (sei romanzi e una raccolta di racconti in quarant’anni di lavoro), e per nulla convinto di essere maestro di alcunché, Mister Selby è una bomba a tempo, è un pugile dolce che periodicamente si affaccia sul nostro ring e ci assesta un uppercut esemplare, per poi tornare in quella vita di cui si sa così poco, senza nemmeno il vezzo salingeriano di una privacy maniacale: si sa poco perché non c’è nulla da sapere, direbbe lui. Allora, se la sua posizione nel panorama narrativo è così defilata e al contempo così forte, sarà qui inutile tentare di inchiodarla con un segnaposto troppo stabile, o provare a stilare ipotetiche classifiche, imbastire una bella museificazione, dare una bella pagellina a un autore tanto elusivo. Meglio, forse, fissare alcuni punti che impostino, più che portare a termine, un abbozzo critico che cerchi di illuminare aspetti noti (vulgo: luoghi comuni critici) e meno noti del “pugile dolce”, senza preoccupazione alcuna di erigere la Statua del Grande Romanziere Americano, o di pronunciare l’Orazione all’Eroe Misconosciuto. L’occasione, oltretutto, c’è ed è ghiotta: la recente traduzione di Requiem per un sogno, uscito da Fazi (traduzione di Adelaide Cioni e Grazia Giua, pp. 261, euro 15,00), sulla scia del film di Darren Aronofsky, girato nel 2000 e sontuosamente maltrattato dalla distribuzione italiana, su sceneggiatura scritta dal regista e dallo stesso Selby, e con interpreti principali come un’eccezionale Ellen Burstyn e gli ottimi Jared Leto, Jennifer Connelly e Marlon Wayans. La traduzione, certo, è tardiva (il romanzo è del 1978), ma ben venga anche ora, ben venga anche a traino del film: questo era un libro che andava tradotto. Più compatto di Ultima fermata a Brooklyn, che è testo assai più corale e solo apparentemente dispersivo e difficile, più “aperto” del claustrofobico La stanza, seconda, tremenda opera di Selby, tutta ambientata in una stanza e nella mente di un carcerato, Requiem per un sogno è la storia di due nuclei narrativi, quello composto dal trio di giovani sbandati Harry e Marion (che formano una coppia) e Tyrone, un nero, e quello costituito dalla monade dolente di Sara, madre di Harry. L’occhio solo in apparenza impassibile dell’Autore ne segue le relative, ineluttabili catabasi nell’Ade urbano, con una scansione lenta e inesorabile, da un inizio quasi da commedia (si veda la scena dell’amico Tony che spara al televisore con battute da John Wayne, o Sara che incatena il suo apparecchio TV al termosifone, per evitare che il figlio glielo vada nuovamente a impegnare) fino a una serie di apici di clima scespiriano: i quattro inseguono tutti un sogno, anzi un Sogno, che in questa Terra delle Opportunità ribaltata e deviante ha poca ragione di essere, e si tramuta in un Incubo. Che si cerchi la Madre di Tutte le Partite di Droga, quel “mezzo chilo di pura” dall’evidente valenza simbolica, come fanno i tre ragazzi; oppure che si sogni di partecipare a un idiota programma televisivo come unica chance di riscatto a un’esistenza di rimpianti, ricordi, desolazione, com’è per Sara: il Sogno è Incubo, i giorni del vino e delle rose sono giorni di aceto e decomposizione, e qui se ne recita un impietoso, straziante Requiem. Chiaramente, un riassunto del genere non può in alcun modo descrivere cosa sia Requiem, né può sognarsi di farlo una disamina, anche prolungata, del suo stile, del suo ordito narrativo, che sono sempre “impegnativi”, che chiedono molto a chi legge (meno che Ultima fermata, ma sempre molto) ma che comunque ripagano lo sforzo, e con gli interessi. È una voce avvolgente, che lega inestricabilmente a sé, in cui per esempio la soppressione delle virgolette non è mero artificio grafico ma ha una sua ragione d’essere, e concorre con tutto il resto a creare quel ritmo che è di Selby e di nessun altro, e a fondare quell’esperienza che, come ha detto lui stesso in una nota intervista (tra le rare interviste) per lui deve essere la lettura dei suoi libri. È, Requiem, formalmente un romanzo sulla droga ma non è I ragazzi dello zoo di Berlino, è casomai parente di un’opera che gli è vicina non di area né di stile, non di “genere” né di trama, ma quantomeno cronologicamente, per visionarietà e per dolore esperito, è cioè
Scrutare nel buio (1977) di P. K. Dick. Di Requiem, nell’introduzione all’edizione americana tascabile, Selby ha detto: “È un libro su cosa succede quando ci dedichiamo, nella vita, più all’avere che al dare.” Vero. Ma è anche, credo, uno pugno formidabile al Sogno Americano, nonché al lettore.
Ma un pugno salutare.
2. Primo luogo comune (inevitabile, direi) della critica su Selby: Bardo di Brooklyn, dei diseredati, delle drag queens, delle prostitute, di un’umanità a brandelli sotto le vivide luci di lampioni, di individui disfatti dalla Droga o dalla Vita, che si limita a
registrare, a filmare con parole, senza alcun intervento da parte sua: quasi che, novello Zola, fosse convinto che la realtà parli da sola, e denunci meglio di un pamphlet di mille pagine sui bassifondi newyorchesi. Giusto, tutto giusto: Selby è calato in mezzo alle cose che descrive, non sputa sentenze, non dà giudizi. narra. Narra, ma non è uno scrittore naturalista dell’Ottocento; lascia cantare il coro disperato, stridulo e dissonante del suo mondo, in Ultima fermata, ma non è il Verga de I Malavoglia; denuncia “gli orrori di un mondo senza amore” (sono parole sue), l’inacidirsi del Sogno, ammette di aver amato Céline, se proprio deve fare un nome di referente letterario, ma non è nemmeno Céline. È un Occhio, dicevo prima, ma da quest’Occhio sempre così attento, sobrio, preciso da far sospettare impassibilità e gelo, talora emerge empatia, un’empatia per nulla esibita, per nulla scontata, forse perdente ma per questo più intensa, dolorosa, viva. Che sia quell’istante che potrebbe
salvare la prostituta Tralala di Ultima fermata, un istante di riscatto negato o, nello stesso libro, il travestito Georgette che recita Poe (non certo a caso) o che, in Requiem, sia Tyrone in cella, ripiegato in posizione fetale, o il candore di Marion che “non si è mai considerata una tossica”, dal canto del fango si innalza una flebile dura voce di amore, che riverbera sulle atrocità narrate e le illumina di tutt’altra luce.
Non sono documentari, le Stagioni all’Inferno dei romanzi di Selby, sono itinerari di umanità impastata di dolore, perdizione e morte, ma proprio per questo umanità, e proprio per questo sono realmente esperienze, qualcosa che mira a valicare la lettura in quanto tale e a immergere, anche violentemente, chi legge in una materia viva, pulsante. È umanità dalla vocazione discenditiva, che qualcosa o qualcuno ha condannato irredimibilmente e che sembra quasi scegliere, con esattezza da tragedia da greca, i sentieri migliori per compiere questo itinerario di catastrofe e autodistruzione, questa nemesi folle, ma che al tempo stesso chiede cittadinanza e dignità anche dall’Abisso.In questo senso, mi pare decisamente corretta la lettura sintetica che Lou Reed, nella già citata introduzione a The Raven, appone come sigla all’intera produzione di Selby, nonché alla sua: “Ho lottato con questo pensiero innumerevoli volte: l’impulso del desiderio distruttivo – il desiderio della mortificazione di sé (.) Cerco sempre di mescolare il loro sangue alle mie melodie. Perché facciamo quello che non dovremmo fare? Perché desideriamo ciò che non possiamo avere? Perché ci innamoriamo esattamente delle cose sbagliate? Cosa intendiamo per ‘male’?”Di recente (dicembre 1999), sulla rivista “Rain Taxi”, a una domanda dell’intervistatore Rob Couteau su quella che ritiene la sua raison d’être in quanto uomo e scrittore, Selby ha risposto: “To be as kind, as gentle, loving as possible”.Essere più che posso gentile, garbato e pieno d’amore.
Strano, per questo pugile.
Ma è un pugile dolce.
Bibliografia e altro
Lo strano è che sono ancora qua, e che di tanto in tanto pubblico un altro libro.
(Hubert Selby jr., “Perché continuo a scrivere”)
Narrativa
In Italia, metà dei romanzi di Selby non è ancora stata tradotta. Si potrà colmare la falla?
Comunque:
» Ultima fermata a Brooklyn
(1964, ed. it. Feltrinelli 1966, ristampato nella “Universale economica” 1989, terza edizione 2000).
» La stanza (1971, ed. it. Feltrinelli 1973).
Un’opera che lo stesso Selby definisce “disturbing”. In Italia è oggi introvabile.
» The Demon (1976).
Un giovanotto che ha tutto, moglie & carriera & soldi, eppure. ha un demone che lo spinge all’efferatezza più totale.
» Requiem per un sogno (1978, ed. it. Fazi 2003)
» Canto della neve silenziosa (1986, ed.it. Feltrinelli 1989).
Quindici racconti scritti in alcuni casi prima del grande successo del primo romanzo e unificati dal nome del protagonista, Harry (che è nome che ricorre sovente nell’opera di Selby, dal sindacalista gay represso di Ultima fermata all’Harry Goldfarb di Requiem, all’Harry White di The Demon).
» The Willow Tree (1998).
È la storia di Bobby, adolescente nero del Bronx in cerca di vendetta, e di Moishe, anziano sopravvissuto ai lager che ha perso un figlio in Vietnam. Una favola sull’empatia e sulla compassione, per un libro controverso, forse meno riuscito degli altri.
» Waiting Period (2002).
Un uomo decide di uccidersi, ma dopo qualche giorno di attesa tramuta tale decisione autodistruttiva nella volontà distruttiva contro incarnazioni del Male vere o da lui presunte. Un altro tour nella paranoia mentale, come era successo per La stanza.
Sceneggiature
» Jour et nuit (1986), film franco-svizzero.
» Requiem per un sogno (2000), insieme al regista David Aronofsky.
» Fear X (2003) di Nicolas Winding Refn, film di prossima (forse) uscita, con il coeniano John Turturro e la Deborah Kara Unger del Crash di Cronenberg.
Comparse cinematografiche
Oltre a un paio di apparizioni televisive in telefilm, Selby compare nei due film tratti da suoi libri. In Ultima fermata a Brooklyn (1989, regia di Uli Edel, con Stephen Lang, Jennifer Jason Leigh, Burt Young, Peter Dobson e Alexis Arquette) è un
automobilista, mentre nel già trattato Requiem per un sogno interpreta, con un paio di battute, un poliziotto sadico. È singolare come la frase: “Voi tossici negri di New York siete delle merde che se la tirano”, che in originale suona: “That’s the trouble with ya New York dope fiends. Ya got a rotten attitude” (“questo è il problema con voi tossici di New York, avete un modo di fare rotten, marcio, balordo”), contenga la stessa espressione di un modo di essere, “rotten attitude”, che Selby nell’articolo su “LA Weekly” sopra citato attribuisce a se stesso, a proposito della decisione di pronunciare un bel “fuck you” ai medici.
Reading
Sono anche disponibili DVD e videocassette di sue letture: una è il Live in Europe 1989, insieme a Henry Rollins; l’altra è Blue Eyes and Exit Wounds, insieme al giornalista, scrittore e poeta newyorkese Nick Tosches, autore di libri, tra gli altri, su Michele Sindona, su Jerry Lee Lewis, sul pugile Sonny Liston e sugli eroi trascurati del rock. Un autentico poligrafo.
– 21/02/2004
Hubert Selby Jr., risveglio cult tra le pasticche
Con un ritardo che fortunatamente non attenua la potenza eversiva della lingua e la dissidenza dello sguardo, esce da Fazi (pp. 261, euro 15.00), nella traduzione notevole di Adelaide Cioni e Grazia Guia, Requiem per un sogno di Hubert Selby Jr., esponente dell’underground americano anni sessanta. Pubblicato negli Stati Uniti nel ’78 e recentemente ispirazione per il film omonimo di Darren Aronofsky, questo è tutto sommato il primo libro che rende giustizia alla voce “autoriale” di Selby jr., che era stata un po’ alleggerita nelle versioni pur pregvoli di Attilio Veraldi per Feltrinelli (Ultima fermata Brooklyn e Il canto della neve silenziosa). Requiem fu scritto nel giro di sei settimane – negli anni dopo Kennedy e della scoperta dello spazio – quando l’aspirazione al Sogno Americano sembrava ancora un’utopia almeno immaginabile. Selby jr. viveva a Los Angeles (“il posto giusto per parlare delle immagini del Great American Dream, e di come l’ostinazione e il desiderio di raggiungerlo conducessero all’autodistruzione”), città che a livello testuale emerge con il suo horror vacui, fisico e territoriale, di fiction-city per eccellenza, anche se l’ambientazione viene traslata nella frenesia plastica di New York, creando una sorta di spazio americano mitologico e ancestrale (LA+NY) nel quale i personaggi si muovono lungo i binari del loro destino tragico. Requiem per un sogno è in questo senso una parabola assolutamente non compromissoria del risveglio violento, incondizionato, dall’illusione. La storia dell’America degli ultimi cinquant’anni, si potrebbe dire.
I quattro protagonisti: Harry, il suo amico Tyrone, la sua ragazza Marion e sua madre Sara, sono inconsapevolmente incastrati nella dialettica ossessiva dei loro sogni, continuano a ignorare la forza coercitiva del presente e affidano tutte le loro intime realizzazioni alla speranza di un futuro radioso che “deve” per forza arrivare. Harry, Tyrone e Marion sono tossicodipendenti che non ammettono di esserlo, per loro la vita vera sta da un’altra parte, e la loro dipendenza è solo il modo per arrivare a raggiungerla; Sara mimeticamente aspetta la sua grande occasione (un invito ad andare in televisione), e nel frattempo si impasticca di pillole dimagranti per indossare il vestito rosso della sua giovinezza. Nella progressiva autodistruzione Harry e Marion riescono ad amarsi solo a patto di proiettare il loro stesso amore fuori da sé, in quel luogo immaginario in cui potranno un giorno finalmente essere liberi e averla vinta sui propri demoni, così come Sara ama suo figlio in un futuro in cui lei potrà essere nonna e prendersi cura dei nipotini. Lo scacco rispetto alla realtà si rivela ancora più drammatico perché i protagonisti, strutturalmente incapaci di viverlo, continuano a giocare la loro partita in un universo parallelo dove la sola comunicazione possibile è con gli oggetti: le siringhe e le bustine di eroina per i tre ragazzi, il frigorifero e i bagel alla crema di formaggio per Sara. La promessa di un’esistenza migliore è l’unica cosa che rende tollerabile il loro martirio quotidiano insieme alla fede integrale nel vero motto americano: una felicità restituita dalla chimica.
– 06/02/2004
Ecco il capolavoro di Selby jr che ispirò “Requiem for a dream”
Nel frattempo l’autore è diventato un vecchio signore dall’aria innocua. Quarant’anni fa scatenava entusiasmi e inquietudini tra il pubblico con la stessa facilità con cui estraeva dal sottosuolo metropolitano degli States storie di violenza e perdizione. Si chiama Hubert Selby jr e può essere definito l’ultimo dei maledetti: venerato dai lettori come un attore culto (sia pure maudit), perseguitato dai benpensanti per le sue provocazioni (negli anni ’60 e ’70 subì svariati processi per oscenità). Di questo mostro della narrativa Usa gli italiani conoscevano fino a ieri solo il libro bomba dedicato alla sua città natale, che lo fece esplodere nel 1964 nel panorama letterario dell’epoca: Ultima fermata a Brooklyn, da cui l’omonimo film del 1989. E Il canto della neve silenziosa (entrambi Feltrinelli). Oggi la casa editrice Fazi ha pubblicato il suo capolavoro del 1978: quel Requiem per un sogno da cui il regista Darren Aronofsky ha tratto il cult movie sotterraneo – come si addice al genio underground – Requiem for a Dream, con Jennifer Connely e Ellen Burstyn, appena approdato sui nostrani canali satellitari e nelle videoteche in dvd. Il romanzo, dal ritmo martellante – come l’adrenalinico film – batte ossessivamente su un unico chiodo: la dipendenza. Da droghe, anfetamine, pillole per dimagrire o Tv. L’effetto è perforante oggi come 25 anni fa.
– 16/11/2003
INTERVISTA A HUBERT SELBY JR.
NEW YORK. Allen Ginsberg ha dichiarato che i romanzi di Hubert Selby Jr. sono tra i pochi scritti in America che “saranno letti nei prossimi secoli”, e Nick Tosches, che dello scrittore e collega e amico, lo ha definito “il piu’ grande romanziere americano vivente”, concedendo che “soltanto Philip Roth puo’ essere considerato al suo livello, quando si leva lo zucchetto”. Le opinioni di Ginsberg e Tosches sono ribadita dalla gran parte dei critici americani, sedotti dal carattere assolutamente indipendente del romanziere originario di Brooklyn (il “New York Times lo ha definito ripetutamente “straordinario”, l’”Indipendent” “uno dei maggiori del novecento”, il “Los Angeles Times” semplicemente “grande” e il “New York Times Review of Books” lo colloca nel“pantheon della letteratura statunitense”), e dalla visceralita’ dilaniante con cui riesce ad affrontare tematiche estreme che rivelano una dimensione che e’ sempre universale, e spesso condivisibile. In particolare nei suoi romanzi piu’ aspri e visionari, Selby emerge uno scrittore squisitamente americano, per la capacita’ di collocare i personaggi in perenne conflitto con il proprio destino, e per lo sviluppo narrativo di vicende che coniugano l’anelito dell’epica con l’inevitabile mediocrita’ del quotidiano. La decisione della Fazi di pubblicare un classico underground come “Requiem for a dream” (pagg. .. euro…) seguito da “Waiting period” e “The willow Tree”, rende onore a questo scrittore di culto, che ha raggiunto il momento piu’ intenso della sua espressione letteraria con la trilogia in questione, realizzata in un arco di venticinque anni, ed intervallata unicamente da “Song of the silent snow”. Selby vive ormai da molti anni a Los Angeles, ma parla sempre con piacere della sua Brooklyn, che definisce con orgoglio “una citta’ ed un universo”, come tutti coloro che hanno passato l’infanzia a sognare la grande metropoli al di la’ del ponte. Mi spiega che gli fa sempre piacere parlare anche di politica, ma quando gli chiedo un parere su Bush, esplode unicamente una grande risata. (D.) Perche’ ride?
(R.) Perche’ giunto a settantacinque anni ho capito che ridere e’ l’unico modo per non piangere.
(D.) E perche’ vorrebbe piangere? br>
(R.) Per quello che “baby Bush” sta facendo al nostro paese e al mondo.
(D.) Cosa sta facendo?
(R.) Lo sta rendendo un luogo uniformato e omologato attraverso la violenza.
(D.) Non le sembra una semplificazione?
(R.) La semplificazione e’ parte essenziale della cultura americana. Quella operata da Bush e’ basata sulla violenza.
(D.) Non crede che questo paese abbia anche subito la violenza?
(R.) Certo, non sono mica cieco. Sono il primo a piangerne e so anche che la violenza organizzata a tradimento contro il mio paese e’ precedente all’avvento di questa amministrazione. Detto questo non ho mai visto un simile degrado culturale, e mi chiedo se questo paese riuscira’ mai a sopravvivere a “baby Bush”.
(D.) Come descriverebbe lo stato della cultura in America in questi periodo?
(R.) Vedo molti talenti di indubbia levatura in vari campi, ma anche una tendenza all’effetto e all’esemplificazione, dettata da esigenze puramente commerciali. Glie lo sta dicendo una persona che e’ stato accusato di usare strumantalmente gli effetti, e che e’ stato definito sin dall’inizio della sua carriera come “estremo”. Oggi in America vige solo il dio denaro. Per molti versi cio’ potrebbe rappresentare nulla di nuovo, tuttavia riscontro che nella odierna societa’ statunitense cio’ e’ accettato come un dato di fatto, senza alcuna forma di ribellione morale o di tensione etica. Un tempo almeno si provava l’umiliazione della testa chinata di fronte al bisogno: oggi, anche in campo culturale, appare tutto normale. Stiamo parlando di un fenomeno che e’ anche globale, e non sono cosi’ fazioso da attribuirlo unicamente a questa amministrazione. Tuttavia e’ indubbio che la tendenza pre-esistente a livello mondiale ha subito una netta accentuazione.
(D.) Lei ha parlato di indubbi talenti. Me ne citi uno in campo letterario.
(R.) Ne ammiro molti, ma voglio fare il nome di David Foster Wallace. Ho parlato di molti talenti, ma non si puo’ minimizzare un senso generale di decadenza intellettuale. Le sembra normale che vengano pubblicati libri di memorie di trentenni? Oggi la letteratura e’ sempre piu’ voyeuristica e tende a esibire il vuoto e l’insensatezza di esistenze che hanno perso il proprio baricentro morale.
(D.) Lei ha iniziato a scrivere dichiarando di “non voler morire senza aver fatto nulla nella vita”
(R.) Lo penso ancora. La scrittura ha dato un senso alla mia esistenza, e mi ha fatto superare i momento piu’ duri di una vita estremamente difficile, alla continua presenza del dolore e della morte. Ritengo che lo scrivere, ma potrei dire l’arte, sia innanzitutto una necessita’. E chi scrive dovrebbe farlo con un atteggiamento etico. Senza scadere in un facile moralismo, l’obiettivo primario non dovrebbe essere il guadagno.
(D.) Ritiene che la letteratura l’abbia reso un uomo migliore?
(R.) A secondo il significato che lei da al termine “migliore”. Non sono certo diventato un uomo ricco, ma ora, da persona anziana, credo che questo sia stato un bene. Ho vissuto e vivo la letteratura come una esperienza spirituale. (D.) E’ credente?
(R.) Credo in una forma di spiritualita’ presente in ogni cosa, ed in particolare nell’arte, ma in nessun tipo di religione organizzata.
(D.) La trilogia che sta per essere pubblicata e’ dominata da patologie e ossessioni…
(R.) Lei cos’altro vede nella vita?
(D.) Beh, anche la felicita’ e la speranza.
(R.) Anch’io le vedo, ma so che sono travolte perennemente da illusioni che diventano spesso ossessioni.
(D.) In “Requiem for a dream” i protagonisti sono dipendenti dalla droga, dai medicinali e dalle stupidaggini che vengono propinate dalla televisione.
(R.) Sono innanzitutto dipendenti dal “sogno americano”: e’ la droga piu’ pericolosa che assumono inconsapevolmente. L’iniziale suggestione del romanzo nasce dalla volonta’ di raccontare delle storie parallele di dipendenza: quello che accade con i medicinali non e’ troppo diverso dall’assuefazione mortale alla droga, ma scrivendo mi sono reso conto che potevo utilizzare lo stimolo per un discorso piu’ ambizioso sull’America.
(D.) Non le sembra una visione a tinte forti?
(R.) E’ l’America che e’ sempre a tinte forti.
(D.) Il libro e’ diventato recentemente un film di culto.
(R.) Mi e’ piaciuto immensamente come lo ha diretto Darien Aronovskly, e mi ritengo uno scrittore decisamente fortunato: come gia’ in passato con “Ultima fermata a Brookyn” ho visto sullo schermo quello che avevo immaginato sulla pagina.
(D.) Nell’incipit, amato in particolare dagli scrittori della beat generation, il protagonista chiude la madre nello sgabuzzino.
(R.) Si tratta di una madre molto particolare, rinchiusa da un figlio ancora piu’ particolare. E, cosa piu’ importante, si tratta di una situazione di doloroso disagio esistenziale.
(D.) Ancora una volta un suo romanzo e’ ambientato a Brooklyn
(R.) Per la precisione a Coney Island: il luogo dove la citta’ termina la propria insularita’ ed incontra l’oceano, con tutto cio’ di evocativo che esso rappresenta.
(D.) Lei rappresenta sia stilisticamente che da un punto di vista concettuale un unicum nella letteratura americana.
(R.) Non mi sono mai posto questo problema, ma so di non poter sfuggire alle mie origini culturali, a cominciare da Melville.
(D.) Mi citi un autore che ha influenzato la sua scrittura.
(R.)Il nome che mi viene alla spontaneamente non e’ americano: Celine. Quando cominciai a leggerlo quaranta anni fa rimasi sconvolto dalla sua rabbia e la sua follia, ma poi, a poco a poco fui conquistato da come riusciva a gestirla e organizzarla con assoluta armonia artistica. Mi accorsi in quel momento che mi sentivo piu’ vicino a Celine di gran parte delle persone che conoscevo. E forse e’ ancora cosi’.
– 04/02/2004
Requiem per un sogno
Hubert Selby jr è stato il primo scrittore ad affrontare i temi più luridi della società americana, senza nascondersi nella prospettiva sociologica di chi guarda verso il basso armatodi cultura. Per chi ha letto Irvine Welsh, Requiem per un sogno potrebbe sembrare apparentemente datato, visto che il romanzo risale al 1978 ed esce nel nostro paese solo adesso, fuori tempo massimo per essere ancora innovativo dal punto di vista del linguaggio. Ma la qualità spietata dell’autore di Brooklyn, oggi quasi ottantenne, arriva tutta mello stomaco. E a differenza dell’autore scozzese, Selby non racconta il lato grottesco del marcio ma quello disperato. Non ci sono nemmeno le virgolette, paragrafi, giri di punteggiatura: solo blocchi inesorabili di parole che scorrono a velocità costante verso la base della spirale. Un gruppo di tossici che si ritrovano a farsi all’obitorio del Bronx, una casalinga ossessionata dalla tv e dalle pillole dimagranti, Harry, Tyrone e Marion che non riescono a vedere lo sfascio delle loro vite: tutti vivono di speranze, dipendenze e fallimenti. E’ una lettura tosta, ma i calci sono dati talmente bene, che prenderli nello stomaco è un piacere.
– 12/12/2003
Dopo venticinque anni, “Requiem per un sogno” di Selby jr. A ciascuno la sua droga
La cosa che interessa di meno, in questo Requiem per un sogno di Hubert Selby jr. (Fazi) – romanzo uscito negli States venticinque anni fa, e portato sugli schermi nel 2000 dal sopravvalutato Darren Aronofsky, interpreti Ellen Burstyn, Jennifer Connelly e Jared Leto -, è la storia, il plot, la vicenda. Uno spaccato fine Settanta della Coney Island cara a Lou Reed (che di Selby jr. è fanatico, oltre che amico), fra madri drogate dalla televisione e figli che si sbattono da mane a sera per procurarsi ben altra droga – fino a impegnare la “droga” materna, appunto la scatola televisiva, in cambio di pochi spiccioli vitali. La contrapposizione fra questi due tipi di tossicodipendenza (mediatica e chimica) è già uno schemino tutt’altro che inutile a mettere a fuoco la
temperie del libro (ognuno ha la sua droga, non si scappa). Libro la cui trama, dicevamo, non è poi così decisiva. Primo:
perché – per ambientazione, motivi e sviluppi – non si discosta granché da quella del capolavoro riconosciuto dell’ormai settantacinquenne narratore newyorkese, Ultima fermata a Brooklyn.Secondo: perché i cultori di Selby si saranno già visti (su Tele+ o in Vhs: il film non è mai uscito nelle nostre sale) la pellicola. E poi insomma, diciamolo una volta per tutte, non sta nella “materia” l’originalità di questo scrittore… Giacché di romanzi che ci raccontano come il nostro universo sia ormai preda di droghe che lo svuotano di senso riducendolo al simulacro virtuale (e malato) di se stesso, ne abbiamo letti millanta e uno (a partire da quelli del sommo Philip K. Dick). Idem dicasi per le storie destinate a finir male: reietti che annaspano nel pantano, poi arriva un grande sogno (fosse anche la partecipazione a un quiz televisivo) che potrebbe ripulirli dalla melma; ma è tardi, troppo tardi – e per il sogno non si può recitare che un livido requiem. No. L’originalità di Selby jr. sta nella micidiale macchina da guerra della prosa con cui veniamo affrontati: una colata lavica che impasta e porta al calor bianco, nel suo magma, ogni altro elemento: flash descrittivi, mozziconi di dialoghi, slang; barlumi subito soffocati di interiorità, desideri carnali incontrollabili e nausee omeriche – e allarme, furore, fetore, paura, disgusto. La lezione del miglior Céline viene esasperata da una carica di rabbia e di odio che mette a disagio: l’occhio sbanda schizzato come la “camera” dell’Oliver Stone di “Natural born killers”, le raffiche della paratassi crivellano con esatta ferocia la pagina – e quel poco di luce che più avanti, a Ottanta inoltrati, arriverà a rischiarare il “Canto della neve silenziosa”, qui è ancora sanguinosamente ghermito e sfigurato dagli artigli di un’oscura necessità che non dà tregua a nessuno.
Libri dello stesso autore