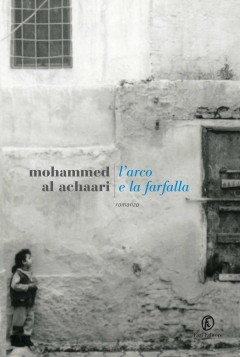Eudora Welty
La figlia dell’ottimista
Traduzione di Isabella Zani
A oltre mezzo secolo dalla prima apparizione, e dopo un decennio di silenzio sulla scena editoriale italiana, Fazi Editore pubblica la prima traduzione italiana de La figlia dell’ottimista, premio Pulitzer 1973.
Il secondo dopoguerra in un piccolo centro della provincia americana del Sud; Clinton McKelva, l’anziano giudice della città, sua figlia Laurel e Fay, la seconda giovane moglie. La morte improvvisa dell'”ottimista” dopo un banale intervento chirurgico spezza un triangolo tenuto in precario equilibrio dalla lontananza e dalle convenzioni e costringe Laurel, figlia unica e vedova di guerra, a ripensare tutto il suo passato e ad affrontare la presenza della rozza ed egoista matrigna, in un mondo in cui le regole formali che governano la comunità affettuosa di parenti e amici vanno dissolvendosi, sostituite da una visione sempre più gretta della vita.
Ne La figlia dell’ottimista, per la prima volta tradotto in Italia, Eudora Welty riesce a catturare la ricchezza di un’intera esistenza trascorsa all’interno di un ambiente ristretto dove tutti si conoscono e i rapporti umani sono forti e complessi. Esistono ancora luoghi del genere? In realtà, questo mondo va sparendo anche dal romanzo e l’incarnazione dello sfacelo è proprio Fay, petulante, sgraziata, infantile, incapace di provare amore o anche solo di immaginarlo. Protagonisti di un’opera dal forte contenuto autobiografico sono dunque i valori: quelli tradizionali appresi da Laurel e dai suoi genitori prima di lei, e quelli acquisiti nella sua vita indipendente di donna in carriera in un’altra città; tutti in netto contrasto con Fay, che subisce l’esistenza solo in termini di competizione e il cui unico desiderio è uscirne vincitrice. E l’ultima accesa discussione tra le due donne segnerà una rottura irreparabile tra due mondi, tra coloro che, come Fay, non comprendono mai «il significato di ciò che è accaduto loro» e appartengono già a un futuro dai contorni morali preoccupanti e ineluttabili, e la dimensione del passato simboleggiata da Laurel, attraverso il cui sguardo l’autrice racconta magistralmente la forma e la sostanza delle proprie origini, il mistero dei rapporti familiari, la tensione del cuore umano nell’amore e nel dolore della perdita, affermando con forza la necessità di coltivare la memoria.
– 29/08/2005
Con la Welty l’altra faccia dell’America
– 30/08/2005
La figlia dell’ottimista
– 01/10/2005
Mississipi al femminile
– 26/03/2005
Eudora Welty, la figlia dell’ottimista
West Virginia, anni Cinquanta. Una donna di mezz’età, Becky, è molto malata. Il marito, il giudice McKelva, è un uomo mite e buono, ma forse questo a Becky non basta. Poi la donna muore. Passano gli anni. Il giudice si risposa con Fay, una texana insopportabile. E muore anche lui. Sola, nella vecchia casa dell’infanzia, la figlia Laurel ripensa a quegli anni: a sua madre malata nel letto; al padre incapace, pur amandola, di aiutarla. “Quando rientrava” scrive Eudora Welty “indifeso nel suo smarrimento, suo padre si fermava l capezzale della moglie. Esausta, una volta lei gli aveva mormorato: “Perché ho sposato un codardo?”. Poi gli aveva preso la mano per aiutarlo a sopportare la domanda”. Bastano queste quattro righe splendide a decretare che La figlia dell’ottimista è un capolavoro? Forse no, a dispetto delle forti tentazioni ormai predominanti a nominare per chiunque Tolstoj, Proust e Omero. Certo è che, comunque, La figlia dell’ottimista è un romanzo decisamente bello; e che l’intensità e la ricchezza delle righe citate non sono un fatto episodico. Il romanzo è costruito, in pratica, secondo la scansione di tre grandi scene. Nella prima vediamo la figlia, Laurel, vedova, che viene da Chicago per assistere suo padre; lo scontro con la matrigna gretta; la morte del giudice McKelva. Nella seconda ci sono i funerali, ai quali partecipano tutti gli amici e i vicini del villaggio in cui il giudice è vissuto. Nella terza, a esequie concluse, Laurel rimane nella casa vuota e, aprendo un armadio o un cassetto, girando di stanza in stanza, ripercorre il suo passato. Come ho detto, il romanzo è molto intenso, di un’intensità che non riguarda soltanto i sentimenti: è una vera e propria intensità narrativa. Cosa vuol dire? Vuol dire che Eudora Welty, scrittrice molto amata dai critici americani, autrice di romanzi e racconti pubblicati su sofisticato New Yorker, conosce l’arte della pregnanza. La dimostra, in particolar modo, nei dialoghi. Efficacissimi e, vogliamo aggiungere, parecchio divertenti, soprattutto nel secondo lungo sipario delle esequie, tradizionale terreno di caccia dello humor di scuola anglosassone quale indispensabile bilancia di dolore.
– 05/03/2005
Il tempo del Mississippi
Ha raccontato Eudora Welty che la sua casa di bambina, a Jackson in Mississippi, era una casa piena di orologi. Nell’atrio batteva le ore una grande pendola di quercia, e il suono attraversava ogni stanza, si arrampicava su per le scale, invadeva il piano superiore. Spesso si tre bambini Welty, addormentati da un pezzo, capitava di svegliarsi all’improvviso per i dodici rintocchi di mezzanotte. Puntuale, però più piano, alla pendola dell’atrio rispondeva il piccolo orologio bella camera da letto dei genitori. C’era poi un orologio in cucina, e un altro, a cucù, in sala da pranzo. D’estate la casa in North Congress Street, dove Eudora è nata nel 1909, rimane vuota a lungo: gli Welty sistemano i figli sul sedile posteriore della Oakland e li portano in vacanza dai nonni, in Ohio e molto più a nord in Virginia. Al ritorno, mentre Eudora annusa la polvere negli angoli alla ricerca di odori conosciuti, il padre per prima cosa rimette gli orologi. Spiega la Welty che è stata una fortuna per lei avere imparato a sentire il tempo dentro di sé tanto presto ,quasi senza saperlo. In tutte le sue pagine il tempo è una figura viva, un’ombra solida e che si può toccare.
“Il narratore è costretto a lavorare con il tempo, nel romanzo non c’ è niente che al tempo sia consentito di sottrarsi. Nessun romanzo comincia prima che sia stato caricato il suo orologio; allora, e solo allora, i personaggi sono vivi, in movimento; la situazione non si rivela che nel suo dispiegarsi. […] Il tempo mette in scena l’azione, è il meccanismo di ogni cambiamento. Se il tempo si spezza anche il romanzo cade, e il suo significato è perduto. Perché il tempo ha con il significato del romanzo il rapporto più stretto, è il tempo che guida la trama”. Così Eudora Welty scriveva da grande narratore in un testo critico del 1973. Quell’anno vince il premio Pulitzer con il suo quinto romanzo, e sarà l’ultimo: nel 2001, quando muore a Jackson in una delle case che aveva abitato da bambina, è l’unico autore consacrato in vita da un’edizione in due volumi della Library of America, ma alla sua opera si sono aggiunti solo un libro di saggi, la raccolta completa dei racconti e un’autobiografia. Concluso nel 1969, pubblicato nel 1972, La figlia dell’ottimista (Fazi Editore “Le strade”, pp. 187, € 13,50) è ora tradotto per la prima volta in italiano da Isabella Zani, brava nonostante qualche sordità a riprodurre della versione originale il ritmo sotterraneo e inflessibile, la mutevole sonorità dei dialoghi, ticchettii di fondo e rintocchi interiori. Come quella di North Congress Street, anche la casa del romanzo vibra del respiro concorde di molti orologi.
“Che ore sono?”, domanda il vecchio giudice McKleva appena uscito dalla sala operatoria dopo un intervento agli occhi che lo costringe a letto nell’immobilità più completa. Bendato, obbligato perfino a trattenersi dal piangere, dovrà solo lasciare che il tempo passi per lui. Sul tempo il giudice McKleva si concentra fino a sprofondare dentro un silenzio irraggiungibile, ne interroga le pause e il battito ascoltando sua figlia Laurel che legge Dickens a voce alta, lo misura sulle pagine del libro che lei sfoglia con premurosa, partecipe lentezza. Però il tempo per lui in realtà scorre all’indietro, è un nastro che si riavvolge su se stesso. Mentre fuori turbina la furia rumorosa del martedì grasso, e nella stanza infuria lo scontro muto tra Laurel e la nuova moglie Fay, che è capricciosa e giovane e insensibile, il giudice McKleva è arrivato alla fine del suo tempo. Per Laurel comincia la dolorosa discesa in fondo al proprio, dentro il passato che rintocca nel presente e a volte ne sovrasta il suono vero. Sarà il tempo delle maschere strappate. Partita in treno da Chicago per accudire il padre in ospedale a New Orleans, in treno Laurel accompagna la bara del padre a Mount Salus, la cittadina del Mississippi dove lui viveva e lei è nata. Durante la notte, sdraiata sul suo letto di ragazza, aspetta che dal piano di sotto la raggiunga il battito rassicurante e familiare dell’orologio sul camino del salone. Però quell’orologio nessuno l’ha rimesso. Se all’insaputa dei protagonisti e del lettore la prima parte del romanzo cammina silenziosa a ritroso mentre la storia sembra spingersi in avanti, la parte centrale del trittico è il luogo animato di un tempo fermo. La piccola fiera delle vanità durante il funerale, il chiacchiericcio in apparenza vuoto ma funzionale alla soluzione della trama, la necessità di Laurel di arrendersi a un’immagine del padre che non corrisponde al rigido ritratto da lei fissato con la distanza e nel ricordo: dentro una sola giornata cadenza interiore e ritmo esterno degli eventi si intrecciano in un sanguinoso corpo a corpo, il campo di battaglia è la vita immobile di Laurel, anche il suo cuore ancorato a ciò che ora è per lei lontano e impenetrabile. Il suo sguardo è incapace di bucare la realtà, lei sembra più cieca di suo padre bendato dopo l’intervento. Il tempo la tiene ancora prigioniera.
La sera, quando tutti se ne sono finalmente andati via e ogni stanza è sprofondata nel silenzio, Laurel scopre un rondone dei comignoli entrato in casa chissà quando. Farlo uscire è impossibile. Con il rondone che sbatte contro le porte e contro i vetri, sporcando le tende lavate di fresco, lei condivide la sua notte. Fruga nei cassetti e trova le lettere e i diari di sua madre: anche lei è morta da anni, come suo marito ucciso in guerra da un kamikaze giapponese, come suo padre pochi giorni prima in ospedale a New Orleans. “Quanti fardelli addossiamo ai morti, pensava Laurel adesso ascoltando la pioggia che batteva più forte sul tetto, cercando di dimostrare piccole cose da poterci tenere a mò di consolazione quando loro non possono più averne il sentimento…cose che è impossibile tenersi così com’è impossibile dimostrarle: la permanenza della memoria, la vigilanza contro il male, l’indipendenza, la speranza, la fiducia reciproca”. Liberando i morti da quel fardello che li vincola al tempo dei vivi, Laurel libera se stessa e il suo futuro. La mattina dopo, quando l’orologio della sala ha ricominciato a battere le ore, riesce a volare fuori anche il rondone. Essere sopravvissuti non è più una colpa.
Eudora Welty pensava a sé come a una scrittrice di short-stories, prestata al romanzo di tanto in tanto e per caso. Davanti al romanzo le sembra di scegliere ogni volta la via più tortuosa, più accidentata e strana. Però La figlia dell’ottimista è un romanzo breve e perfetto, nemmeno una traccia resta sulla pagina di casualità o fatica. Lo scintillio dei dialogati, la luminosa necessità delle metafore, lo splendore fermo dei simboli: ogni parola lavora dentro uno stile di cristallo che è limpido ma tintinnante di rintocchi, attraversato in profondità da battiti accordati in esatta sincronia su un ritmo ferreo, inevitabile.
“Il tempo che noi percepiamo in modo soggettivo è spesso l’ordine che seguono i racconti e anche i romanzi: è il filo ininterrotto della rivelazione”. Dilatato o fermo nella storia, accelerato per un sussulto improvviso della trama, è ancora il tempo scandito dalla pendola nell’atrio che a mezzanotte la svegliava di soprassalto da bambina nella sua casa a Jackson, in Mississippi.
Libri dello stesso autore