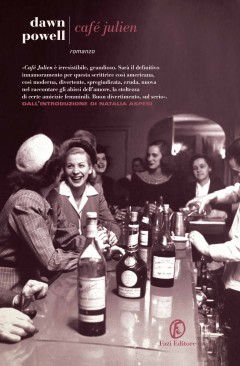
Dawn Powell
The Golden Spur
Postfazione di Gore Vidal
Traduzione di Alessandra Osti
Jonathan Jaimison scopre di non essere figlio dell’uomo che lo ha cresciuto, bensì di qualcuno con il quale la madre, ormai morta da tempo, aveva avuto una relazione durante il periodo trascorso al Greenwich Village. Da Silver City, soporifera cittadina dell’Ohio, si trasferisce allora a New York in cerca del vero padre e delle proprie radici, si registra in un albergo che sembra modellato sul Madison Square e, come prima tappa, si reca nel bar dove la madre era cliente fissa, The Golden Spur. Inizia così per il nostro eroe, ingenuo e amorale, un’avventura intessuta di personaggi bislacchi e di vicende che si susseguono con ritmo incalzante in un mondo per lui assolutamente sconosciuto e assolutamente affascinante dove il suo passaggio trasforma e sembra dare un nuovo ordine alle cose. Ma al di là degli eventi, a tratti comici e surreali, The Golden Spur è innanzitutto un romanzo sul Village popolato di artisti, beatnik, lesbiche muscolose, derelitti e, naturalmente, newyorchesi in carriera, dove Dawn Powell celebra, con una prosa intensa ed evocativa, una New York che ormai sta scomparendo.
«Una vena letteraria satirica, disincantata, a tratti beffarda, lieve e divertita».
Francesco Erbani, la Repubblica
– 12/01/2000
Erano i fatti a sbagliarsi
Negli Stati Uniti, anzi a New York, Dawn Powell (1896-1965) è una scrittrice di culto; e con sacerdoti di qualità come Gore Vidal e John Updike. Quindi che “The Golden Spur” – suo ultimo romanzo, ma il primo a uscire qui da noi – mi abbia lasciato piuttosto freddo, non significa granché: la prossima volta potrei farmi sorprendere sulla via di Damasco e, rimontando a cavallo, contarmi fra i suoi adepti! Ma per ora quasi m’appassiona di più la sua vita, ben ricostruita da Tim page: dall’infanzia in una cittadina dell’Ohio, il padre alcolizzato, i guai con la matrigna crudele ecc., all’approdo a Manhattan e – da allora – l’indefessa fedeltà ai liberi costumi del Greenwich Village. E più del Golden Spur (che però ho letto solo in traduzione), m’ha interessato spigolare i diari, questi si bellissimi, e – come racconta Page (che li ha curati nel 1995) – la sua opera in realtà più di successo: dove agli sketch di scene di romanzo s’alternano “bozzetti perfettamente autonomi, istantanee di una realtà lontana, vivida e vitale”, e anche annotazioni francamente banali – “e tuttavia, proprio perché le banalità di ieri sono così fugaci e rapidamente dimenticate, esiste un arcano piacere nell’ascoltare, insieme a Dawn Powell, una conversazione che ebbe luogo nel bagno di un locale notturno mezzo secolo fa, recarsi in cime all’Empire State Building quando era nuovissimo, spiare una festa cosmopolita a Manhattan nel bel mezzo della Grande Depressione” (Page). Anche i migliori aperçus sull’arte del romanzo li si trova nei diari. Come in questo appunto del 2 giugno 1962 (non citato da Page), di sapore domesticamente neoplatonico: “ho deciso che la mia idea di fondo è che c’è un solo personaggio, un A. gigante che si sfoglia come un carciofo in diversi personaggi – perché ognuno non è che uno stato d’animo o possibilità di quello di fondo, e un romanziere illumina una sola striscia del carciofo. Nello Spur, come altrove, ogni personaggio rappresenta l’eroe in un altro momento – in un’altra situazione – in circostanze differenti. Il frutto si apre, sembra diverse persone, poi si richiude nell’Uno”. Che è una descrizione davvero eccellente del tutto e niente che avviene in “The Golden Spur”, e rende giustizia anche a quella “spinosità” del libro, che in realtà è propria di tutti gli scrittori satirici – come il grande Evelyn Waugh, o Muriel Spark, cui già Edmund Wilson, recensendo il romanzo a suo tempo sul “New Yorker”, aveva accostato Dawn Powell. Come in molti altri suoi libri (ne dà conto Gore Vidal nel bel saggio stampato in appendice), anche il “carciofone” di “The Golden Spur” è un belloccio sempliciotto di campagna (dell’Ohio) che arriva a Manhattan a cercare se stesso: cioè, nel caso specifico, l’uomo sconosciuto (e – Jonathan lo sente e si sbaglia – di gran successo…) con cui la madre ormai defunta l’avrebbe concepito in una giovanile parentesi bohémienne. L’intreccio, comunque, non è che un pretesto per stendere il più ampio affresco di un Village primi anni sessanta, popolato d’artisti e scrittori più o meno da strapazzo (ma ci sono anche parodie di Hemingway e Peggy Guggenheim), yuppie ante litteram, e donnine che non si fanno pregare, anzi rimorchiano loro (“Le donne di città erano meravigliose, stabilì, però molto strane. le sentiva discutere sui meriti relativi dei loro diaframmi ed ebbe il buon senso di capire che non parlavano di canto”). Un po’ troppo lungo, il romanzo è un susseguirsi di scene e schermaglie, tutte piuttosto divertenti in sé, ma un po’ tediose nell’insieme – forse in conseguenza di un arte fin troppo sofisticata, che non cerca la battuta memorabile, così sicura d’averla già trovata per strada. Come in questa rivelazione folgorante (ma quasi non si vede, a metà paragrafo…), che suggella il gran successo di una terapia psico-analitica: “Erano i fatti a sbagliarsi”.
– 10/01/2000
The Golden Spur
Manhattan: il Village negli anni Sessanta, attraverso gli occhi doppiamente ingenui del giovane provinciale Jonathan Jaimison, sbarcato a New York dall’Ohio in cerca del suo vero padre. Il primo, quasi unico indizio che la madre gli ha lasciato è il nome di un locale, The Golden Spur, una via di mezzo fra una bettola e un cenacolo di artisti e intellettuali, più o meno illusi, più o meno spiantati. Di scoperta in scoperta, Jonathan esplora ambienti, case, relazioni sociali, affettive e sessuali di cui neppure supponeva l’esistenza, e la sua disarmata disponibilità, uno degli elementi più riusciti del libro, o porta a conoscere una quantità incredibile di persone e situazioni. Il romanzo di questa prolifica scrittrice, da poco riscoperta negli Stati Uniti, punta tutto sullo spaccato new-yorkese, di notevole incisività; sul profilo dei suoi attori, realistico e paradossale; sulla vicenda: rito d’iniziazione alla vita adulta. Dawn Powell, nata nell’Ohio nel 1896, scomparsa a New York nel 1965, è oggi considerata una delle più grandi scrittici americane del Novecento.
The Golden Spur di Dawn Powell
Come talvolta capita, purtroppo i riconoscimenti in letteratura vengono “dopo”. É il caso della scrittrice americana Dawn Powell, morta nel 1965 a New York. Nonostante la stima che di lei aveva un critico molto importante, Edmund Wilson, è sempre stata “sul punto di”. Oggi, scrittori del calibro di John Updike e Gore Vidal ne celebrano l’abilità, l’arguzia, il talento, sostenendo che il suo nome potrebbe tranquillamente affiancarsi ai nomi di Hemingway o di Scott Fitzgerald. L’editore Fazi, pubblicando “The Golden Spur”, il romanzo considerato da parecchi il suo più bello, insieme a una sua biografia, ne tenta il lancio in Italia. Buona fortuna. “The Golden Spur” è il nome di un bar di New York. Un bar del Village: il quartiere degli scrittori, dei pittori, degli artisti veri e sedicenti tali. Un giovanotto arriva dalla provincia del Midwest a New York, siamo alla fine degli anni Cinquanta, per scoprire la propria identità. Sua madre è morta; il padre che gli ha dato il cognome non è quello vero. Chi è il padre di Jonathan Jaimison? Ha inizio una frenetica ricerca, anche assai rocambolesca, assai improbabile. Che sia rocambolesca e improbabile, non ha alcuna importanza: è la trama. I personaggi, le situazioni, gli incontri si intrecciano senza fine, in una specie di “gioco al massacro” del buon senso. C’è di tutto: scrittori importanti e altri falliti, pittori, mercanti d’arte, attricette, professori universitari, “vecchie amiche”, omosessuali dichiarati, omosessuali coperti: non si finirebbe più. Il centro di tutto è quel bar, “The Golden Spur”, immerso nel suo delirio alcolico. Naturalmente, la ricerca paterna finisce quando finisce il libro: il padre è quello che né Jonathan, né noi lettori aspettavamo. Ma, pure questo ha importanza relativa. Nel romanzo contano l’arguzia, il sarcasmo (tanto più apprezzabile quanto meno diretto a personaggi “riconoscibili”), la capacità aerea di trasferire tempo e luogo. La Powell ricorda Evelyn Waugh. Ma ha anche la cattiveria di Ivy Compton-Burnett.
Le mille ombre di New York Una visitatrice permanente racconta la Grande Mela
La notte che Dawn Powell entrò in ospedale per non uscirne più, a New York ci fu il primo blackout totale. Due le ipotesi: buio indossato a lutto e quella o profezia dell’oblio a venire. L’una non esclude l’altra. «Io sono New York – in questo momento – adesso»: Dawn Powell, nata e fuggita dall’Ohio, nutrì sempre per la metropoli l’innamoramento strenuo della visitatrice permanente, come si definiva dopo aver abitato Manhattan per più di quarant’anni. Ne scrisse quando ne scrivevano anche Francis Scott Fitzgerald (di cui condivideva l’anno di nascita, il 1896, e l’editor di Scribner’s, il leggendario Max Perkins) e Dorothy Parker (le iniziali e l’arguzia, ma non la notorietà): contribuì a fare di New York un genere letterario, ma ne venne considerata un’interprete minore. Al momento della morte, avvenuta nell’inverno 1965, quasi tutte le sue opere erano fuori catalogo, e lo sarebbero rimaste fino a quando un lungo articolo dell’amico Gore Vidal sul New Yorker la resuscitò dal silenzio vent’anni dopo, innescando un rilancio internazionale: questa di Tim Page è la prima biografia, minuziosa fino alla devozione, e The Golden Spur è forse il capolavoro. Quando venne pubblicato, nell’ottobre del 1962, Dawn Powell non poteva sapere che sarebbe stato l’ultimo romanzo, eppure The Golden Spur ha la qualità enciclopedica ed essenziale di un testamento: c’è il Greenwich Village, ritaglio di boheme nel cuore arlecchino della metropoli, con alberghetti artritici e bar sudaticci dove tutti vanno «finché possono permettersi di non venire», e c’è poi qualche cartolina di nostalgia midwest e il lercio splendore di Broadway. C’è l’ingenuità vigorosa e l’esperienza sfiancata, ci sono poeti, ballerine e altri destini da strapazzo, il saliscendi mercuriale della fama degli artisti e il viavai delle donnine da uno all’altro dei loro letti. Questa, solo e tutta questa, è Dawn Powell, che scrisse più volte uno stesso romanzo – il giovane dell’Ohio con la vita inceppata in una routine di campi e famigliola mentre invecchia sognando il fascino caleidoscopico di Broadway – e poi lo riscrisse molte altre volte allo specchio – il giovane dell’Ohio che morde la Grande Mela rassegnandosi ad abitarla come un bruco di campagna. Non sorprende sapere che questa è stata anche la sua esistenza. Ebbe un’infanzia di una crudeltà da fiaba, con una matrigna che costrinse le figliastre a riesumare il cadavere della sua primogenita nata morta perché l’abbigliamento era ritenuto inadatto, facendola poi riseppellire con indosso i vestiti dell’unica bambola concessa alle tre sorelline. Nella sua parte newyorchese, invece, quella di Dawn Powell fu una vita di ordinarie tragedie, fugaci mondanità e sbiadite soddisfazioni, cucite intorno a un matrimonio sopravvissuto alle scappatelle e all’alcolismo di entrambi i coniugi, e a un figlio autistico. «Solo il romanzo è il mio legittimo consorte», scrisse allora, ed ebbe quindici di questi matrimoni, oltre a un imprecisato numero di brevi flirt da poche cartelle consumati quasi tutti senza passione su riviste e quotidiani di secondo piano. Frequentava con camaleontica disinvoltura i salotti dei Vanderbilt e i tram affollati, Dos Passos, Edmund Wilson e Hemingway così come gli avvinazzati dell’East Side: aveva fatto della sua vita la bozza originaria di ogni romanzo, ma ristabiliva un equilibrio testando nelle conversazioni in società le battute dei dialoghi. Le sue trame, d’altra parte, non erano che pretesti a forma di recinto. Quello che davvero la interessava era la tavola dolorosamente periodica degli elementi umani, e le esistenze che descrive con affettuoso fatalismo hanno la familiarità delle cose eterne riscoperte per caso. Adottò spesso e disordinatamente la tecnica balzachiana del ritorno dei personaggi, ma forse non per scaltrezza narrativa, quanto per un autentico legame materno con le sue creature: le amava «nella loro interezza, senza ritocchi» e, quindi, anche senza giudizi. Forse per questo la brillantezza della sua ironia non si lasciò mai incapsulare nell’epigramma puntuto alla Wilde, né in sgargianti gag hollywoodiane, animando figure e situazioni di una comicità compiuta e autonoma, soffusa di un malinconico calore autunnale. Dawn Powell sapeva che le storie umane, al fondo, non sono che tenaci strategie di autoillusione, meschine o geniali, buffe o patetiche, e per sé aveva scelto la più raffinata. In un romanzo giovanile c’è un’autrice alle prime armi che permette infine a un amico di leggere quello che sta scrivendo, e gli mormora appena: «Questa… be’, questa sono io». Simone P. Barillari
– 09/01/2000
Una vita spesa al bar
Dawn Powell amò con lo stesso trasporto il whisky e la scrittura. Una Janis Joplin delle lettere. provinciale dell’Ohio calata nel Greenwich Village negli anni Venti vi restò fino alla morte, nel 1965. Da Dos Passos a Gore Vidal, padrino del suo rilancio li vide passare tutti. In questo libro, intitolato al loro bar nel famoso quartiere della bohème newyorchese, canta speranze e naufragi dei compagni di strada. Il suo sarcasmo animava le serate. Da completare con il racconto della sua tormentata vita.
The Golden Spur
Alcuni decenni fa, c’era uno sguardo che si aggirava incantato per il Greenwich Village. Ma non era quello di Forrest Gump. Apparteneva invece a Dawn Powell, ottima scrittrice americana, ora proposta da Fazi in due versioni: con la biografia di Tim Page che ricostruisce eccellentemente la sua vita e quella del quartiere più artistico e anticonformista di New York dagli anni fra il 1920 e il 1965; e con il suo ultimo romanzo, “The Golden Spur”, uscito nel 1962. Un racconto brulicante di personaggi e trasformazioni del Village, elaborato da una lei che ne aveva “celebrato un’epoca precedente”, ma che continuava, nonostante la miseria, le disgrazie, le malattie a sgranare i suoi occhioni curiosi su un mondo amatissimo. Occhi che erano sempre stati ironici, perfino sarcastici, ma insieme avidi e vitali. La giovane Dawn Powell era sbarcata a New York nel 1918. Proveniva da una provincia davvero doc quanto a noia, l’Ohio. Aveva un unico, pervivace sogno: diventare scrittrice. E in poco tempo vi era riuscita, elaborando nel corso di quattro decenni di attività due potentissimi miti: quello della provincia che si era lasciata alle spalle e quello della città più moderna del mondo. Aveva scritto perciò incessantemente e senza risparmio romanzi, racconti (da pubblicare sulle riviste), storie per il teatro, la radio, il cinema. Al mondo della celluloide aveva rinunciato, proprio per non dover lasciare la Grande Mela. Aveva trascorso il suo tempo tra alberghi e ristoranti. Si era sposata con un grafico geniale ma scrittore mancato, aveva avuto un figlio schizofrenico. Aveva macinato lavoro per pagare infermiere e cameriere, senza smettere di incontrare il bel mondo cosmopolita e intellettuale dei vari John Dos Passos, Edmund Wilson, Ernest Hemingway, Dorothy Parker (penna sciccosa e graffiante, però forse di minore tenuta romanzesca). E aveva sfoderato uno straordinario senso dell’umorismo. Un’ironia che si ritrova pari pari in “The Golden Spur”: una sorta di testamento, un’ultima brillante istantanea su un quartiere della città, il suo villaggio, che all’inizio degli anni Sessanta si stava trasformando. Vi comparivano i primi beatnick, i primi spinelli di marijuna (“Questi drogati sono piccoli conformisti confusi” li liquida lei, con tagliente ragionevolezza), mentre i vecchi e cari alberghi d’antan finivano sotto le ruspe di costruttori rampanti e gli amici se ne andavano uno appresso all’altro. Ma Dawn non si lascia intimidire dai nuovi lustrini e non molla punto (ha una sete di conoscere e di capire davvero incorreggibile). E va da sé non si rifugia nella nostalgia. Proprio nel cuore della Grande Mela (ripetendo nella fiction quello che tanti anni prima le era capitato) fa approdare il suo protagonista fornendolo di un’analoga curiosità, ma strutturata in una domanda che è insieme romanzesca ed esistenziale: “Chi è il mio vero padre?”. Anche Jonathan Jaimison, dunque, arriva dall’Ohio. A sospingerlo verso la grande metropoli è un soggiorno giovanile della madre che, dattilografa come in tante commedie brillanti degli anni Quaranta, se ne era tornata a casa con il pancione. Il ragazzo si muove fra le diversità delle geografie, il passato e il presente, la folla vecchia e nuova, fra l’innocenza e l’esperienza. Fra individui abbarbicati alla propria identità (in un cinico, vecchio scrittore si può intravedere una parodia di Hemingway) e l’incalzare di nuovi profili social-urbani. Quasi non gli importa venire a capo dell’iniziale quesito edipico. perché intanto, la vita, col suo ritmo e le sue assurdità l’ha catturato. “Questa è l’America ragazzo”, si direbbe in un film. “Questo è il Golden Spur”, ribatterebbe la Powell, con ironico snobismo: è “il bar dove tutti vanno finché non possono permettersi di non venire”. Un locale, si noti fra parentesi, che sta per essere demolito.
– 07/01/2000
The Golden Spur
Una delle più grandi e misconosciute scrittrici americane de Novecento: questo ha proclamato, nel decennio scorso, un inaspettato revival avvenuto negli Stati Uniti, questo promette ora l’editore Fazi con il lancio in contemporanea del primo romanzo di Dawn Powell tradotto in Italia, e di una calorosa biografia a lei dedicata dal giornalista Tim Page. Opere e biografia riservano motivi di interesse: una serie di romanzi popolati di personaggi bislacchi e animati da un saporito spirito di osservazione, in particolare sulla New York artistica e ribelle dove l’autrice visse per un quarantennio; e una vita che miscela elementi drammatici (la precoce morte della madre, un marito alcolizzato, una perfida matrigna, un figlio autistico) con la felicità di amicizie preziose, con Nabokov, Hemingway, Dos Passos, Edmund Wilson…
Escono in contemporanea in Italia l’ultimo romanzo e una biografia di Dawn Powell, l’autrice ammirata di Vidal
una lucida ironia sulla pur amata New York
“La vita vi sembra grigia e senza senso? Invidie e ipocrisie vi deprimono? I romanzo di Dawn Powell possono ridarvi il sorriso”. Con questo incoraggiante messaggio la stampa americana salutava nei mesi scorsi la riscoperta della scrittrice preferita da Ernest Hemingway. Scomparsa nel 1965, la Powell era rimasta viva soltanto nell’attenzione dei suoi fedeli lettori . A ripescarla dall’oblio arrivò per primo, nel 1987, un lungo articolo di Gore Vidal, lo scrittore che da anno vive nello splendido isolamento della sua villa di Ravello, sulla Costiera Amalfitana. Il saggio di Gore Vidal fa adesso a postfazione all’ultimo romanzo della scrittrice (il primo ad essere tradotto in Italia, edito da Fazi contemporaneamente a una sua biografia (Dawn Powell, “The Golden Spur”; Tim Page, “Dawn Powell: una biografia”). Autrice di numerosi romanzi, raccolte, articoli, piéce teatrali, la Powell ebbe una vita di per sé romanzesca. Nata nel 1896 nell’Ohio, rimasta presto orfana di madre e con un padre alcolizzato, subì maltrattamenti fisici o psicologici dalla seconda moglie del padre. A tredici anni scappò di casa dopo che la matrigna le aveva bruciato i suoi primi scritti letterari. Con l’aiuto di una zia poté completare gli studi, e nel 1918 arrivò a New York, dove rimase per il resto della sua vita. “C’è la sola città per ciascuno, come c’è un solo grande amore”, affermò una volta la scrittrice. Lei realizzò entrambe le condizioni, più fortunata nella scelta della città che nel tormentato amore per il drammaturgo John Howard Lawson. The Golden Spur, il bar del Greenwich Village che dà il titolo al romanzo, è il punto di ritrovo di artisti e intellettuali della bohéme metropolitana intorno a cui ruotano le avventure dell’ingenuo Jonathan, il protagonista, arrivato dall’Ohio in cerca del suo vero padre. Accanto all’evidente autobiografismo (la contrapposizione tra la quiete incolore della provincia americana da cui proveniva Dawn Powell e il pulsare vitale delle mille luci di Manhattan), il libro presenta anche le caratteristiche di un moderno romanzo di formazione, con tanto di prove iniziatiche, non necessariamente spiacevoli. E’ così che Jonathan, dopo essersi viste cascare nel letto una dopo l’altra le sue disinvolte compagne d’appartamento, comincia a capire che quando le due ragazze “discutono dei meriti dei loro diaframmi non stanno parlando di canto”. Sorprendentemente attuali i toni con cui vengono toccati temi fra i più rappresentativi della società americana. Prendiamo ad esempio la psicoanalisi: fin dagli anni Trenta, stendersi sul lettino dell’analista era per i newyorchesi dei quartieri alti un segno di appartenenza a un’élite intellettuale, prima ancora che sociale. L’ironia con cui Dawn Powell tratta analisti e pazienti appare dunque molto in anticipo sui tempi; oggi ci abbiamo fatto l’abitudine, in gran parte grazie ai film di Woody Allen. Restando in ambito cinematografico, si è da poco smorzato il clamore suscitato da American Beauty e la sua impietosa messa a nudo della crisi dei valori personali e familiari. Tanto più lungimirante appare allora questa scrittrice che, appena agli inizi degli anni Sessanta, strappa il velo di conformismo dietro cui si celano famiglie apparentemente perfette, ma in realtà corrose da una smania di prestigio sociale che fa preferire a tutti i costi l’apparire all’essere. Fra i pregi della Powell oltre all’intelligente umorismo, il suo essersi mantenuta osservatrice lucida, anzi spregiudicata per i suoi tempi, di quella New York che ha tanto amato, senza celarsene le debolezze e al tempo stesso evitando ogni forma di moralismo.
Dawn Powell e lo stupore del provinciale che scopre la grande città
Con “The Golden Spur” (Fazi, 296 pagine) arriva anche in Italia la Down Powell che in America è stata riscoperta negli ultimi anni e considerata una delle più grandi scrittrici del Novecento Usa da personaggi come Gore Vidal a John Updike. Quelli della Powell non sono romanzi d’amore o consolatori: il suo tema è quello del provinciale che dal Middel west arriva a New York e la città gli pare inaffidabile e frivola, confusa e veloce, ma poi scopre che in tanta amoralità c’è spazio per una personale rilassatezza e libertà, per fare quel che si vuole senza che qualcuno venga a intromettersi. Libri forti, anche aspri, ma che pure hanno quasi una vena fiabesca e tragicomica di grande vivacità, in un gioco tra l’osservazione realistica e un’ottica invece personale e sfuggente, tutta letteraria e metaforica. L’educazione sentimentale di un ragazzino venuto dal suo paesello dell’Ohio tra incidenti di percorso e sconvolgenti promesse.
– 06/06/2000
“The Golden Spur” della Powell
Una città due mondi
Con “The Golden Spur” arriva anche in Italia la Dawn Powell che in America è stata riscoperta negli ultimi anni e considerata una delle più grandi scrittrici del Novecento Usa da personaggi come Gore Vidal a John Updike, ma si è mosso anche un nume delle lettere come Edmund Wilson. Quelli della Powell non sono romanzi d’amore o consolatori, capaci di stimolare le fantasie delle lettrici, anzi, il suo tema, secondo Wilson, è il tema della provinciale che dal Middel West arriva a New York e la città gli pare inaffidabile e frivola, confusa e veloce, ma poi scopre che in tanta amoralità c’è spazio per una personale rilassatezza e libertà, per fare quel che si vuole senza che qualcuno venga a intromettersi. Libri forti, anche aspri, ma che pure hanno quasi una vena fiabesca e tragicomica di grande vivacità, in un gioco tra l’osservazione realistica e un’ottica invece personale e sfuggente, tutta letteraria e metaforica. É un’iniziazione, una moderna e ironica educazione sentimentale, un crescere e rivedere la propria concezione del mondo che pare cambiare al passaggio del protagonista, il giovane Jonathan Jaimision, che è arrivato a New York dal suo paesino dell’Ohio in cerca di suo padre, un’avventura dimenticata della madre quando visse al Village. Prima tappa di questo viaggio simbolico e metaforico è il bar dove la madre faceva tappa fissa, appunto “The Golden Spur”, dove lo rimorchiano due ragazze che lo portano a vivere con loro. É solo il primo di una serie di incontri strani, che lo affascinano e stupiscono, affrontati con ingenua disponibilità e un atteggiamento senza pregiudizi morali. Ultimo romanzo della Powell, “forse il più affascinante” sostiene Vidal, uscito nel 1962, è il ritratto del Village degli anni ‘60. Da una parte una città che sparisce, abbattuta dalla speculazione edilizia, dall’altra una vita che ferve anche nei suoi aspetti più estremi e bizzarri, con artisti poveri e d’avanguardia, la contestazione, la libertà sessuale e i primi movimenti gay e femminili, i disperati e gli illusi, i loft e le cantine, Andy Wharol.
Dalla New York delle avanguardie, Dawn Powell
Un ripescaggio al Village
Fazi porta in Italia una scrittrice del Midwest coetanea di Fitzgerald Hemingway, divenuta compendio, mondano e letterario, della vita artistica di Greenwich Village
Le guide alla New York letteraria non ricordano Dawn Powell, che Fazi propone in Italia con l’ultimo romanzo “The Golden Spur” (postfazione di Gore Vidal, pp. 295) e la vita narrata da Tim Page, Dawn Powell: una biografia (pp. 383). Eppure la Powell, nata nel Midwest come i coetanei Fitzgerald e Hamingway, approdò ventunenne a New York nel 1918, con l’intenzione di scrivere. Vi rimase tutta la vita se si esclude un breve soggiorno a Parigi alla fine del 1950. Lontana dagli entusiasmi degli espatriati, dopo aver annotato sul diario la nostalgia per gli amici maschi, affidabili, senza pari, e la distanza dalle donne francesi (“cosa ne fanno della loro giornata, e soprattutto, della loro ambizione?”), tornò a casa. La Powell si trasferì nel Greenwich Village col marito Joseph Gousha, nel 1924. I diari, bellissimi, iniziati ‘anno seguente, sono – nello scintillio di incontri – un compendio della vita artistica newyorkese. La Powell accompagnò le avanguardie di quasi mezzo secolo, cominciando dai “radical” e dai comunisti degli anni venti e trenta, da Floyd della a John Howard Lawson, e finendo, nei primi anni sessanta, con Djuna Barnes e Lawrence Ferlinghetti. Dei primi non condivise le passioni politiche, esibendo simpatie repubblicane (“I radical del Village. Conversazioni piene di fascino – mi prendevano in giro per la mia ingenuità. Repubblicana”), o invidiando, frivola fino allo spasimo, ciniche corrispondenze dal Primo Congresso degli Scrittori Americani (1935) all’amico Dos Passos, ormai dissociatosi dal comunismo: “Sono scappata, ho preso un treno per Port Jefferson, mi sono chiusa in un bar per due giorni, e fra me e i fucili di Trotsky c’era solo Tom Collins”. Nel Village, “ossigeno per la creatività”, la Powell scrisse, e molto. Sedici romanzi, un centinaio di racconti, commedie, sceneggiature, saggi e recensioni. Pubblicò con le case editrici più importanti e sulle riviste più note, dividendo con Fitzgerald e Hemingway il mitico redattore Maxwell Perkins. Raggiunse l’apice della celebrità all’inizio degli anni quaranta, conquistandosi una certa reputazione come scrittrice brillante, eccentrica, sofisticata, contraddistinta da arguzia tagliente e da una non comune sensibilità per il dialogo. Morì nel 1965, dimenticata, i suoi libri spariti dalla circolazione. Il riconoscimento che la Powell aveva ottenuto in vita non fu commisurato alle sue ambizioni, come lascia trapelare la lettera indirizzata a Perkins all’uscita di “A Time to Be Born” (1940). Irritata che il romanzo venisse pubblicizzato come “libriccino leggero e divertente”, rivendicava l’appartenenza alla satira impegnata, in linea con Dickens e Thackeray. Anche i sostenitori più fedeli, d’altronde, si erano interrogati sulla scarsa fortuna della scrittrice, e se l’inglese J.B. Priestley l’aveva imputata a quel nome, “Alba”, “che fa pensare a romanzi a puntate su riviste ultraromantiche”, il più duro Edmund Wilson, recensendo “My Home Is Far Away”, ne aveva rivelato imprecisioni e incoerenze. E’ possibile che l’etichetta di scrittrice satirica, cucita addosso alla Powell sin dagli esordi, le abbia nuociuto. Il fascino di “The Gloden Spur”, il romanzo del 1962, è da ricercarsi nei toni lirici, evocativi, più che in quelli comici. Il centro vitale, al di là della superficie illusoriamente scintillante fornita dalla descrizione del Village contemporaneo, giace infatti nel ricordo, nel continuo confluire di passato e presente, come segnala il nome del bar “Then and Now”. La vicenda principale, quella del giovane sprovveduto che dalla provincia arriva nella metropoli alla ricerca delle origini, è stata raccontata mille volte nella letteratura americana; Mettere in scena il ventiseienne Jonathan Jaimison, calato dall’Ohio a New York nel 1956, in mano come talismano gli scoloriti taccuini della madre datati New York, 1927, consente alla Powell di ottenere, oltre allo sdoppiamento temporale, un punto focale che attira e unisce gli altri personaggi. Costruisce inoltre uno spettatore privilegiato, uno sguardo innocente attraverso il quale registrare, rinnovandolo sempre, lo stupore infinito provocato dalla città. Osservando per la prima volta dalla finestra la strada sottostante, il protagonista assorbe “il ronzio soddisfatto” di New York, quella mistura di “campane, motori rombanti, fischi, edifici in costruzione, e altri che venivano buttati giù”. Quando scende fra la folla, Jonathan è testimone attonito della demolizione di in intero isolato, fissa una gru gigante, che sollevando il collo verso il cielo fa cadere piano “una grande palla di ferro contro un orologio gigantesco e condannato”, segnalando così che il tratto distintivo del Village “di ora” è la distruzione. Una sagoma si staglia poco dopo, immobile come un manichino di cera, nella visione di Jonathan, ‘i capelli e le ciglia grigioverdi, gli occhi grigio chiarissimo, tutto aveva il colore morto della pelle seppellita per secoli sott’acqua”, ed è un barbone che vende il sangue. Dispiace che simili esplosioni, simili bagliori surreali, caratteristici della scrittura della Powell, non sostengano l’intero romanzo, fagocitati come sono dallo svilupparsi della trama. Lo stupore iniziale si stempera in un ripetersi forsennato di incontri, in un avvicendarsi di personaggi caricaturali, romanzieri inariditi, scrittori falliti, pittori ciarlatani, accademici ubriachi, scrittrici sorpassate, attrici ebeti, mogli castratrici, anziane galleriste sessualmente iperattive, ragazze promiscue che seminando diaframmi puntano al matrimonio. Avviliti, non riusciamo nemmeno a consolarci se scopriamo in questa ridda, sorretti da Vidal, che dietro l’uno si cela Hemingway e dietro l’altra Peggy Guggenheim. Fra i tanti nomi, veri, che occhieggiano nel romanzo, uno in particolare, Edith Wharton, ci fa riflettere che, se sorretta da uno sguardo più benevolo sul contemporaneo e de una visione meno stereotipata dei rapporti fra i sessi, la Powell avrebbe potuto dar voce in modo indimenticabile, come aveva fatto la Wharton prima di lei, a un altro passaggio di new York dal “vecchio” al “nuovo” ordine. e se forse, come è accaduto a tante scrittrici negli ultimi decenni, avrebbe potuto trovare nelle generazioni successive almeno una entusiasta desiderosa di riproporla all’attenzione del pubblico
Dall’Ohio senza rimorsi
La leggenda, anzi il suo biografo, vuole che Dawn Powell, diciottenne nel 1914, pur di essere ammessa in un prestigioso collegio femminile dell’Ohio supplicasse l’austera preside con la seguente frase: “Mi piacerebbe venire nella sua scuola e farei qualsiasi cosa per entrare, dal lavare le scale di servizio a fare la sua sostituta”. Parecchi anni dopo, sia Edmund Wilson che Gore Vidal avrebbero celebrato la sua straordinaria arguzia, l’insuperabile vis comica, un’ironia che la faceva appartenere alla brillante famiglia di Evelyn Waugh e Muriel Spark. troppo tardi, però: Wilson, pur essendole vecchio amico, ne scrisse solo alla vigilia della sua morte, Vidal nel 1987. e solo da quel momento i molti romanzi della Powell presero la via delle ristampe. Lei, intanto, era finita in un cimitero sull’acqua al largo di New York, un’isola dove tutt’oggi trovano sepoltura comune le salme anonime e dimenticate della città. Lo racconta, con deciso attacco cinematografico, Tim Page in una bella biografia dedicata alla scrittrice più “provinciale” del Greenwich Village, un volume che ora l’editore Fazi pubblica insieme al suo ultimo romanzo del ciclo newyorkese, “The Golden Spur” (1962). Orfana di madre, con un padre inseparabile amico dell’alcool e una matrigna al cui confronto quella di Cenerentola era amorevole, la piccola Dawn cresce con lo sguardo sgranato verso un unico sogno: lasciare l’Ohio, raggiungere New York e diventare una scrittrice. Vi sarebbe riuscita, sbarcando nel 1918 in una città che è al massimo dello sforzo per diventare la capitale della modernità. E non l’avrebbe più lasciata, raccontandola con fervore, ma non tralasciando di elaborare il mito della provincia abbandonata. Nel tempo si sarebbe rivelata un’autrice dalle uscite editoriali costanti, ma dal successo alterno. Sfiorando spesso la popolarità, senza raggiungerla mai. Anzi, morendo nella miseria più nera. Ma scrivendo fino all’ultimo. Romanzi, soprattutto, ma anche piéce teatrali, racconti, sceneggiature. Provò anche a lavorare per Hollywood, come molti suoi colleghi scrittori, ma vi rinunciò quasi subito: “Per pazzia”, come ammise con la lucidità che le era propria, prima di ritornare a Manhattan a vivere tra alberghi, ristoranti, pettegolezzi, mondanità, sbornie colossali sue, del marito pubblicitario e di tutti gli amici, rigorosamente anticonformisti e artisti, che popolavano il Village. Personaggi come Dos Passos, o come Dorothy Parker, capace quest’ultima quanto la Powell di sarcasmi taglienti come lamette di rasoio ma assai più nichilista, meno vitale e soprattutto meno abile di lei a narrare per via romanzesca quarant’anni di trasformazioni di quella euforica città. Sono ormai gli anni Sessanta quando Dawn Powell, in “The Golden Spur”, racconta l’approdo a New York di un giovane provinciale, Jonathan Jaimison. Il Village non è più quello di un tempo, ma la voce narrante non si abbandona a nessuna reazionaria nostalgia. Anzi continua, attraverso gli occhi del protagonista, a provarne di curiosità e incanto. Lui, Jonathan, è arrivato per cercare notizie sul suo vero padre, una domanda forte sulla propria identità che lo conduce a incontrare i personaggi più stravaganti. Fra loro è possibile riconoscere anche un vecchio e piuttosto cinico Ernest Hemingway, padre controverso di molti scrittori del secolo, non solo americani. Privo di paure, Jonathan è pian piano sedotto da quelle funanboliche esistenze. da una vita che, eccentrica o normale che sia, continua a chiedere di essere vissuta. Osservata e raccomandata, chi oserebbe indomita la Pawell. Ma c’è una scelta terribile che ricorre nella biografia di questa eccellente scrittrice: immortalata in figlio Jojo, schizofrenico e autistico, mentre alla fine di ogni crisi violenta riduce a brandelli il “David Copperfield” di Dickens e la Bibbia. chissà, forse dentro al suo mondo senza uscita combatteva anche contro i grandi modelli letterari della madre. Lei, invece, proprio affidandosi a tanta tradizione narrativa, al racconto delle storie della vita aveva dedicato tutti i giorni. Con curiosità, con inevitabile dolore, ma anche con il sorriso pungente che si dipinge sulle labbra di chi molto ha capito. Dell’esistenza e della sua assurdità.
Fazi propone l’ultimo romanzo e una biografia della scrittrice americana che riuscì a farsi spazio nei salotti newyorchesi. Una vita segnata dalle difficoltà e dalla sofferenza, fino alla morte. Grazie a Gore Vidal il rinnovato interesse dei critici.
La “scoperta” di Dawn Powell. Attenta cronista dei sentimenti
La riscoperta dei talenti artistici dimenticati dal caso o dalla congiura degli eventi dovrebbe risultare un proficuo lavoro per artisti in crisi d’identità: se ne potrebbero ricavare frustazioni cocenti o conferme dei propri valori misconosciuti, in un’ideale passaparola per i posteri, nel gioco sempre beffardo e affollato dei destini. Ci si sono messi d’impegno Gore Vidal e, prima ancora, Edmund Wilson per disseppellire la voce – neanche troppo ignota nell’America degli anni Trenta e i Cinquanta – di Dawn Powell, definita in termini maiuscoli “la più grande scrittrice comica americana”. Non sappiamo se in Italia la sorte decreterà per lei lo stesso destino di riabilitazione toccato in sorte a un John Fante; di certo ci troviamo di fronte a una voce dai contorni ancora troppo sommari per decretarne la sicura grandezza dopo aver letto un solo romanzo, tra l’altro l’ultimo della sua vita. Dalla concreta e precisa biografia di Tim Page emerge soprattutto il ritratto affettuoso di una piccola donna coraggiosa che, in tempi non sospetti – Powell visse tra il 1896 e il 1965 – affrontò le intemperie del destino a testa alta, creandosi un preciso spazio nella New York degli anni d’oro, con amicizie sparse tra intellettuali e animali da salotto, evidenziando le punte d’iceberg dei Dos Passos, degli Hemingway, dei Wilson. Profuga da un retaggio familiare di serie minore nelle campagne dell’Ohia, Powell riuscì a farsi strada tra un ampio spettro di riviste e romanzi di modesto successo, faticando per tutta l’esistenza a tener la testa fuor d’acqua: un’unione quasi virtuale col marito Jack, un figlio autistico che le segnerà la vita anche economicamente, ma su tutto una ferrea volontà di narrare le frivolezze materiali del proprio tempo, tra cronaca mondana e narrativa ricca di spunti ironici e di arguti pettegolezzi da portinaia laureata. Un primo ciclo di romanzi si ricollega al mondo opaco e rustico dell’Ohio, zeppo di fermenti d’odio e lampi di giovanile nostalgia; dal 1936 prende avvio, con “Turn”, “Magic Wheel”, il ciclo newyorchese, in cui la Powell catapultò le sue profonde conoscenze – popolari e intellettuali – del mondo del Greenwich Village da cui si era lasciata catturare fin dall’arrivo nella Grande Mela nel lontano – e quasi magico – 1918. Dalla biografia di Page si rivela l’entusiasmo di una donna briosa e presente alla sua epoca, in grado di reggere – con alterne fortune – al ritmo del caos competitivo della metropoli, passando con disinvoltura da un editore all’altro ma anche, molto sfacciatamente, da un letto all’altro, senza disdegnare alcun tipo di esperienza. Quasi commoventi le curiosità finali, quando quasi settantenne si poneva domande interessate sulla nuova gioventù sballata tra erba e sesso libero, vagabondaggi e droghe esotiche: vediamo una dama d’altri tempi corpulenta e un pò snob, attratta dall’esperienza e dal contatto con la gente vivace e fricchettona per scelta del Village. La fine fu ovviamente povera e destinata all’oblio, addirittura quello dell’allucinante cimitero degli sconosciuti di Hart Island, tra barboni, neonati abortiti, cadaveri senza nome e vittime della sfortuna. All’orizzonte, le luci sempre accese di Manhattan. La riscoperta di Powell va accreditata soprattutto a Vidal, che la conobbe in anni remoti, quando già comunque era palese il divario tra il grande affabulatore e la volenterosa narratrice delle proprie esperienze. Dalla lettura di questo ultimo – e per noi primo – romanzo, abbiamo tratto l’impressione di una simpatica e attenta cronista dei caratteri, vivace e pungente perché critica, anche da un punto di vista strettamente materiale. Certo, in anni dove operavano nomi Faulkner o Nabokov – piuttosto invisi a Powell – ma anche Hemingway, Dos Passos o i primi fuochi d’artificio di Mailer e dello stesso Vidal, troviamo un’autrice che, se da un lato opera con disinvoltura dal punto di vista ironico nel delineare i suoi personaggi, dall’altro poco si discosta dalle atmosfere e dallo stile un pò datato della Wharton, di Willa Cather o anche del più famoso – all’epoca – J. P. Marquand. La modernità adesso esaltata della Powell probabilmente emergerà da una attenta analisi della sua opera: avvicinandoci a questo “The Golden Spur” abbiamo ricavato l’impressione di un tentativo onesto di rivalutare una scrittrice legata a un mondo e a un’epoca eternizzabili soprattutto nell’atmosfera disinvolta in cui ha vissuto e operato. La storia del provincialotto “Jonathan Jaimison” che dall’Ohio approda a New York convinto di trovarvi il proprio padre reale è grottesca e godibile, ma ricollocabile in un tempo determinato, di difficile sovrapposizione metaforica. Si sorride e si riflette, ma come guardando un vecchio film in bianco e nero dove le ragazzotte ciarlano doppiate con voce da pollaio e i maschietti hanno le sembianze un pò ebeti di un James Stewart qui piuttosto libertino. Una cronaca d’antan, collocabile tra il Babbitt di Sinclair Lewis e i primi vagiti del cronista Tom Wolfe: ma vale la pena di curiosare nel suo mondo zeppo di belle caratterizzazioni, non fosse altro che per decretarne un posto privilegiato nell’analisi di costume di un’epoca e nell’omaggio alla mai troppo osannata madre di tutte le metropoli, New York. Per certi versi, Powell potrebbe funzionare nelle vesti della nonna disinvolta di un McInerney, che allo stesso modo inneggiò in seguito alla città, da protagonista attivo. E questo Powell cercò sempre di esserlo.
– 06/10/2000
L’Italia scopre la sregolata scrittrice americana
Dawn Powell, la preferita di Hemingway
Orfana a sette anni, allevata da una matrigna crudele, moglie di un pubblicitario alcolizzato, madre di un figlio autistico, considerata sempre una scrittrice di second’ordine, sepolta in una tomba collettiva nel cimitero dei poveri di New York. Con una biografia così, stupisce lo stupore di quel critico stizzito perché nei suoi romanzi “non c’è un solo personaggio completamente normale”: come potrebbe? Nella vita di Dawn Powell, però, ci furono anche amicizie brillanti, molto sesso giocoso, un’indomita arguzia e un grande amore ricambiato: quello per la città di New York, dove arrivò nel 1918, all’età di ventun’anni, in fuga dal natio Ohio e da un’infanzia dikensiana; e dove visse fino alla morte nel 1965, soprattutto nel Greenwich Village degli artisti, sempre lo sguardo inebriato del “visitatore permanente”, del provinciale esaltato dal vorticare della metropoli. Fu amica di John Dos Passos, di Edmund Wilson, di Ernest Hemingway, che la definì “la mia scrittrice vivente preferita”: lei, che lo disprezzava, ricambiò la cortesia raffigurandolo in un romanzo come un personaggio caricaturale, arrogante e narcisista, maniaco della caccia, crudele con stuoli di donne adoranti. Eric Von stroheim ricavò il proprio ultimo film da una sua commedia e Gore Vidal, che la conobbe in vecchiaia, le dedicò un tributo postumo (è “la nostra migliore romanziera della metà del secolo”) che scatenò nel decennio scorso un revival in grande stile, “una delle scoperte letterarie più importanti dell’ultimo quarto di secolo” secondo il “New York Times”. E’ piena di riesumazioni, la vicenda di Dawn Powell. Quando era una ragazzina, la matrigna disseppellì la bambina che aveva appena partorito perché era stata sepolta in abiti inadatti, e le mise il vestitino dell’unica bambola concessa alle figliastre: ce n’era abbastanza da scappare di casa, e Dawn lo fece; ce n’era abbastanza da impugnare il lavoro di scrittrice “come uno scudo contro il dolore”, e Dawn fece anche questo, sfornando romanzi e racconti e commedie a decine, nell’arco di un quarantennio. quando era ormai scomparsa da vent’anni, venne invece riesumata lei: i suoi romanzi ormai introvabili furono ripubblicati, e rivestiti con ‘l’abito buono dell’adorazione di critici e lettori. sull’onda del repechage che negli Stati Uniti ha fatto di lei, tardivamente, un’autrice-cult, l’editore Fazi traduce ora il suo ultimo romanzo, “The Golden Spur”, e l’affettuosa biografia che le ha dedicato il giornalista della “Washington Post” Tom Page. Il quale sostiene che Dawn Powell fu negletta in vita perché eludeva e precorreva i valori dell’epoca. troppo anticonvenzionale, troppo libera, troppo maliziosa lei, con quel matrimonio pubblicamente affiancato da tanti amori, con le colossali bevute nei bar del Village, con la sfrenata mondanità. e troppo facilmente scambiata per cinismo l’arguzia dei suoi romanzi: commedie sofisticate, bozzetti paragonati al “Satyricon” di Petronio e alle mordaci opere di Evelyn Waugh. In “The Golden Spur” c’è la figura, tenera e patetica, di una scrittrice dimenticata; con i modi spicci di una pioniera del midwest sbarcata nella Manhattan bohémienne, Dawn Powell prese così in giro anche se stessa e l’oblio che l’avrebbe circondata.
– 06/03/2000
Escono una biografia e il suo ultimo romanzo dimenticato
Dawn Powell un ritorno in grande stile
Amica di Ernest Heminguay e il grande rivale di Dorothy Parker, in “The Golden Spur” concentra i motivi tematici della sua scrittura
Dawn Powell nacque nel 1896 nella città di Mount Gilead, Ohio, Stati Uniti. Sua madre, Hattie Sherman, morì quando lei era ancora bambina. Il padre, Roy King Powell, si risposò qualche anno dopo con Sandra Stearns, donna piuttosto malvagia che fece di tutto per rendersi odiosa. La piccola Dawn e le sorelle Mabel e Phyllis furono sballottate come pacchi postali da una zia all’altra fin quando riuscirono a conquistare l’agognata autonomia. Dawn studiò al Lake Erie College mostrando subito una spiccata predisposizione alla scrittura. Appena le fu possibile, si trasferì a New York dove conobbe l’uomo che diventò suo marito, il pubblicitario Joseph Roebuck. Da lui ebbe un figlio autistico, Jojo, le cui precarie condizioni psichiche lo tormentarono per tutta la vita. Il Greenwich Village, lo storico quartiere degli artisti, divenne per Dawn la seconda pelle. Quando cominciò a pubblicare romanzi, trasfigurò la propria esperienza biografica secondo scelte tematiche univoche; i personaggi ricorrenti sono molto spesso provinciali che si stabiliscono nella metropoli alla ricerca della felicità. La scrittrice, impegnata a fare i conti con problemi di sopravvivenza quotidiana, raggiunse comunque una notorietà abbastanza diffusa negli ambienti letterari ma restò sempre in quella che una volta Henry James definì “la retrovia polverosa” dove sono confinati i romanzieri di seconda schiera. Dawn Powell intrattenne rapporti d’amicizia con John Dos Passos ed Ernest Hemingway. Dorothy Parker fu considerata la sua grande rivale. Edmund Wilson le dedicò alcune pagine affettuose. Ma tutto questo non fu sufficiente a preservarla dall’oblio, specie negli ultimi anni tristi e poveri quando era costretta a improvvisare continui traslochi pur di sfuggire ai creditori. Morì nel 1965 al St. Luke’s Hospital accudita da una vecchia cugina. I suoi resti si trovano oggi nel desolato cimitero di Hart Island, raggiungibile solo in traghetto dai canali interni del Bronx. E questa è un’altra storia da raccontare. Le persone sepolte accanto alla scrittrice furono vagabondi morti di freddo, neonati soppressi, cadaveri di suicidi riemersi a primavera dalle acque dell’Hudson River. Le tombe di Hart Island vengono realizzate usando manodopera residente della prigione municipale di River’s Island, con squadre di volontari che ricevono per la loro opera trentacinque centesimi l’ora. Apprendiamo tali notizie dalla biografia di Dawn Powell scritta da Tim Page che l’editore Fazi pubblica, nella traduzione di Chiara Vatteroni (pagg. 382), unitamente all’ultimo romanzo della scrittrice americana, “The Golden Spur” (trad. Alessandra Osti, pagg. 293), considerato il suo risultato migliore. Pur non avendo letto gli altri libri della Powell (la cui pubblicazione integrale viene annunciata dall’editore italiano), siamo inclini a condividere gli stessi giudizi. La storia di Jonathan Jaimison, protagonista della narrazione, sembra infatti una sofisticata scrematura di motivi tematici sui quali l’autrice lavorò con insistenza ossessiva, sino a farne il centro ispiratore di tutta l’opera. Questo ragazzo arriva anch’egli dall’Ohio a New York in cerca del vero padre che non ha mai conosciuto. Al Golden Spur, il bar un tempo frequentato dalla madre, incontra la classica serie dei possibili candidati e si trova coinvolto in una compagnia di strambi ed eccentrici i quali lo faranno diventare definitivamente adulto. E’, come risulta evidente anche da questo rapido accenno, il tipico tema dell’educazione sentimentale, svolto con sorridente letizia e bonaria ironia, quasi fosse il resto novecentesco dei romanzi familiari del secolo precedente. La Powell si tiene distante da ogni deformazione stilistica e non concettualizza mai il rapporto con la realtà. Il suo genio vive nel talento mimetico. La scrittrice si cala nei mondi interiori altrui senza volerli interpretare, ma allo scopo di conoscerli e scoprire come funzionano. Questa ci pare essere la dote maggiore Dawn Powell, oltre che il suo limite. Chi sceglie dimettersi in posizione laterale rispetto ai personaggi, né sopra,per giudicarli, né sotto, per deriderli, si trasforma in un loro compagno di cordata. L’effetto è spesso comico, senza verticalità espressiva ma con la sapienza di chi conosce il mondo. Ecco ad esempio, in “The Golden Spur” come vengono rese le sensazioni di Alvine che, assai probabilmente, era una controfigura di Ernest Hamingway, nel momento in cui, sdraiato su letto davanti alla televisione, sopra il giovanotto incontrato poco prima, il quale ha fatto sentire padre: “Il figlio Jonathan, un incrocio tra un uomo dello spazio da giornaletto umoristico e n angelo da commedia musicale, si materializzò da una nuvola di schiuma di gomma, ma appena cominciò a trasformarsi nella creatura della Laguna Nera, Alvine si svegliò tanto da allungare un braccio e girare la manopola sul programma di Big Joe, che durava tutta la notte, dove alcuni esperti più terrestri discutevano di alcolismo”. Forse Dawn Powell non sarà “la nostra migliore scrittrice della seconda metà del secolo”, come pare abbia dichiarato Gore Vidal (a mio avviso Mary McCarthy e, soprattutto, Flannery O’Connor, la sopravanzano di una spanna)ma, se ci fosse qualche forma di naturale giustizia, i gabbiani di Hart Island dovrebbero sostare sulla terra dove lei riposa con il rispetto dovuto alle creature che esercitarono bene il talento di cui erano dotate.
– 06/08/2000
Un caso letterario
La signora del Village
La scrittrice Dawn Powell piacque a Dos Passos e a Hemingway. Scomparsa nel ‘65 viene ora riscoperta
The Golden Spur è l’ultimo romanzo di Dawn Powell, ma il primo che arriva in Italia (Fazi, pagg. 293, Traduzione di Alessandra Osti). Fu pubblicato nel 1962. Tre anni dopo Dawn Powell moriva uccisa da un cancro che sigillò un esperienza terrena spaventosamente crudele eppure irrorata da una vena letteraria satirica, disincantata, a tratti beffarda, lieve e divertita. I suoi romanzi raccontano New York, Manhattan e il Greenwich Village in un arco di tempo fra la metà degli anni Venti e i primi anni Sessanta, un periodo di sconvolgimenti frenetici, di mondanità e di ricchezza intellettuale, con la città che cambia volto in modo vorticoso, ma che resta sempre indifferente alla sorte di una folla di artisti e di sfaccendati, di miliardari e di derelitti. Soltanto da poco le qualità di Dawn Powell vengono riconosciute negli Stati Uniti, dove si ripubblicano i suoi romanzi uno dopo l’altro, spinti da una messe di giudizi critici molto lusinghieri che accompagnarono la scrittrice soprattutto negli ultimi anni di vita. Dawn Powell piacque a John Dos Passos e ad Ernest Hemingway, che le furono amici. E suscitò l’entusiasmo di Edmund Wilson: “I suoi romanzi sono tra i più divertenti che siano stati scritti e stanno alla pari con quelli di Anthony Powell, Evelyn Waugh e Muriel Spark”, sentenziò il celebre critico. ”Le persone di spirito non sono mai creature felici”, scrisse la Powell nel 1939. “L’angoscia che ha scorticato i loro nervi lasciandoli scoperti di fronte ad ogni guizzo della vita è la base della loro arguzia”. Dawn Powell nasce in un paesino dell’Ohio nel novembre del 1896, ma la sua infanzia termina a sette anni e precipita nel capitolo di un romanzo gotico (contemporaneamente a The Golden Spur viene pubblicata una sua biografia: Tim Page, Dawn Powell, Fazi, pagg. 382, lire 35.000, traduzione di Chiara Vatteroni). A causa di un aborto muore sua madre e il padre, commesso viaggiatore, si risposa con una donna brutale e psicopatica che al colmo del delirio impone di riesumare il corpo di una figlioletta vissuta solo cinque giorni per rivestirla con gli abiti di una bambola. Appena può, Dawn fugge di casa trascinando l’orrore di quegli anni e il ricordo della matrigna che, scoperti alcuni racconti scritti con calligrafia minuta su un taccuino, li brucia gridando: “Via questa robaccia”. La ragazza vive per qualche tempo con una zia e da lei apprende uno stile spigliato, sessualmente disinibito che stride con i costumi del Middle West. Nel 1918 Dawn è a New York (“C’è una sola città per ciascuno, come c’è un solo grande amore”, scriverà più tardi), metropoli sconfinata agli occhi di una provinciale come lei, abitata – la sola Manhattan – da due milioni trecentomila persone. New York è colta nel momento della sua fioritura liberty, con i grattacieli decorati (il Woolworth Building conta sessanta piani ed è il più alto del mondo), cinquanta quotidiani e duecentocinquanta settimanali. Un provinciale ingenuo che sbarca a New York dal torpore dell’Ohio nei primi anni Sessanta è il protagonista di The Golden Spur. Si chiama Jonathan Jaimison e nei dintorni di Washington Square, in pieno Village, cerca l’uomo che ebbe una relazione con sua madre, traduttrice e amica di scrittori e pittori, e che – solo da poco l’ha scoperto – è il suo vero padre. Jonathan approda in un bar, il Golden Spur, dove sua madre era di casa, un luogo in cui tutti vanno “finché possono permettersi di non venire”, e che tanto assomiglia al Cedar Bar, frequentato a quel tempo da Jakson Pollock e Willem de Kooning. Narratori alla moda e artisti d’avanguardia compaiono anche nel romanzo, attorniati da ragazze che gareggiano per portarseli a letto. Come la piccola Lize, alla quale i quadri dell’amante sembravano tutti uguali, “grandi losanghe rosse e bianche (“io amo il sangue”, diceva sempre), quadrati neri e grigi (“io amo gli scacchi”, diceva), lunghe punte verdi (“io amo gli asparagi”)”. Per cui, “tutto ciò che Lize aveva imparato sull’arte vivendo con i pittori era che i quadri grandi erano per i musei e i piccoli per l’arte”. Dawn Powell ha conosciuto il Village degli anni Venti, quando già si diceva che fosse diventato un trastullo per i turisti, ma dove si affolla comunque un mondo di poeti, ha sede la redazione della New Republic, nei bar e nelle librerie si parla di Nietzsche e di Marx, e l’Urss appare il motore di una rivoluzione che presto avrebbe invaso gli States. Dawn, che ha pubblicato il suo primo romanzo nel 1925, Whither, seguito da She walks in beauty (1928), The Bride’s House (1929), e da Dance Night (1930), conduce vita mondana, frequenta Edward Estlin Cummings e Sherwood Anderson, Ernest Hemingway e Theodore Dreiser. Ma il dolore le resta appiccicato come con lo scirocco una maglietta di seta. Nel 1920 ha sposato Joe Gousha, un uomo attraente che lavora nella pubblicità e da lui ha avuto Jojo, un bambino silenzioso che ha scatti repentini e incontrollabili. Nessuno azzarda una diagnosi. Oggi, scrive il biografo di Dawn Powell, i medici parlerebbero di autismo. Il matrimonio si sgretola. Dawn e Joe, che già ingollavano grandi razioni di Martini e di whisky, sono soggiogati dall’alcol. Stringono altri rapporti, si dividono e poi tornano insieme, coccolati in un ambiente liberalissimo, ma anche immiseriti dall’ indifferenza. Dawn è una scrittrice affermata. Si dedica al teatro e al cinema. Nel 1928 scrive una commedia, The Party, in cui un dirigente pubblicitario presenta a sua moglie un ricco cliente e fa pressioni perché ci vada a letto. Dieci anni dopo pubblica The Happy Island, un romanzo popolato da gay. In realtà il protagonista delle sue pagine è sempre il Village, con la sua multiforme antropologia. “Ovunque, ma non a New York”, scrive a un cugino, “devi nascondere le tue umili origini e fingere che, in famiglia, tutti siano bianchi e sappiano leggere, scrivere e suonare l’arpa. Le persone veramente di classe sono convinte che fare l’accidente che ti pare, senza curarti di quello che pensano gli altri, sia il contrassegno dell’aristocrazia”. La sua penna è intinta nella ferocia e nella compassione insieme. Dawn è contemporaneamente dentro e fuori le sue storie, si mantiene a distanza dai suoi personaggi, ma ne porta impresse le ferite. Dopo la guerra ha un tracollo. Joe viene licenziato e quello che Dawn guadagna non basta a mantenere se stessa e il figlio Jojo, sempre più spesso ricoverato. Per loro arrivano lo sfratto e una vita raminga fra pensioni e amici ospitali. Dawn è sbandata, l’alcol la paralizza, ma porta ugualmente a termine The Golden Spur. A metà novembre del 1965 Dawn si spegne dopo una dolorosa malattia. Il suo corpo viene seppellito ad Hart Island dove vanno a riposare in eterno gli homeless trovati assiderati in un sacco, le persone senza nome e i cadaveri recuperati nel fiume Hudson. Gore Vidal: A me ricorda Petronio e il suo Satyricon Per decenni, Dawn Powell è stata sul punto di non essere più un culto e di diventare una religione più importante. A dispetto però dell’opera di cultori zelanti quali Edmund Wilson e Matthew Josephson, John Dos Passos ed Ernest Hemingway, Dawn Powell non divenne mai la scrittrice popolare che avrebbe dovuto essere. In quei giorni, con un pizzico di fortuna, un buono scrittore attirava lettori volontari e diventava popolare. Oggi, ovviamente, “popoalre” equivale invece a cattiva scrittura letta da un pubblico vasto, mentre la buona scrittura è quella che viene insegnata a lettori involontari. Dawn Powell fallì sia nell’una che nell’altra cosa. Non ha bisogno di alcuna interpretazione e nel corso della sua esistenza avrebbe dovuto essere letta da un pubblico altrettanto vasto di quello di Hemingway, diciamo, o del primo Fitzgerald. Dawn Powell però era un mostro inconcepibile, una donna arguta che non riteneva doveroso pagare un prezzo, seppure basso, e tantomeno uno alto, all’Amore o alla Famiglia; vedeva la vita con una neutralità petroniana, e ogni ospite alla festa della vita era un potenziale Trimalcione da prendere in giro. (dalla New York Rewiew of Books) John Updike: Straordinaria quella vena leggera. Sembra che la reputazione di Dawn Powell sia destinata a essere perennemente riproposta. Il suo talento di narratrice – fatto di agilità, umorismo, sapienza, compassione e poesia – è troppo grande perché si possa dimenticarla. D’altra parte però, non è un’autrice tanto emblematica da imporsi tra gli esemplari in mostra nello zoo dei romanzieri americani accademicamente imposti. Sono Hemingway, Faulkner e Fitzgerand i grandi, sfavillanti animali del loro tempo. Al loro fianco, uno Steinbeck o un Lewis appaiono un po’ più grevi, ma è impossibile ignorarli. Dawn Powell avrebbe potuto trovare un suo spazio nelle antologie se, come Katherine Ann Porter, Dorothy Parker o Mary McCarthy, avesse dato il meglio di sé nei racconti brevi. Per esprimere la sua visione del mondo, Dawn Powell aveva bisogno del canovaccio ampio di un romanzo in cui sviluppare punti di vista molteplici da una prospettiva aerea, distaccata. Dawn Powell si colloca – con la sua vena leggera – accanto a Dreiser, a Cather e ad altri autori del Midwest, fra coloro che hanno percepito il senso epico del grande esodo dalle aree rurali a quelle urbane, dal chiuso della provincia alla liberazione metropolitana. (dal New Yorker)
– 06/01/2000
“Io i letti non li faccio, li disfo”; “Meglio le risse da caffé che le liti da famigliola felice”
La maledetta del Village
Eroina dei bar notturni, stimata da Hemingway, morì alcolizzata e in miseria. Eppure New York non sarebbe stata la stessa senza di lei
Forse meglio di qualsiasi scrittore americano, Dawn Powell ha saputo descrivere New York fra gli anno 20 e i 60. e in particolare una piccola parte della città, il Village, quartiere con il massimo condensato di vita artistica e bohémienne, almeno in quel periodo. John Dos Passos, suo grande amico, la definì “una delle donne più argute e impetuosamente coraggiose che abbia mai conosciuto”. Ernest Hemingway diceva che era la sua “autrice vivente preferita”. John Updike ha usato aggettivi superlativi: “divertente, dotata, umana, poetica”. Eppure, conosciuta da tutti nell’ambiente culturale newyorkese della sua epoca, amata o detestata per le intemperanze alcoliche e caratteriali, autrice di una quindicina di libri, commedie e qualche sceneggiatura per Hollywood, Dawn Powell non riuscì mai in vita a raggiungere quel successo che forsennatamente rincorreva. Doveva passare un trentennio dalla morte (aveva sessantotto anni, nel 1965), e ci voleva la caparbia energia di un suo grande ammiratore, Gore Vidal, per riesumarla dalle tenebre e riproporla a un pubblico finalmente attento e più vasto dei tremila lettori di culto cui era condannata. Ora, tradotta in molti paesi, si è sistemata fra i grandi protagonisti del mito di una città straordinaria. In Italia è Fazi a raccogliere la sfida del lancio prostumo. Lo fa presentando in contemporanea due libri: il romanzo “The Golden Spur” (dal nome di un celebre bar del Greenwich Village), che è l’ ”ultimo testamento” di Powell, e la “Biografia” che di lei ha scritto Tim Page, curatore anche dei suoi leggendari “Diari”. Una scelta giusta, visto il contenuto fortemente autobiografico della sua opera e il carico carismatico della sua presenza sulla scena newyorkese. “The Golden Spur” è il caustico ritratto di quel quartiere di artisti veri e presunti, di ambizioni spesso sbagliate, di piccoli arrivisti e grandi fallimenti, ma comunque “Isola Felice” Dawn Powell era nata dell’Ohio nel 1896, seconda di tre sorelle dall’infanzia tormentata. La madre morì giovane, sembra per un aborto clandestino, e il padre, affascinante figura di eterno ragazzo, si risposò dopo tre anni con una donna chiaramente isterica che riversò sulle bambine la sua nevrotica infelicità. appena poté (a 22 anni) Dawn scappò nella grande metropoli. E qui finalmente si gettò nel turbine della vita tra artisti, sposati, alcolizzati e mitomani al pari di lei. E amò e scrisse e fece pasticci sentimentali. Come tutti i suoi amici, che si chiamavano Dorothy Parker, Edmund Wilson, Sherwood Anderson, oltre a Hemingway e Dos Passos. Ma New York non fu generosa con lei. I suoi libri erano un fiasco dopo l’altro. Le commedie che riuscì a far rappresentare a Broadway ebbero sorte ancor più fallimentare. Si sposò con un gentile pubblicitario, più ubriacone di lei, ed ebbe un figlio autistico, il cui destino di internato la angustiò ogni momento della sua vita. Spiritosa, amara, d’un feroce realismo, non è una scrittrice consolatoria né leggera. Eppure nei bar del Village era sempre attesa come chi saprà comunque tirar su la serata, con le sue battute e le sue acidità, con le sue passioni per i ragazzi, con la sua irrefrenabile voglia di essere allegra malgrado tutto. Manhattan si palleggiava le sue battute: “Io i letti non li faccio, li disfo”; “Sono il tipo di persona che preferisce partire più che tornare a casa”; “Qualsiasi rissa da bar è meglio delle continue punzecchiature della famigliola felice”… Anche sul letto di morte Dawn Powell seppe essere all’altezza del suo personaggio. A chi le chiese cosa le stava succedendo, rispose: “Non so che cosa mi abbia preso. Ma certo che lo so. Sto morendo”.
Libri dello stesso autore
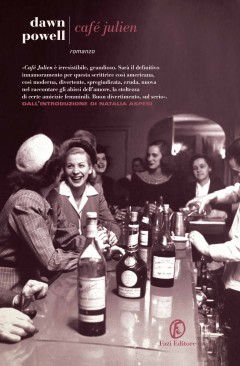

Gabbia per amanti
Dawn Powell
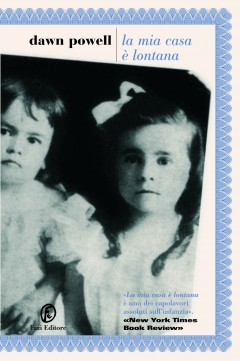
La mia casa è lontana
Dawn Powell

Un tempo per nascere
Dawn Powell
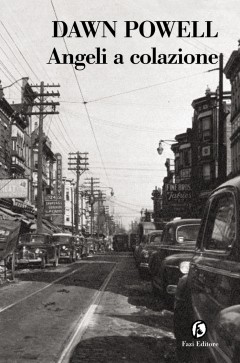
Angeli a colazione
Dawn Powell






