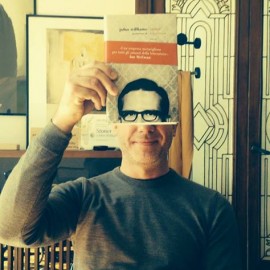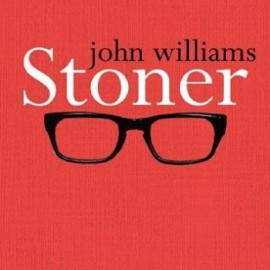Ave Augusto! Ma chi era?
• Il blog di Fazi Editore - Recensioni
Vi proponiamo il saggio di Daniel Mendelsohn apparso come introduzione alla nuova edizione di Augustus della NYRB Classics e pubblicato su The New York Reviews of Books con il titolo Hail Augustus! But Who Was He?.
1.
Se paragonato ai romanzi precedenti di John Williams, Augustus – l’ultima opera pubblicata dall’autore, poeta e professore il cui Stoner, dopo l’oblio, è diventato recentemente un caso editoriale internazionale – potrebbe sembrare piuttosto strano. Innanzitutto, è stato l’unico dei suoi quattro romanzi ad aver suscitato grande entusiasmo mentre Williams era ancora in vita: pubblicato nel 1972, Augustus ha vinto il National Book Award per la narrativa. (Williams è nato in Texas nel 1922 ed è morto in Arkansas nel 1994, dopo una carriera trentennale da professore di Letteratura inglese e Scrittura creativa all’Università di Denver).
Ancora più importante, il tema del romanzo – la vita e la carriera di fondamentale importanza storica del primo imperatore di Roma – sembra remotissimo dalle preoccupazioni prettamente americane delle altre opere della maturità di Williams, coi loro protagonisti dimessi e una scrittura scarna. Butcher’s Crossing (1960) è la storia di un giovane bostoniano che, infervorato dal trascendentalismo di Emerson, nel 1876 si sposta verso occidente per esplorare «la natura selvaggia» dove, ne è convinto, risiede «il senso più profondo che possa dare alla sua vita»; e dove prende parte a una disumana caccia al bisonte che fa vedere qual è il costo del sogno americano.
Stoner (1965) tratteggia la vita oscura e, in apparenza, fallimentare di un professore di Letteratura inglese all’Università del Missouri, a cavallo tra l’inizio e la metà del secolo scorso. Un uomo di umile e misera estrazione, che vede nell’Accademia un «rifugio», un posto dove finalmente ritrovare «quella sicurezza e quel calore che gli erano mancati a casa da bambino». (In seguito Williams ha disconosciuto il suo primo romanzo Nulla, solo la notte, pubblicato nel 1948, che narra di un dandy con problemi psicologici).
Sarebbe difficile trovare, per questi nobili e in definitiva disillusi personaggi minori, un personaggio che avesse con loro meno cose in comune di quel leader mondiale realmente esistito che la storia ci ha fatto conoscere col nome di Augusto; un uomo i cui nomi, numerosi e sofisticati, dati e ricevuti, estesi e resi più elaborati, acquisiti e messi da parte lungo gli ottant’anni della sua vita tumultuosa e straordinaria, offrono un contrasto quasi comico rispetto ai semplici bisillabi che Williams ha dato agli altri due protagonisti. Entrambi, come i lettori noteranno, condividono il nome del loro creatore – William Andrews, William Stoner: una coincidenza che rende quasi impossibile non scorgere qualche elemento autobiografico nei suoi primi romanzi.
Nessuna tentazione di questo genere si ritrova in Augustus. L’imperatore, che con la solennità del proprio nome ha definito una stagione politica e letteraria, nacque come Gaius Octavius Thurinus nel 63 a.C, l’anno in cui Cicerone vanificò il tentativo di colpo di Stato da parte dell’aristocrazia contro la Repubblica. Figlio di Gaius Octavius, un facoltoso pretore di famiglia plebea, venne cresciuto nelle province a circa quaranta chilometri da Roma. Quando era ancora adolescente, sebbene cagionevole il giovane era comunque abbastanza sveglio e ambizioso da fare colpo sul suo prozio materno, Giulio Cesare, tanto che questi decise di adottarlo. Da allora fu chiamato Gaius Julius Caesar Octavianus (“Ottaviano”).
Nel 44 a.C., dopo l’assassinio di Cesare e la sua successiva deificazione per decreto del Senato, il diciannovenne, che smaniava per avvantaggiarsi del prestigio del parente morto e così ottenere maggior credito tra i veterani di Cesare, con grande scaltrezza si fece chiamare Gaius Julius Caesar Divi Filius (‘Figlio del Dio’). Non ancora venticinquenne, dopo aver vendicato l’omicidio di Cesare con la disfatta di Bruto e Cassio a Filippi, il nuovo Gaius Julius Caesar attraverso stratagemmi e astuzie si era insediato al centro del potere romano come dittatore militare o “triumviro”, ruolo che condivideva con altri due (uno dei quali era Marco Antonio, col quale entrerà in guerra). A questo punto, “Gaius” e “Julius” spariscono per essere sostituiti da “Imperator”: un titolo militare usato dai soldati per acclamare i comandanti vittoriosi, nonché la radice della parola inglese “emperor”.
Nei dieci anni successivi l’“Imperator Caesar Divi Filius” aveva vittoriosamente strappato il controllo dei vasti domini romani dalle mani del suo unico rivale, Antonio, che venne sconfitto ad Azio nel 31 a.C. e si suicidò un anno dopo, insieme alla sua amante Cleopatra. (Quando ordinò di uccidere il figlio adolescente di Cleopatra, Caesarion – un possibile rivale, dal momento che il padre era proprio Giulio Cesare – osservò che: «Troppi Cesari non sono un bene»). A trentatré anni era il signore del mondo e si occupò pertanto di consolidare il proprio potere, usando ogni stratagemma per legittimare il suo governo autocratico attraverso le strutture della tradizionale legge repubblicana e istituendo le fondamenta legislative, politiche e culturali di un impero che sarebbe sopravvissuto, in una forma o in un’altra, per i successivi quindici secoli.
Uno dei titoli che questo personaggio dotato di una sagacia strabiliante non utilizzò mai fu rex, ‘re’, una parola talmente detestata dai romani che per alcuni di loro, la paura che Cesare volesse diventarlo era una ragione valida per il suo omicidio. Il signore del mondo si faceva chiamare princeps, ‘primo fra i cittadini’. Nel 27 a.C., il Senato, con ogni evidenza grato al nuovo Cesare per aver messo fine a un secolo di sanguinosi scontri civili e aver portato stabilità nella politica interna ed estera, votò a favore di un’ulteriore onorificenza da aggiungere ai suoi nomi, che aveva una suggestiva associazione religiosa: augustus, ‘colui che dev’essere adorato’. Il nome col quale è conosciuto non ha alcuna somiglianza con quello con cui è nato.
Nessuna somiglianza con la propria precedente personalità: qui risiede la celata affinità tra Augustus e i suoi due predecessori. Un grande tema dell’opera di Williams è come la nostra percezione di chi siamo possa essere alterata in maniera irrevocabile da circostanze e colpi del destino. Nel suo romanzo su Augusto, Williams si sforza di andare oltre la sfavillante parata della storia e si concentra su quanto di quell’uomo sfugge – un uomo che, più di molti altri, deve originare nuove personalità per avere la meglio. Nel suo ultimo romanzo, la sorpresa consiste nella scoperta che il suo famoso protagonista non è poi così diverso dagli altri eroi delusi partoriti dallo stesso autore; il che significa né meglio né peggio di gran parte di noi. Questa spettacolare saga storica riguarda quanto di più intimo e profondamente umano ci sia.
2.
La vita del primo imperatore è un tramite ideale per un romanzo storico: Augusto è uno di quei personaggi di cui sappiamo al contempo molte cose e quasi nulla, per cui stimola tanto il racconto quanto l’invenzione.
Le biografie e le dicerie, le testimonianze e le congetture comparvero già quando l’imperatore era ancora in vita. Un amico e contemporaneo di Augusto, il quale fa parte dei personaggi del romanzo di Williams, ne scrisse una Vita: il filosofo e storico Nicola di Damasco, precedentemente precettore dei figli di Antonio e Cleopatra. L’imperatore stesso compilò un’autobiografia ufficiale, Res Gestae Divi Augusti (‘Gli atti del divino Augusto’), che voleva essere con tutta evidenza una forma di propaganda politica. Inscritta su lapidi di bronzo affisse sui portali del suo mausoleo, venne riprodotta in tutto l’Impero.
Se prestiamo fede a Tacito, che scriveva un secolo dopo il regno di Augusto, l’impenetrabilità della natura e delle ambizioni dell’imperatore era già un argomento di conversazione presso i suoi contemporanei. Nei suoi Annales, lo storiografo riporta, parafrasandola, una discussione avvenuta alla morte dell’imperatore, all’età di settantacinque anni, nel 14 a.C.:
«Alcuni affermano che: “Non ebbe altra scelta se non la guerra civile sia per l’onere che lo legava al padre [Giulio Cesare], sia per le necessità imposte dallo Stato, dove all’epoca non c’era spazio per il governo della legge […] e per un paese in guerra contro se stesso non c’era altro rimedio che il governo di un sol uomo”».
E tuttavia:
«D’altro canto, veniva sostenuto anche che: “L’onere che lo legava al padre e l’emergenza dello Stato erano serviti come puro pretesto; era per sete di dominio che aveva invece mobilitato, grazie a cospicue elargizioni di denaro, i veterani […]; estorto il consolato a un Senato riluttante e rivolto contro la Repubblica l’esercito che gli era stato affidato per combattere Antonio. Ci furono proscrizioni di cittadini e le terre vennero redistribuite […] Senza dubbio, dopo tutto ciò si ottenne la pace, ma fu una pace che aveva versato sangue”».
L’imperatore ha, forse, affinato una certa opacità come strumento per la gestione del potere: se era difficile da indovinare ciò che lo muoveva, non era molto diverso per le sue azioni. Nulla di sorprendente quindi nel fatto che il suo sigillo ufficiale fosse l’enigmatica e misteriosa Sfinge.
Come scrivere di una figura simile? La domanda, in Augustus, viene furbescamente messa in bocca al biografo dell’imperatore Nicola. «Capisci cosa intendo», lo studioso scrive perplesso, dopo un incontro con Augusto, incapace di conciliare la celebre prudenza dell’imperatore con la sua altrettanto celebre propensione al gioco d’azzardo. «Sono così tante le cose che non si dicono… Se davvero esiste una tecnica, per dire tutto ciò che va detto, forse qualcuno deve ancora inventarla».
Qui Williams si diverte con i riferimenti interni al testo: la forma che Nicola vagheggia – che è, ovviamente, quella che Williams finirà per utilizzare – è il romanzo epistolare, un genere che sarà inventato soltanto quindici secoli dopo Augusto. Eppure, le sue radici risalgono al suo regno. Il poeta romano Ovidio – anch’egli personaggio di Augustus, sempre aggiornato sui pettegolezzi della corte imperiale – scrisse un’opera intitolata Heroides (Eroidi), una serie di lettere in versi di eroine mitologiche indirizzate ai loro amanti.
La forma dell’epistolario, associata per lungo tempo a temi romantici, è in realtà cucito alla perfezione sul progetto quasi biografico di Williams. (Questa forma è stata utilizzata con gran successo da Thornton Wilder in Idi di marzo, il suo romanzo del 1948 sull’assassinio di Giulio Cesare). Il quadro che Augustus crea, restituitoci non solo da lettere (inventate) ma anche da estratti di diario, decreti senatoriali, ordini militari, appunti privati e storie incomplete, è esauriente nella sua complessità e al contempo misurato nel suo impressionismo, individuale. Gli autori delle lettere inventate e dei documenti sono, con pochissime eccezioni, personaggi realmente esistiti e Williams, che ha sempre manifestato insofferenza verso il rozzo “aggiornamento” del passato di una certa narrativa storica, si è evidentemente goduto l’opportunità di immedesimarsi in alcune personalità piuttosto note.
Ecco, dunque, l’acume e la vanità di Cicerone, l’oratore che, nonostante la sua opposizione a Giulio Cesare, si alleò a un certo punto col giovane Ottaviano che, all’inizio, sottovalutò pericolosamente. («Il ragazzo non vale nulla, e non dobbiamo temere alcunché […] In passato sono stato gentile con lui e ho ragione di credere che mi ammiri […]. Sono troppo idealista, lo so – lo riconoscono anche i miei amici più cari»). Ed ecco anche Ovidio, un uomo di mondo che, mentre racconta al suo amico Properzio della giornata passata ad assistere ai giochi dal palco dell’imperatore, lo infioretta con affettato lirismo: «[…] mentre il sole cominciava a sorgere, arrancando in quella selva di edifici che è Roma […]».
Anche quelle personalità che hanno lasciato poche tracce del loro stile di scrittura risultano estremamente vitali e, per quanto le testimonianze storiche ci permettono di sapere, verosimili. Mecenate, il facoltoso patrono delle arti amico di Orazio, Virgilio e Augusto – che prendeva in giro lo stile effeminato del suo amico – ci viene presentato come un esteta («molto è stato detto su quegli occhi, spesso in cattiva metrica e prosa anche peggiore») con un pizzico di acciaio. Livia, l’ambiziosa terza moglie di Augusto, madre del suo successore, Tiberio, emerge come un’impassibile pragmatica, non più subdola delle persone che la circondano: un personaggio molto più convincente che l’avvelenatrice granguignolesca che si ritrova in Io, Claudio di Robert Grave. «Il nostro avvenire è più importante di noi stessi», scrive al proprio figlio la concretissima Livia di Williams, pretendendo che lui divorzi dalla sua amata moglie così da poter entrare nella linea dinastica di Augusto attraverso l’unione con la figlia, Giulia, che lui detesta.
E Williams adopera estratti inventati da delle perdute memorie di Marco Agrippa – il grande amico d’infanzia di Augusto, comandante fautore delle sue vittorie militari, infine suo genero e padre dei suoi eredi – per dare l’arida, prosaica versione “ufficiale” dei fatti: «E dopo aver formato il triumvirato, e schiacciato i nemici di Giulio Cesare e Cesare Augusto, restavano ancora a Occidente le forze del pirata Sesto Pompeo e a Oriente gli assassini in esilio del divino Giulio […]».
Williams sa disporre dei tic stilistici in maniera convincente: ad Agrippa dà quello di cominciare le frasi con “e”. Una critica che si può muovere ai suoi primi romanzi è che l’autore a volte lavora così tanto per rendere la scrittura “bella” che finisce per lavorare a detrimento della credibilità; Will Andrews, in Butcher’s Crossing, si esprime spesso in maniera ricercata, il che stride data la sua giovane età. Il ventriloquio che gli s’impone con l’epistolario di Augustus mette al riparo Williams da questo vizio. È la sua opera più rigorosa.
Una scelta avveduta nella composizione di Augustus è stata quella di non svelare la voce dell’imperatore fino alla fine, dove l’ascoltiamo in una lunga (di nuovo inventata) lettera a Nicola di Damasco, che costituisce la breve sezione finale del romanzo. Nessuna sorpresa, quindi, che il resoconto dell’imperatore sul suo passato non collimi con molte delle supposizioni e delle congetture che l’hanno preceduto. Ad esempio, viene fuori, in quel frangente, che ciò che all’epoca un amico aveva interpretato come il pianto afflitto e confuso del giovane Ottaviano alla notizia dell’assassinio di Cesare era – o quanto meno, è quello che l’anziano imperatore ora avrebbe fatto credere al suo amico – nient’altro che un’espressione di «nulla […] gelo», seguita da un sentimento di trionfo: «provai una sorta di sollievo […] avevo compreso il mio destino».
Come a rimarcare l’incolmabile distanza tra ciò che si percepisce e ciò che è vero, tra la narrazione ufficiale delle nostre vite e quella ufficiosa, quella pubblica e quella privata, Williams inframezza questa mini-autobiografia inventata, e man mano che si procede sempre più coinvolgente, con estratti in corsivo delle Res Gestae Divi Augusti. Dove si trova la verità di una vita? Dopo la lettura della biografia autorizzata di Nicola (e la riflessione sulla biografia ufficiale scritta di suo pugno), l’Augusto di Williams commenta sarcastico che «quando leggo quelle opere e scrivo di me stesso, mi pare di leggere e di scrivere di un uomo che portava il mio nome ma che quasi non conosco».
Per chi scrive romanzi storici quell’inconoscibilità può risultare un vantaggio. Allo stesso modo delle migliori opere di narrativa storica ambientate nel mondo classico – Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, Idi di marzo di Wilder, il romanzo di Grave su Claudio, la rievocazione dell’Atene del V secolo nel romanzo di Mary Renault Le ultime gocce di vino – Augustus fa trasparire il passato senza la pretesa di ricrearlo.
3.
Il semplice tentativo di ricreare il passato non avrebbe lasciato spazio alle importanti considerazioni letterarie che stanno al cuore di Augustus e delle altre opere dell’autore. In un’intervista del 1985, Williams ha descritto ciò che lui riteneva un tema comune sia a Stoner che ad Augustus:
In entrambi i casi mi stavo occupando dell’autorità, e delle responsabilità individuali, e di ostilità e alleanze… A eccezione delle proporzioni, le macchinazioni del potere sono più o meno le stesse in un’università come nell’Impero Romano…
L’effetto del potere (e la lotta per il potere) sugli individui è, infatti, un tema dell’episodio nel regno di Augusto che per primo ha irretito l’immaginazione di Williams e mette in moto il romanzo. Non molto dopo la pubblicazione di Butcher’s Crossing, aveva sentito la storia dello scandalo devastante che aveva scosso l’impero e la famiglia imperiale: nel 2 a.C. Augusto fu costretto a mandare in esilio la sua adorata e unica figlia in una minuscola isola chiamata Pandataria. Una delle accuse era adulterio – una violazione della rigida legge morale che il padre aveva istituito come parte della sua campagna per ristabilire le virtù romane tradizionali nel nuovo Stato. (A quel tempo Giulia, intrappolata in un rancoroso matrimonio con Tiberio, era nota per le sue flagranti infedeltà coniugali). Un altro era il tradimento: viene lasciato intendere in modo piuttosto palese che alcuni degli uomini che lei si era scelta come amanti facessero parte di una fazione ostile alla successione di Tiberio.
Nel racconto di questa donna piena di determinazione, condotta dalle sue passioni a un disastroso conflitto con i suoi doveri, Williams intravedeva un tema di grande interesse: quello che lui chiama «l’ambivalenza tra la pubblica necessità e il volere o il bisogno privati». È su questa tensione che la sua Giulia, tra i personaggi più penetranti e stupefacenti del romanzo – intelligente, ironica, ribelle, smaliziata, filosofica –, spende parole piene di livore nel diario di Pandataria che Williams inventa per lei:
È strano aspettare in quest’inerzia, dove nulla conta. Nel mondo in cui ho vissuto, tutto era potere: e ogni cosa contava. Si amava, perfino, in nome del potere; non più per il gusto d’amare, ma per le innumerevoli gioie del potere.
Non è un caso che Augustus possa suddividersi in due parti principali: la prima narra della sua improbabile e trionfale ascesa al potere, mentre la seconda, raccontata in presa diretta dal diario di Giulia, cartografa la disintegrazione della sua famiglia e della sua felicità, in gran parte conseguenza delle sue macchinazioni volte alla perpetuazione del proprio potere attraverso matrimoni dinastici mal assortiti. In altre parole, la prima parte riguarda il suo successo nella sfera pubblica e politica, la seconda il fallimento della sfera privata e affettiva – l’ultima, lascia intendere Williams, come possibile scotto della prima.
Il conflitto tra individui e istituzioni è il centro nevralgico anche di Stoner – il libro che Williams ha scritto subito dopo essere venuto a conoscenza della storia di Giulia, il cui profilo il racconto di Stoner cerca in qualche modo di rovesciare. Tant’è che il frustrato eroe eponimo del romanzo diverse volte accantona il proprio volere in favore di doveri più grandi. La storia d’amore con una dottoranda empatica lenisce per troppo breve tempo il suo infelice matrimonio. (Il ritratto più significativamente meno riuscito è quello della bisbetica moglie di Stoner: ideata per rendere la sua vita orribile, risulta molto più malevola del necessario). La paternità: Williams se la cava particolarmente bene con la tenerezza delle relazioni padre-figlia, in Stoner come in Augustus.
C’è poi una mediocre carriera, sostenuta con delicatezza da pochi e accorti alleati e aperta alle minacce da parte di uno o due nemici dell’accademia che, nel corso del tempo, non ha potuto evitare di farsi. Uno, infastidito dalle critiche di Stoner al proprio protégé, riesce a impedire gli avanzamenti di carriera e la felicità di Stoner per molti anni. In Augustus, il personaggio di Salvidieno – un caro amico d’infanzia dell’imperatore che finirà per tradirlo – osserva nei suoi “Appunti per un diario” che: «Ogni successo rivela difficoltà impreviste e ogni vittoria aumenta la portata di una nostra eventuale sconfitta». Questo è un altro dei principali temi di Williams.
E tuttavia l’opera di Williams non si può ridurre a una serie di parabole su individui che lottano contro, e dentro, le istituzioni. Tra le altre cose, questo tipo di approccio non sarebbe valido per Butcher’s Crossing, un’opera nel quale le limitazioni della società e delle sue istituzioni sono quasi del tutto assenti; semmai, è proprio la loro assenza che produce alcuni degli esiti spaventosi di quel romanzo, che traccia la china del personaggio, durante e dopo la caccia al bisonte, verso un primitivo stordimento asociale («il cibo e il sonno divennero le uniche cose importanti»).
Il tema principale svolto in tutti e tre i romanzi della maturità di Williams è in effetti piuttosto ampio: si tratta della scoperta che, per metterla con le parole che Stoner usa quando sta lasciando la sua amante per salvaguardare il lavoro e la famiglia, «in fondo, apparteniamo al mondo». Tutta l’opera di Williams si occupa del modo in cui, qualunque siano la nostra indole o i nostri desideri, le vite che finiamo per condurre sono spesso i prodotti inaspettati degli attriti tra noi e il mondo – che quel mondo sia cultura o natura, l’espansione fintamente edenica dei territori del Colorado o gli angusti corridoi di un’università statale, la carneficina di una caccia al bisonte o le proscrizioni del Senato romano. In Augustus a un certo punto una persona in visita a Roma chiede al precettore di Ottaviano, ancora ragazzo, come sia il giovane imperatore e l’anziano saggio greco risponde: «Diventerà quel che deve, in virtù della sua forza di carattere e dei capricci del Fato».
Un’incontrovertibile e semplice conclusione di tutti e tre i romanzi è che l’attrito tra “la forza di carattere” e “i capricci del Fato” diventa, spesso e volentieri, erosione: un processo che confonde l’immagine che abbiamo di quello che siamo, rivelandoci al suo posto un estraneo. Prima che Will Andrews parta per la caccia al bisonte, una dolce prostituta, che lui vorrebbe ma non riesce a portarsi a letto – la perdita della sua innocenza assumerà un’altra forma, durante e dopo la caccia –, ammonisce quel bellissimo ragazzo dalla pelle morbida dicendogli che cambierà e si temprerà. Questa profezia si avvera pressoché alla lettera al culmine della macellazione del bisonte:
«Nel buio, Andrews si passò una mano sul viso e al tatto gli parve ruvido e strano […] si chiese se Francine, vedendolo in quel momento, l’avrebbe riconosciuto».
Allo stesso modo, Stoner capisce alla fine della sua vita che qualunque ideale avesse perseguito, sarebbe capitolato di fronte al caso e al bisogno, che lo avrebbero reso diverso da quello che aveva sperato:
«Aveva sognato di mantenere una specie d’integrità, una sorta di purezza incontaminata; aveva trovato il compromesso e la forza dirompente della superficialità. Aveva concepito la saggezza e al termine di quei lunghi anni aveva trovato l’ignoranza. E che altro?, pensò. Che altro?».
Lo stesso vale per Augusto, i cui molti nomi riflettono con particolare vividezza quel processo di evoluzione dagli esiti imprevedibili e di irreversibile erosione che tanto affascina Williams. Augusto è riluttante a riconoscere che pace e stabilità, per le quali ha lottato così a lungo e sulle quali ha imperniato carriera e reputazione, potrebbero, dopo tutto, non essere quello che i romani, o chiunque altro, vogliono: «Mi sono andato convincendo che la condizione ideale dell’uomo – ovvero quella in cui può dare il meglio di sé – non sia quella della prosperità, della pace, e dell’armonia che tanto m’impegnai a restituire a Roma». In altre parole, ha eretto il proprio impero su un abbaglio.
I finali con questa dolorosa ironia sono tipici in Williams. C’è una somiglianza fortissima, ad esempio, col finale di Butcher’s Crossing, quando i cacciatori di bisonti tornano finalmente alla civiltà dopo la macellazione per scoprire che, durante i mesi in cui sono stati via, il mercato delle pelli di bisonte è crollato – il che significa che tutta la loro fatica, tutte le macellazioni, le privazioni e i sacrifici, sono stati vani. In Augustus l’ironia emerge dolorosamente in una breve appendice che assume la forma di uno dei molti documenti che l’autore inventa grazie alla sua straordinaria fantasia: una lettera scritta, quarant’anni dopo la morte dell’imperatore, dall’ormai anziano medico greco che lo ha assistito sul letto di morte. In essa il medico, dopo aver retto alle crudeltà del regno di Tiberio e alle follie di Caligola, celebra l’avvento di un nuovo imperatore che «possa finalmente realizzare il sogno di Augusto». Quell’imperatore è Nerone.
E tuttavia Williams non vede nei suoi eroi dei falliti; né dovremmo farlo noi. Nella lunga intervista che ha concesso pochi anni prima della morte, ha sottolineato, ancora una volta, che per lui Stoner è “un vero eroe”:
«Un sacco di persone che hanno letto il romanzo pensano che Stoner abbia avuto una vita terribilmente triste e miserabile. Io penso che abbia avuto un’ottima vita […]. Ha fatto quello che voleva, si appassionava a quello che faceva, ha compreso l’importanza del lavoro che svolgeva. Ha portato la testimonianza di valori importanti […]. Devi avere fiducia».
«Avere fiducia»: forse questi personaggi sono diventati persone molto diverse da quelle che pensavano sarebbero dovute diventare, ma quello che hanno compreso è che le vite che hanno vissuto sono “loro stessi” – gli edifici che devono abitare e che devono trovare il coraggio di abitare da soli.
Questo è un sapere tragico, ma non necessariamente triste. Alla fine della relazione extra-coniugale che minaccia quella modesta vita che, con tanta meticolosità quanta confusione, ha creato, Stoner con dolcezza dice alla sua amante, Katherine, che almeno non si sono compromessi: «Mentre almeno, fino a ora, siamo rimasti noi stessi. E sappiamo di essere… quello che siamo». William Andrews ritorna dalla caccia al bisonte con la vaga consapevolezza che il suo sogno di armonia con la Natura era un’illusione superficiale e che le lezioni che l’incontro con le terre selvagge gli hanno dato erano diverse da quelle che aveva immaginato di imparare – le “nobili bugie” che un compagno più vecchio e rancoroso rigetta con sprezzo: «non c’è nient’altro, nient’altro che te stesso e quello che avresti potuto fare». Come nelle tragedie greche, i romanzi di Williams mostrano il processo per il quale «quello che avresti potuto fare» viene pian piano rimosso da un personaggio, lasciandolo solo con ciò che ha fatto – ovverosia, quel sedimento che è “te stesso”.
Accade la stessa cosa all’Imperator Caesar Divi Filius Augustus, che nelle ultime pagine del romanzo di Williams abbraccia stoicamente la verità di cui il collega di Andrews si lamenta amaramente:
«Sono ormai convinto che nella vita di ogni uomo, presto o tardi, giunge il momento in cui egli prende coscienza, più chiaramente che mai, e a prescindere da quanto riesca ad ammettere, della terribile realtà della sua condizione; del fatto che è solo, e separato dagli altri; e che non può che essere la misera creatura che è».
Questa è la conclusione a cui molte delle ottime biografie e alcune delle migliori opere di narrativa giungono. «La misera creatura che è» difficilmente sono i termini in cui molti di noi penserebbero al primo imperatore romano. Il romanzo di Williams riesce nell’impresa di farcelo pensare alla conclusione del libro e di farci ritenere quella una fine soddisfacente.
Traduzione di Simone Traversa
Articoli sullo stesso libro