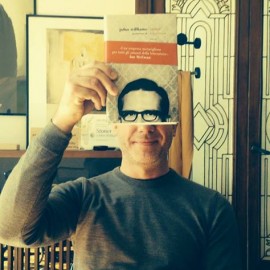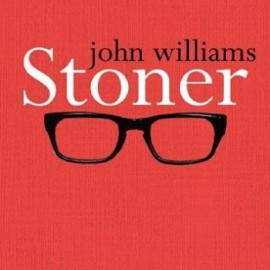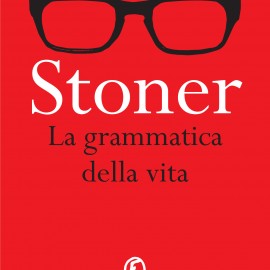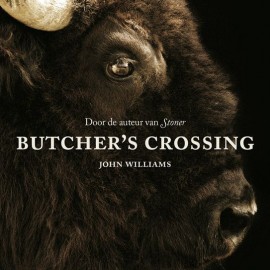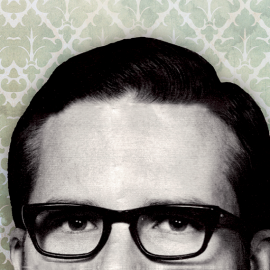Ritratto di John Williams. Parte quarta
• Il blog di Fazi Editore - Recensioni
Pubblichiamo l’unico testo in circolazione sulla vita di John Edward Williams, apparso sul «Denver Westword» il 3 novembre 2010.
Con Augustus Williams iniettò ossigeno nel genere del romanzo epistolare e finalmente attirò l’attenzione dell’establishment letterario – o parte di esso, ad ogni modo. Nel 1973 il romanzo vinse il National Book Award, ma Williams dovette dividere il premio di mille dollari con un altro vincitore, John Barth, autore di Chimera. Qualcuno aveva insinuato che il premio costituiva un tentativo di risarcimento per aver ignorato Stoner sette anni prima, ma il pareggio indicava anche l’emergere di uno scisma nel mondo dei libri, tra sperimentale e tradizionale, tra forme vecchie e nuove.
Williams accettò l’onorificenza con classe e sostenne che non gli interessava avere mille o cento lettori. Non si era mai aspettato di diventare ricco da questo lavoro e riceveva ogni assegno, non importava quanto modesto, come un regalo inatteso che debba essere speso immediatamente. Sapeva che quella sua personale versatilità gli rendeva impossibile diventare quello che Greenberg chiama «uno scrittore affidabile», qualcuno che, come Stephen King, consegna un prodotto affidabile per lettori che vogliono semplicemente più quantità della stessa cosa – e per questo non sarebbe mai stato un autore-marchio.
D’altra parte anche il premio non riuscì a far molto per le vendite di Augustus e qualche amico intravide un risentimento latente da parte di Williams nei confronti dell’industria editoriale. «Pensavo fosse uno scrittore maledettamente talentuoso», sostiene Epstein, «viveva i rifiuti con sdegno, e aveva ragione. Non c’era ragione al mondo perché i suoi libri dovessero essere rifiutati. Mi chiedo come riuscisse a controllarsi».
«Ma questa è una delle cose interessanti di quando beveva. Tutto il suo rancore era messo da parte e riemergeva quando inaugurava le sue sbronze notturne, indirizzato sempre alle persone sbagliate. Poteva diventare molto aggressivo».
La dipendenza alcolica di Williams era passata inosservata durante le feste di facoltà in quelle estati a base di alcol a Bread Loaf. «Spero tu sia licenzioso, dissoluto, ubriaco, gonfio e felice, anche se tutto ciò sarà la tua dannazione», così gli scrisse Ciardi nel 1971. Ma gli effetti divennero più evidenti col passare del tempo, così come quelli del suo tabagismo. L’alcolismo pose una distanza nel suo rapporto con gli Epstein e con altre amicizie.
«Mi faceva soffrire molto», afferma Greenberg, «Glielo dissi: “John, se io avessi il tuo talento, mi prenderei cura di me”. Ma lui era bravissimo a far finta di niente».
«Poteva essere molesto con le parole», prosegue Nancy, «diceva cose cattive. Beveva un poco ogni giorno e troppo il sabato. Poi andava nel suo studio e non scriveva».
Alla fine degli anni Settanta a Williams fu diagnosticato un enfisema. Iniziò a presentarsi al campus con una bombola d’ossigeno legata addosso, ma si rifiutava di lasciare che questo interferisse con la sua classica routine di insegnamento. Faceva un tiro di sigaretta e poi uno di ossigeno e allora riprendeva la lezione.
I suoi ultimi anni alla Denver University furono contraddistinti da problemi di salute e da una crescente irascibilità: si lamentava della condizione in cui versava l’istruzione, delle nuove e brutte costruzioni in vetro del centro, del modo in cui Denver stava iniziando a diventare “falsa”, come tanti altri luoghi. I medici lo assillavano a spostarsi in una località più vicina al livello del mare, dove avrebbe potuto respirare meglio.
I programmi di scrittura creativa delle università erano tantissimi in tutto il paese. Denver, attaccandosi a quella che Zaranka descrive come “un’estetica conservativa”, si dava da fare per mettersi al passo coi tempi. Williams non dirigeva più il programma, e alcune divergenze tra colleghi che negli anni si erano approfondite avevano reso quel luogo meno accogliente di quanto lo fosse stato in passato.
«Adoravo John, ma c’erano persone che non la pensavano allo stesso modo», afferma Miloksky, «qualcuno pensava che si comportasse come un grande scrittore. Il fatto è che lui era un grande scrittore. È da notare che non ci furono altre lamentele su di lui».
Andò in pensione nel 1985. Lui e Nancy si trasferirono a Key West, dove vivevano alcuni amici intellettuali come Richard Wilbur e James Merrill; ma trovarono le strutture ospedaliere troppo limitate per le loro esigenze. Quindi si sistemarono a Fayetteville, in Arkansas, dove molti degli ex compagni della Bread Loaf insegnavano all’Università statale.
Poco dopo la partenza di Williams da Denver, Robert Pawlowski, che successe a Williams come direttore del programma di scrittura, lo nominò a una carica onorifica dell’Università, «Non avrebbero potuto dire niente», ricorda Pawlowski, «C’era un po’ di acrimonia nei confronti di John tra i piani alti dell’amministrazione, stupide minuzie, immagino. Ma era la personalità più importante del dipartimento».
Un po’ di feste gli furono fatte, infine, il 29 marzo 1986, con una serie di reading e incontri, sia all’Università sia alla biblioteca pubblica, tutti incentrati sul nuovo lavoro di Williams. L’ospite d’onore arrivò in macchina da Fayetteville e ne approfittò per ricevere complimenti e rivedere i vecchi amici; in alcuni casi per l’ultima volta. Un’edizione speciale del «Denver Quarterly», la rivista letteraria che Williams aveva fondato venti anni prima, fu dedicata interamente ai suoi scritti, interviste e al suo lavoro.
La chicca dell’edizione fu un lungo brano tratto da The sleep of reason, un romanzo sulla guerra e i falsi d’arte che Williams aveva iniziato dopo Augustus. Per certi aspetti la nuova opera suggeriva il suo progetto più ambizioso fino a quel momento. Anche se molte scene sono ambientate a Washington nel periodo del Watergate, «il romanzo si espande nel tempo e nei luoghi, a partire dal Quattrocento fino all’invasione napoleonica dell’Italia, e dalla Berlino degli anni Trenta fino alla Seconda Guerra Mondiale, sia in Italia che in Birmania», così aveva appuntato in un formulario per una domanda di borsa di studio.
Il libro aveva preso la sua prima ispirazione in un viaggio che Williams fece in Portogallo con Nancy nel 1976, durante il quale aveva iniziato un racconto vagamente romanzato della sua disavventura di guerra, quando si perse nella giungla con altri commilitoni. Dopo cinquanta pagine abbandonò la bozza. «Era troppo vicina alla sua esperienza personale», continua Nancy, «Diceva di annoiarsi».
Williams trovò uno spunto più promettente in un articolo che scrisse per «Esquire», un memoir di un curatore d’arte che era stato catturato e torturato dai giapponesi e che aveva trascorso i venti anni successivi nel tentativo di metabolizzare il trauma. Williams annusò il potenziale della storia, quello di essere una storia di esplorazione d’identità, sulla consolazione dell’arte e sui traumi della guerra (quello che oggi chiamiamo post traumatic stress disorder).
Nel 1980 aveva scritto un centinaio di pagine, comprese alcune scene mozzafiato sulla cattura dell’eroe da parte dei giapponesi. Poi entrò in ospedale per un’operazione ai polmoni, la cui ripresa impiegò molti mesi. Non esistono indicazioni per cui possiamo pensare che abbia mai scritto oltre The sleep of reason o altri testi di narrativa, negli ultimi suoi dieci anni di vita.
«Ha sempre sperato di tornare a lavorare a quel libro, ma le sigarette e l’alcol chiesero il conto», così Nancy, «credo sia la ragione principale perché non abbiamo quel romanzo magnifico».
Dopo il trasferimento a Fayetteville, la University of Arkansas Press ripubblicò tutta la sua opera, e la biblioteca universitaria acquisì i suoi manoscritti e appunti. Williams aveva tenuto un corso lì, un favore fatto a degli amici, ma lo trovò troppo impegnativo per le sue forze, tanto che a un certo punto chiese a Greenberg di sostituirlo per una settimana.
«Cosa trovai? Molto amore da parte degli studenti», ricorda Greenberg, «venivano da tutto il paese e allora gli chiesi cosa ci fossero venuti a fare a Fayetteville e loro mi dissero, “John”».
Per lo più rimaneva a casa, riceveva amici e osservava con estremo interesse gli scoiattoli o gli uccelli che si contendevano il cibo fuori della finestra del suo studio. Ogni settimana si rimetteva in sesto per accogliere la signora delle pulizie, una donna di campagna di mezza età molto semplice con cui poteva discorrere per ore.
E poi c’era un nuovo viaggio all’ospedale, le infermiere e le terapie in day hospital, «Non si aspettava di vivere così a lungo». «Ci siamo detti addio centinaia di volte. Se ne stava sdraiato lì e respirava così a fatica. Diceva che quasi non ne valeva la pena. Ma io ascoltavo la parola “quasi”».
Morì di insufficienza respiratoria il 3 marzo 1994.
Qualche anno prima aveva pensato di utilizzare un verso di Ortega y Gasset come epigrafe a Stoner , «Un eroe è colui che vuole essere se stesso». Aveva compreso fin troppo bene che le persone che sembrano programmate per cambiare il mondo finiscono per esserne cambiate loro stesse, e qualche volta ne sono distrutte. Dunque chi, come Stoner, ha perseguito il proprio lavoro come una vocazione ha avuto la migliore occasione, non per sopravvivere (chi può?), ma per diventare se stesso. Per John Williams era tutto quel che contava.
Articoli sullo stesso libro