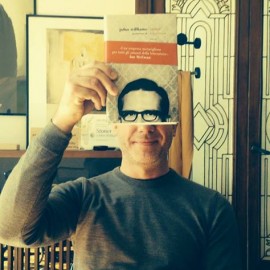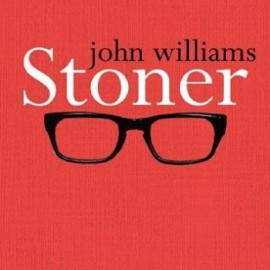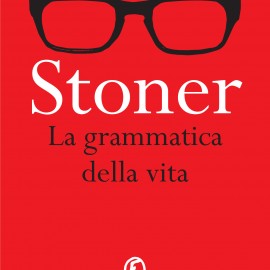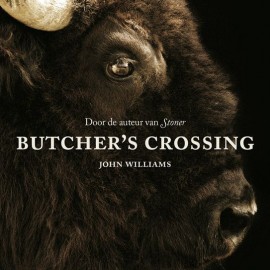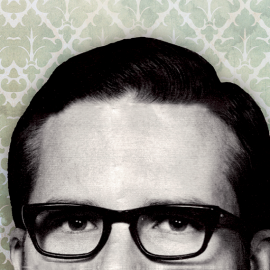Ritratto di John Williams. Parte seconda
• Il blog di Fazi Editore - Recensioni
Pubblichiamo l’unico testo in circolazione sulla vita di John Edward Williams, apparso sul «Denver Westword» il 3 novembre 2010.
Poco dopo il suo ritorno a Denver, iniziò a leggere molta letteratura dell’Ovest. Ciò che vi trovò fu molto materiale di bassa qualità, opere celebrative e stupide storie di pistoleri che pretendevano di raccontare come le persone vivevano e lottavano in quell’angolo di finestra temporale che oggi associamo al selvaggio West. Anche scrittori sofisticati tendevano a romanticizzare la regione. «Il tema del West è passato attraverso un processo di insulsa standardizzazione», scrisse Williams in un manifesto personale su «The Nation», «da parte di una fila di delinquenti letterari… uomini sprezzanti delle storie che hanno da raccontare, delle persone che le animano e dei paesaggi dentro i quali si svolgono».
Williams iniziò a riflettere su come descrivere al meglio l’esperienza della frontiera, gli elementi aspri della natura e le ampiezze spaventose dei luoghi. La storia che emerse da tali riflessioni racconta di un tale Will Andrews, un giovane che lascia Harvard nel 1870 e si dirige a ovest, colmo dell’ideale emersoniano sulla Natura e desideroso di avventure, che sperimenterà il mondo selvaggio innanzitutto in se stesso. Poco dopo il suo arrivo nel desolato villaggio del Kansas Butcher’s Crossing, il ragazzo decide di finanziare quella che sembra essere una delle ultime grandi cacce al bisonte, in un tempo in cui l’animale era stato annientato dal contrabbando. Miller, un cacciatore attempato, guida la spedizione verso una mandria di mille capi in una valle nascosta nel territorio del Colorado; è un uomo ossessionato dall’uccidere fino all’ultimo esemplare; gli uomini rimangono intrappolati dall’improvviso arrivo dell’inverno nelle montagne e Andrews impara presto a conoscere l’indifferenza della Natura più di quanto si fosse mai preoccupato di scoprire.
Butcher’s Crossing rappresenta un notevole balzo in avanti dalla prima aulica prova di Williams, sia per la scrittura che per l’argomento. Ogni aspetto delle traversie di Andrews, dai momenti di tedio all’agonia di cavalcare per giorni interi lungo una prateria deserta fino all’insensata mattanza e allo scuoiamento di miglialia di bisonti, alla lotta per la sopravvivenza per mesi in territori di montagna, è rappresentato in vividi e splendidi dettagli. Eppure la prosa è austera e quasi insopportabilmente imparziale, il racconto esposto nitidamente e lucidamente anche quando affonda nel brutale macello:
Miller sparava, ricaricava, sparava e ricaricava ancora.
Il fumo acre della polvere s’infittiva intorno ai due uomini.
Poiché ormai tossiva e respirava a fatica, Andrews abbassò
la testa verso il terreno, dove il fumo era più sottile.
Quando la rialzò, vide che la pianura davanti a sé era coperta
di cadaveri di bisonti, mentre il resto della mandria
– che sembrava essersi ridotta di poco – continuava a girare
in tondo quasi meccanicamente, come seguendo un
ritmo cieco, scandito dalle esplosioni regolari del fucile di Miller.
L’agente di Williams presentò il manoscritto a un concorso nazionale per la narrativa sponsorizzato dall’editore Macmillan. Vinse il secondo premio, guadagnando 25.000 dollari e un contratto. Pubblicato nel 1960, Butcher’s Crossing vendette meno di 5.000 copie. Nessuno sapeva come promuoverlo; il «New York Times» lo assegnò a un recensore di Western pulp, che esaltò Williams. Un editore di paperback lo volle per ripubblicarlo, ma solo se la dicitura “un western” fosse apparsa in copertina. Williams rifiutò.
Insieme al romanzo Warlock di Oakley Hall, Butcher’s Crossing fu uno dei primi romanzi seri sul West. Nel giro di pochi anni quest’opera pioneristica sarebbe stata in buona compagnia, scrittori come Cormac McCarthy e Larry McMurtry e registi come Sam Peckinpah e Robert Altman iniziarono a reinventare il mito del West o a ridurlo all’osso per vedere cosa vi si nascondeva all’interno. Ma a Denver, Williams fu conosciuto come lo scrittore di “western” –anche se la sua storia di ideali che si infrangono sul terreno mortale dell’esperienza parla di molto più che di una caccia al bisonte, così come Moby Dick è molto più di un racconto sulla caccia alla balena.
Dopo la sua morte, la vedova di Williams aprì il libro per la prima volta dopo molti anni e studiò di nuovo l’incredibile passaggio del massacro della mandria, che va avanti per quaranta pagine.
«Mi colpisce molto che l’intensità di questo passaggio venga dalla sua personale esperienza della seconda guerra mondiale», afferma Nancy Williams «Aveva visto così tanta morte, così tanti omicidi insensati».
Negli anni Sessanta il dipartimento di Inglese dell’Università di Denver crebbe del doppio, e poi ancora raddoppiò. Tale ampliamento prese il via dalla creazione di corsi di scrittura per gli studenti del primo anno, precedentemente gestito da un dipartimento di comunicazione, ma segnò anche un’esplosione di baby boomer e di ex studenti che approdavano ai campus del college, l’aumento della popolazione regionale e un interesse crescente nei programmi avanzati di scrittura creativa.
Quando Gerald Chapman si insediò come nuovo direttore agli inizi degli anni Sessanta, divenne l’ottavo membro del dipartimento; nel 1959 erano solo quattro. Quando, otto anni dopo, Chapman si dimise, la facoltà era arrivata a ventotto membri. «C’era qualcosa di molto speciale lì», ricorda oggi Chapman, «uno spirito di gruppo che non ho mai visto in nessun altro luogo. John si prodigò perché questo accadesse».
Oltre all’insegnamento della prosodia, del romanzo moderno e di altri corsi di Letteratura Inglese, Williams aveva trasformato il programma di scrittura creativa in uno dei più impegnativi del paese, ragionando sul fatto che la maggior parte degli scrittori avrebbero dovuto procurarsi dei lavori di insegnamento per potersi mantenere. A un candidato dottorando in scrittura creativa era richiesto di sostenere la stessa mole di corsi dei candidati dottorandi in Letteratura Inglese, e nel mentre di produrre una composizione a scelta tra un romanzo o un libro di poesie.
«Diceva che non ha fatto mai male a uno scrittore essere istruito», ricorda lo scrittore David Milofsky, che ha insegnato all’Università di Denver negli anni Ottanta e che oggi è alla Colorado State University. «Vorrei che più persone avessero quella stessa sensibilità».
«Era uno di quei pochi dipartimenti del paese in cui gli scrittori non erano in guerra tutto il tempo con gli accademici», afferma Bob Richardson, che subentrò a Chapman e rimase in carica per ventisette anni.
«Cercavano di coinvolgere scrittori che erano aperti alla possibilità che anche i ricercatori potessero essere brillanti, e dall’altra parte ricercatori che rispettassero gli scrittori. Grazie a John e alla sua imparzialità la cosa funzionò. Divenne senza dubbio il dipartimento più vivace e gratificante in cui io abbia mai insegnato».
I docenti di inglese erano un gruppo molto affiatato, se si pensa ai momenti di socializzazione e alle feste. E l’alcol era un lubrificante essenziale degli incontri, in particolare quelli in cui Williams era coinvolto. Quando Richardson fece domanda per la prima volta per un posto alla Denver University, fu spedito a fare un colloquio che si tenne a chilometri di distanza dalla città. «La parte più consistente del colloquio avvenne in montagna in una piccola baita a bere un po’ troppo», ricorda. «In questo modo scoprivano in poco tempo chi eri oltre le apparenze. Non erano interessati ai diplomi prestigiosi. Questa è la grandezza di Denver: ciò che importa non è da dove vieni, ma se sei in grado di lavorare».
Il senso di appartenenza si trasmise anche agli studenti laureati, che in alcuni casi erano coetanei o anche più anziani di questo giovane corpo insegnante. Dopo aver concluso le sue lezioni, immerso nella nebbia delle sue sigarette, Williams si trasferiva al Campus Inn scortato da un gruppetto di studenti.
«John sarebbe stato il primo a passare la palla e poi potevi parlare di letteratura per due o tre ore di fila», dice Bill Zaranka, che arrivò da dottorando nel 1969, in seguito diresse il programma di scrittura creativa ed è oggi rettore emerito alla Denver University. «Ricordo di essere stato invitato in più occasioni a casa sua. Non era uno che parlava molto; parlava di tutto tranne che della sua scrittura. Ma potevi essere certo di sapere da che parte stava».
Williams aveva standard alti per i suoi studenti. Alcuni dei suoi allievi lo trovavano troppo brusco, troppo sprezzante nei confronti di scritture che lui non riteneva fossero notevoli. Poteva essere disorganizzato nel suo approccio con l’assegnazione di elaborati e totalmente disinteressato ai trend modaioli di letteratura o di critica letteraria. Ma altri lo ritennero un amico generoso e un buon ascoltatore, un critico brillante e incisivo e molto differente dallo stereotipo del professore.
«Veniva dalla strada più difficile», continua Phill Doe, che studiò con Williams a partire dal 1968 e con cui rimase amico per tutta la vita, andando spesso ad aiutarlo nella cura di quel suo ampio giardino sul retro in South Madison Street. «Era un grande ammiratore di Willa Carther e di tutti quelli che erano fuori dal mainstream, persone di umili origini con eccellenti talenti letterari». Pensava che l’istruzione fosse una faccenda molto intima. Lui ti apriva la porta, il resto stava a te. Qualcuno lo accusava di essere pigro nell’insegnamento e di essere più interessato alla scrittura, ma io durante le sue lezioni non lo avrei detto».
Un workshop di scrittura tenuto da Williams non era quella specie di terapia di gruppo che oggi trovi nei programmi dei master, e d’altra parte non era nemmeno un rito di umiliazione. «Criticava un racconto per essere “il grande racconto che era ancora nella testa del suo scrittore” – non si soffermava sulla singola pagina», sostiene Joe Nigg, che frequentò la Denver University negli anni Settanta e che ha firmato diversi libri sugli animali mitologici. «Non era affatto cattivo. Non aveva niente a che fare con la personalità dello scrittore».
Joanne Greenberg aveva un tale rispetto per Williams che gli chiese di valutare alcuni dei suoi lavori in corso; una curiosa apertura per un autore affermato, di cui d’altra parte lei non si pentì mai. «Lui era il professore navigato», afferma. «Non c’era posto per ego né imbarazzo. Quando ricevevi un suo parere era sempre sul tuo lavoro e il tuo lavoro era importante. Non sono mai uscita da un colloquio avuto con lui senza essere di buon umore».
Williams non viziò mai i suoi studenti, ma ripose molte ambizioni nei confronti di quelli che sembravano promettenti. Michelle Latiolais, ora scrittrice e docente di Inglese all’Università della California a Irvine, ricorda il suo stupore, ai tempi in cui si stava per laureare alla Denver University, quando Williams le si avvicinò al termine di una lezione con una pila di libri sotto il braccio e le disse: «ignora tutto ciò che hai ascoltato fin’ora. Leggi questi».
«Avevo appena deciso di non partecipare a un workshop che lui riteneva inutile. Stavo sperimentando un tipo di scrittura che John credeva non potesse essere insegnato, ma sapeva che avrei trovato tutti gli strumenti necessari nei grandi scrittori».
Latiolais riconosce che alcuni studenti erano intimiditi da Williams. Altri erano a loro agio nel fargli visita al suo studio, facendosi largo tra i mucchi di carta e i libri sparpagliati e scolando un bicchierino di Wild Turkey dalla bottiglia che Williams teneva sulla sua scrivania per accompagnare quelle conversazioni rarefatte. Ma quel che tentava di imprimere nelle menti dei suoi studenti era il grande rischio che implicava la natura del loro lavoro: «John puntava il dito verso la finestra, verso il mondo “reale” e diceva: “lì fuori, quella è una performance da dilettante” La verità era sulla pagina, grazie al mestiere e all’artificio. Era molto rigoroso ma mai distruttivo. Era semplicemente molto serio su quel che stavamo facendo».
Anche se gli impegni del mondo reale si moltiplicarono, Williams lavorava sodo al suo progetto rischioso, un romanzo sulle implicazioni negative di una vita dedicata allo studio e all’insegnamento. È la storia di un ragazzo di campagna, mandato a studiare dalla famiglia all’università del Missouri presso la facoltà di Agraria (una storia ambientata quarant’anni prima che Williams arrivasse a Denver); ma al contrario si innamora perdutamente della letteratura.
William Stoner è uno studente impacciato, ma serio. Ha un brutto matrimonio, che è raccontato in una delle più cupe lune di miele della letteratura. È un ricercatore distaccato e impiega anni prima di capire come accendere una scintilla nella mente dei suoi scarsi allievi. Ha una figlia destinata all’infelicità, una storia d’amore con una dottoranda destinata a finire, e una lunghissima faida con un collega che gli rovina la carriera. I sacrifici che fa pur di mantenere quel che ha e che ama di più, sono orribili e in fondo inutili. Eppure alla fine, Williams un giorno aveva appuntato di avere “più di quello che la maggior parte di noi ottiene: la propria identità”.
Aveva il sospetto che, con dieci anni di ritardo, stesse scoprendo chi era; e la persona che vedeva era allo stesso tempo più simile e più diversa rispetto a quella che aveva immaginato. Sentiva che finalmente cominciava a essere un insegnante, ovvero un uomo che semplicemente dice quel che sa, traendo dalla sua professione una dignità che ha poco a che fare con la follia, o la debolezza, o l’inadeguatezza dei suoi comportamenti privati.
Williams scrisse il romanzo a mano per qualche anno, lavorando a partire da appunti dettagliati e schemi. Ci sono un paio di revisioni in cui si intravede la bozza originale – un’incredibile prodezza per un libro così attento nel suo linguaggio. Malgrado possa sembrare una materia algida e poco promettente, il romanzo è a tratti appassionante, furioso, doloroso e commovente. In un capitolo, partendo dalla descrizione di un esame orale, Williams crea delle pagine di puro dramma e suspense che non si trovano nemmeno nei romanzi commerciali di James Patterson.
Nel percorso disastroso di Stoner siamo tentati dal sentire l’eco del tormento personale dell’autore.
Il terzo matrimonio di Williams stava crollando quando scrisse il romanzo; prima del divorzio trascorreva parte della settimana con la sua famiglia e parte con Nancy, un’insegnante ed ex dottoranda con dei figli. Ma un’interpretazione biografica tanto semplicistica sminuisce quel personaggio vivido e carico di emozioni che Williams ha creato, un uomo imperfetto che il lettore arriva a conoscere intimamente e a soffrire per lui. Stoner è «uno dei pochi personaggi che muoiono davvero in un romanzo», scrisse una volta Harry Crews, a testimonianza della potenza del traguardo raggiunto dal suo creatore.
Sarebbe difficile immaginare un progetto più fuori moda dalla scena degli anni Sessanta: il periodo di Age of Aquarius, del Vietnam, della psichedelia, di James Bond, Mailer e Capote. Stoner fu rifiutato da sette editori. Dopo il settimo rifiuto Williams disse a Nancy, «Beh, non devo proprio scrivere romanzi».
«Mi spaventò a morte», prosegue, «sapevo quanto fosse tenace e che lo diceva sul serio». All’ottavo tentativo, un giovane editor di nome Corlies Smith, che aveva scoperto talenti dimenticati come Jimmy Breslin o Thomas Pynchon, riuscì a convincere i piani alti di Viking a dare una chance a Stoner. Le vendite furono misere. Ma come la vita del suo protagonista, il libro si sarebbe affermato come un singolare successo nel tempo, nascosto sotto gli inutili paramenti del fallimento.
Articoli sullo stesso libro