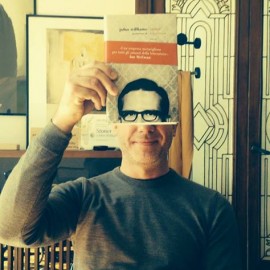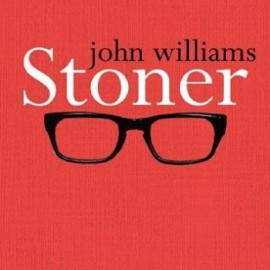John Williams, trauma a San Francisco
• Il blog di Fazi Editore - Recensioni
Pubblichiamo l’articolo di Caterina Ricciardi uscito il 20 aprile, su Alias.
Che nelle soste fra un’offensiva aerea e un’altra la guerra lasci al milite spazio per la scrittura di un romanzo suona esorcizzante: c’è da vedervi un inconsapevole atto salvifico, un modo per rimettere i piedi a terra e ingannare il fato provando a eternare il proprio nome in un qualcosa che idealmente resti. Questo deve essere successo a John Williams – l’autore di Stoner – quando, dal 1942 al 1945, era di servizio sul fronte asiatico, fra India e Birmania, da cui tornò (vivo) con un manoscritto consegnato alle stampe nel 1948: Nulla, solo la notte (trad. di Stefano Tummolini, Fazi, pp. 138, €13,50). Era il suo primo romanzo, per lungo tempo dimenticato, come d’altronde i successivi.
C’è da chiedersi, tuttavia, se il teatro di morte, e non, come sembrerebbe, un oscuro magma biografico, non abbia una parte nella storia psichica messa in scena in Nulla, solo la notte, in cui Williams diluisce una giornata della vita di Arthur Maxley, un uomo giovane profondamente a disagio con se stesso e gli altri, disturbato da memorie felici e terribili, depositate nella sua coscienza nell’infanzia.
Arthur vive le sue ore guidato da una coscienza onirica in una notte dell’anima, un mondo di cupe tenebre: «Era come se ogni giorno si levasse da un sepolcro notturno per tornare ad affliggere la terra»; in sconsolato ricordo del «tempo perduto» legato all’estate e alla madre; in conflittuale relazione con il padre, un uomo d’affari, che lo assiste solo finanziariamente, e con il quale, dopo un lungo distacco, ha un incontro all’Hotel Regency, un epidermico contatto che pare quasi risolversi in una riconciliazione, impedita dall’intervento di un’apparizione scioccante.
Qualcosa è successo in quel passato perduto; Arthur non riesce «a cancellare dalla lavagna della sua memoria l’immagine di quella notte, l’orrore di quel momento». Questo è il ‘punctum’ misterioso del romanzo che, proiettato anaforicamente nella reliquia di una fotografia, si risolverà solo nel penultimo capitolo. L’ultimo, da cui ci si aspetta una possibile catarsi, lascia invece Arthur, e il lettore, su una strada aperta.
A far da sfondo alla giornata buia di Arthur Maxley è, a differenza della Dublino di Joyce, un’irriconoscibile San Francisco di cartapesta, trasformata, contrariamente al mito e alla realtà, in una città tenebrosa, infernale: un appartamento in disordine, scale buie, salotti artefatti, serate alcooliche, squallidi caffè, luci vistose, suoni assordanti e una «moltitudine di gente mostruosamente anonima», famelica. È questa la città in cui, dopo il lusso del Regency, Arthur ci guida fino a un ritrovo dove si accenderà la scintilla necessaria a ricomporre la frattura subita nell’infanzia.
Come per omeopatia. è qui, nel degrado, che Arthur ricostruisce visionariamente il trauma vissuto e individua una piccola verità sulla vita: «Ecco cosa univa gli uomini e le donne: non l’incontro delle loro menti e delle loro anime, non la coniugazione dei corpi nell’oscura follia della copula. Niente di tutto ciò. Era il bisogno sottile di creare un vincolo, un legame più fragile del merletto, più delicato. Era per questo che lottavano incessantemente. ( … ) Soltanto per quel piccolo filo, che non potevano mai misurare, per paura di distruggerlo; soltanto per quel piccolo filo delicato, che non potevano mai annodare, per paura di spezzarlo in due».
La qualità della scrittura di Williams è superba (come la traduzione di Tummolini): immagini e metafore, parole potenziate, vengono fatte lievitare in una prosa aerea tanto lieve quanto sferzante, di contro a una storia dura, enigmatica e violenta, capace di raggiungere acmi surrealiste, una storia forse pretestuosa che, ai suoi tempi, avrebbe attirato Hitchcock, e che preferiamo lasciare in suspense. Sul piano letterario i richiami intertestuali sono numerosi: un Proust molto meno sdolcinatamente nostalgico; un Poe magistrale interprete della città come affollata psiche urbana; e soprattutto un Henry James che da il tono nel muovere le corde della memoria come fa «una bestia dal profondo della giungla», per lasciar galleggiare nell’aria di San Francisco solo la medusea minaccia della «violenta immagine di quella scena violenta».
Articoli sullo stesso libro