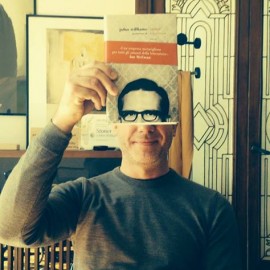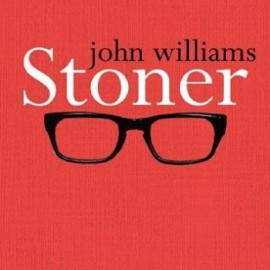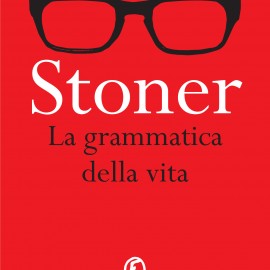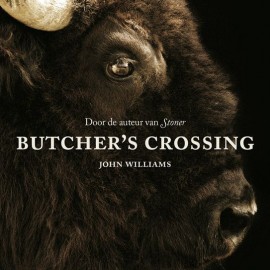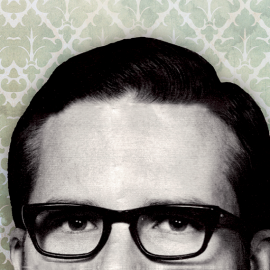Dovete davvero leggere subito Stoner
• Il blog di Fazi Editore - Recensioni
Pubblichiamo la traduzione di Valentina Bortolamedi dell’articolo di Steve Almond apparso il 9 maggio 2014 sul «The New York Times».
Quindici anni fa, sul finire di una festa universitaria ad alto tasso alcolico, un mio amico mi prese da parte e mi sbatté in mano una copia del romanzo Stoner. In quel periodo ero in fissa con una serie di autori tossici e quindi diedi per scontato che Stoner fosse una storia di degenerazione psicotropa. Ma il libro era tutto un altro tipo di viaggio.
Il romanzo segue la vita di un professore universitario di nome William Stoner, un uomo dimenticato dai suoi studenti e colleghi, e dalla storia stessa. L’autore, il tardo John Williams, lo annuncia nella prima pagina. È come se ci sfidasse a lasciar perdere il libro. Io lo divorai tutto in una volta. Non avevo mai letto un libro tanto spietato nella sua devozione alle verità umane e tanto delicato nel suo svolgimento.
Mi rendo conto che è il genere di affermazione che tutti i lettori infatuati fanno sui loro libri preferiti, quindi lasciate che vi mostri l’esempio di questo breve passaggio sulla relazione extraconiugale che Stoner comincia per rifugiarsi dal suo matrimonio infelice:
«Quand’era giovanissimo, Stoner pensava che l’amore fosse uno stato assoluto dell’essere a cui un uomo, se fortunato, poteva avere il privilegio di accedere. Durante la maturità, l’aveva invece liquidato come il paradiso di una falsa religione, da contemplare con scettica ironia, soave e navigato disprezzo, e vergognosa nostalgia. Arrivato alla mezza età, cominciava a capire che non era né un’illusione né uno stato di grazia: lo vedeva come una parte del divenire umano, una condizione inventata e modificata momento per momento, e giorno dopo giorno, dalla volontà, dall’intelligenza e dal cuore».
Non mi sembra ci sia altro da aggiungere.
Dalla sua pubblicazione nel 1965, Stoner è andato due volte fuori catalogo, condannato dalla sua trama piatta e dallo stile sobrio. Ma sulla strada verso gli scaffali del remainder successe una cosa curiosa. Grazie a una legione di discepoli, molti dei quali scrittori di spicco (e insieme a loro Tom Hanks, che consigliò il libro in un’intervista al «Time»), Stoner diventò “Il piccolo capolavoro dimenticato”. Alla sua prima uscita vendette solo duemila copie, ma l’anno scorso Stoner è stato in cima a tutte le classifiche di vendita europee e si è inserito in maniera stabile nelle discussioni letterarie sul canone americano. Un critico, addirittura, si è talmente stufato degli elogi accumulati sul romanzo che di recente ha pubblicato una filippica – piuttosto controproducente – contro la sua popolarità.
Soprattutto, però, questa storia di resurrezione letteraria rafforza la nostra percezione che la posterità non dovrebbe riguardare le tendenze editoriali o i budget di marketing. Herman Melville aveva immaginato che Moby Dick sarebbe stato il suo capolavoro e rimase sconcertato quando fece fiasco. Il grande Gatsby è stato per anni considerato un’opera minore. E la lista continua. Orwell, sono parole ormai famose, ha sostenuto che l’unico vero critico letterario è il tempo.
Ma c’è qualcosa di diverso, elettrizzante e sovversivo nella rinascita di Stoner. Di sicuro sto esagerando, come fanno i fanatici, ma trovo tremendamente incoraggiante che Stoner stia prosperando in un mondo in cui le forze capitalistiche sono così determinate a distrarci dall’angoscia inevitabile delle nostre vite interiori. Stoner afferma che ciò che ci definisce più di tutto è la nostra capacità di affrontare la verità di chi siamo nei momenti privati, non la brillantezza del nostro io pubblico. In altre parole, costituisce una condanna feroce della realtà culturale di oggi – che guarda caso è stata scritta più o meno cinquant’anni fa.
Di recente ho organizzato un gruppo di lettura ben assortito su Stoner. A un certo punto un uomo anziano si è alzato in piedi per rivolgersi alla sala. Era evidentemente indignato; aveva le guance rosso fuoco. «Perché dovrei leggere di questo perdente?», ha chiesto. «Si rifiuta di lottare per il suo paese. Il suo matrimonio è un incubo. Al lavoro si lascia perseguitare. Non fa mai nulla».
È calato un silenzio imbarazzato, rotto soltanto da un secondo uomo che ha osservato, in modo pacato ma non meno coinvolto, che a lui sembrava di leggere della propria vita, e che William Stoner sarebbe potuto essere lui».
Io ero d’accordo con entrambi.
William Stoner è, per molti versi, un uomo poco rilevante, introverso e passivo. Non riesce nemmeno a proteggere la figlia dai folli capricci della difficile moglie. La storia della sua vita non è un eccezionale crescendo di assiduità e trionfo, ma qualcosa di più simile alle nostre vite: un miscuglio di desideri e inibizioni e compromessi.
Questo rende difficile per alcuni lettori, fra cui l’uomo anziano, vedere che Stoner fa anche delle scelte coraggiose. Diligente figlio di un povero contadino, scopre il potere della letteratura al college e persegue la sua vocazione. Fatica per rendere onore alla missione dell’insegnamento e si lascia andare a un’appassionata storia d’amore che sa finirà rovinosamente. Questi avvenimenti non vengono messi in scena sul grande palco della storia, ma nelle piccole stanze del suo luogo di lavoro e di casa sua. La lezione più profonda di Stoner è questa: ciò che rende una vita eroica è la qualità dell’attenzione che vi si pone.
Leggere il libro oggi è riconoscere quanto è diventata superficiale la nostra concezione dell’eroico. Gli americani venerano atleti, magnati e star del cinema, quelli che possiedono i doni scintillanti che per noi equivalgono a valore e felicità. Le storie che lampeggiano sui nostri schermi tendono a essere inni di lode all’ambizione sfrenata. Potremmo anche aver voglia di guardare un dramma su un mite insegnante di scienze di scuola superiore, ma solo se questo degenera in un pezzo grosso dello spaccio con tendenze omicide. Accidenti, perfino le nostre biografie letterarie devono raccontare una storia in stile vita spericolata per raggiungere un pubblico vasto.
Per quanto riguarda William Stoner, lui è l’archetipo letterario dell’uomo medio elevato all’ennesima potenza – un timido medievalista che passa la vita in mezzo ai testi antichi. Guarda all’Università con sincera riverenza, come un santuario per quelli che ancora credono nel mondo delle idee. Molto prima del suo pensionamento, all’interno del campus inizia a essere considerato un relitto. Oggi verrebbe considerato qualcosa più simile a un fossile.
Non è solo il fatto che oggi siamo tutti presi da oggetti onniscienti delle dimensioni di barrette di cioccolato. È l’accelerazione sbalorditiva del nostro metabolismo intellettuale ed emozionale: la nostra fame di scalpore e ricompensa narcisistica, la nostra prontezza a privilegiare l’azione alla contemplazione. E, soprattutto, la nostra disperata ossessione di essere conosciuti dal mondo invece di cercare la conoscenza.
Gli americani non sono sempre stati così. Come osservava lo storico Warren Susman – e come Susan Cain ripete nel suo recente libro sull’introversione, Quiet, – il ventesimo secolo ha dato inizio al passaggio da una “cultura del carattere”, che enfatizzava l’importanza del nostro comportamento privato, a una “cultura della personalità”, in cui il ruolo sociale importante è quello del performer.
Mentre gli americani si spostavano dalle piccole comunità rurali all’anonimato delle grandi città, mentre erano costretti a competere per essere considerati in luoghi di lavoro sempre più frenetici e ambienti sociali, le prime impressioni sono diventate più importanti delle sottili virtù che uno potrebbe coltivare nell’arco di una vita. La comparsa di una massiccia cultura della pubblicità ha rinforzato la nozione che gli americani stiano più o meno sempre su un palco e quindi abbiano costantemente bisogno di costumi adatti e materiale di scena. Se l’antico ideale era stato di condurre una vita all’insegna del pensiero, l’obiettivo moderno è diventato condurre una vita all’insegna dell’esposizione.
Le conseguenze di questo cambiamento paradigmatico non sono mai state più evidenti. Pensiamo alla quotidiana parata dei talent show in prima serata e dei documentari animati in cui chef, prestatori su pegno e casalinghe annoiate reinventano le loro vite private in chiave teatrale.
E questo è quello che sta capitando anche al resto di noi. Pensiamo alle società in crescita nel settore tecnologico: compagnie di social media come Facebook e Twitter, applicazioni “guardami” come Instagram e Snapchat, siti di condivisione di contenuti come YouTube e Pinterest che fungono da fonti di marketing personale. Se vuoi stare fra quelli che contano, e non sei dotato di talenti divini o lignaggio regale, be’, allora fai un po’ di rumore. Esponi la tua personalità – o i tuoi progetti o le tue lamentele o le tue spiritosaggini – al pubblico.
Altrimenti finirai come il povero Stoner – una nota a piè di pagina nella grande storia dell’uomo.
Ma non siamo quasi tutti note a piè di pagina, in fondo? I sogni che coviamo, alla fine, non lasciano sempre il posto alla realtà delle nostre vite?
Come eroe romanzesco, William Stoner dovrà rimanere nell’ombra per sempre. Ma anche questo è il nostro destino. Le nostre azioni più significative, vizi e virtù, eroismi e villanie, saranno conosciuti solo da quelli a noi più vicini, e presto dimenticati. Anche i nostri sentimenti più profondi, per la maggior parte, rimarranno nascosti nella cripta del nostro cuore. Uno dei motivi principali per cui elaboriamo sgargianti fantasie di fama è distrarci da queste dolorose verità. Confessiamo così tanto a così tanti, come se con queste aperture potessimo fuggire al terrore di affrontare il nostro io più nascosto. Ciò che rende Stoner un’opera d’arte tanto radicale è il fatto che ritrae questo conflitto non come una tragedia, ma come la fonte essenziale della nostra redenzione.
E questa redenzione, ad ogni modo, non si verifica nella forma di rivelazione religiosa. Stoner non contiene quasi nessun riferimento a Dio. Invece, la rivelazione è innescata dalla letteratura. Il romanzo è degno di nota in quanto creazione artistica perché pone una fede tanto profonda nell’arte. (Questo è anche ciò che lo rende così irresistibile per gli scrittori).
Verso l’inizio del libro, un docente poco rassicurante recita il settantatreesimo sonetto di Shakespeare alla classe: «Questo tu vedi, che fa il tuo amore più forte, a degnamente amare chi presto ti verrà meno». Alza lo sguardo su Stoner – uno studente di agricoltura che spera solo di soddisfare un prerequisito – e chiede cosa significhino questi versi. Stoner non ha idea di cosa dire. Sa solo che la poesia ha innescato in lui uno strano sconvolgimento. È come se, dopo anni di torpore, si risvegli improvvisamente di fronte al miracolo della coscienza. Il cielo e gli alberi acquisiscono un’intensità quasi insopportabile. Percepisce lo scorrere invisibile del proprio sangue nelle vene. I suoi compagni di corso sembrano illuminarsi dall’interno, e lui si sente «a un tempo molto vicino e molto distante da loro». È il momento in cui acquisisce la consapevolezza della propria anima.
O forse sarebbe più preciso dire che semplicemente comincia a fare attenzione alla propria vita.
Presto, il destino lo sconfigge. Il suo matrimonio degenera nell’orrore domestico. Sua figlia precipita nella disperazione. Un’assurda faida mina la sua carriera. Non subisce alcuna delusione riguardo al proprio posto nel mondo. Si rende conto che gli altri lo trovano assurdo e che i suoi contributi al suo arcano ambito sono, bene che vada, minori. A ripetizione, Stoner è costretto ad affrontare le sue debolezze, i suoi limiti in quanto figlio e padre e marito e accademico. E comunque si rifiuta di arrendersi.
Mentre Stoner giace in punto di morte, il suo creatore osserva: «Una morbidezza lo avvolse e un languore gli attraversò le membra. La coscienza della sua identità lo colse con una forza improvvisa, e ne avvertì la potenza. Era se stesso, e sapeva cosa era stato».
Quanti possono dire lo stesso di sé?
Traduzione di Valentina Bortolamedi
Articoli sullo stesso libro