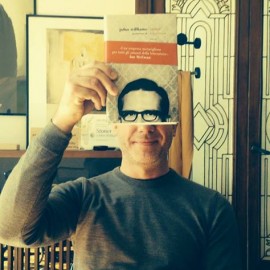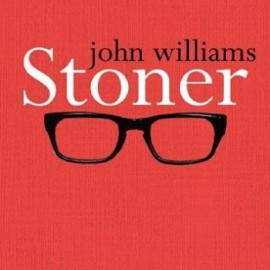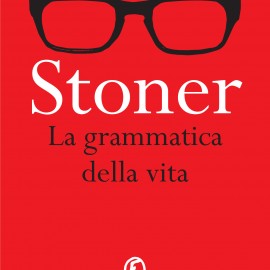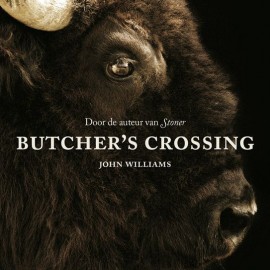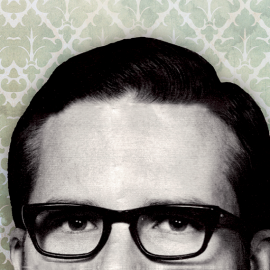Ritratto di John Williams. Parte terza
• Il blog di Fazi Editore - Recensioni
Pubblichiamo l’unico testo in circolazione sulla vita di John Edward Williams, apparso sul «Denver Westword» il 3 novembre 2010.
Dopo Stoner, Williams vide la propria agenda sempre più impegnata da inviti come visiting professor o come relatore di conferenze. Era incoraggiato nel fare domanda e ricevette importanti finanziamenti e riconoscimenti. Non aveva molti lettori, ma erano quelli giusti: alti principi e satrapi dell’accademia e dell’industria editoriale.
Un anno dopo l’infelice debutto, il grande intellettuale Irving Howe incensò Stoner sulle pagine del «New Republic», generando una scia di rinnovato interesse verso il romanzo ormai già messo fuori catalogo. Iniziò così a diffondersi un culto tra gli assistenti, che si scambiavano le poche copie a disposizione come se contenessero la chiave della loro vocazione. Alla Denver University, la copia della biblioteca aveva una spaccatura sulla costa di copertina, gli studenti si preparavano agli orali disquisendo del cortocircuito tra Stoner (un classicista) e la sua nemesi intellettuale (un romantico).
Tra i fan del romanzo c’era il poeta e traduttore di Dante John Ciardi, che dirigeva il più antico e prestigioso workshop di scrittura del paese: il Bread Loaf Writer’s Conference, nel Vermont. Ciardi invitò Williams a raggiungere lo staff di un convegno di due settimane e questi ne divenne un frequentatore abituale per i successivi sette anni, fino a quando Ciardi non lasciò il workshop nel 1972. Per Williams si trattava di una fuga dalla routine intensa e divertente, un’occasione per entrare in contatto con il mondo letterario fuori da Denver. Intrecciò forti legami con molti “prof” che incontrò, compreso Ciardi stesso, Dan Wakefield, Isaac Asimov, Diane Wakoski, Harry Crews e con il poeta Miller Williams. In molti casi li convinse ad andare a Denver per tenere dei corsi.
«Era capace di parlare di scrittura meglio di chiunque altro conoscessi, in un modo che aiutava le persone a scrivere», ricorda Miller Williams. «Molti scrittori ne parlano, ma non puoi utilizzare niente di quello che ti dicono».
Durante gli anni di Ciardi, Bread Loaf fu anche un bar galleggiante per cattivi ragazzi dediti alla scrittura. I bloody mary venivano serviti prima di pranzo, e l’ora della bevuta vera iniziava nel pomeriggio e si protraeva fino alla notte. Nancy riteneva che l’intera faccenda fosse troppo fuori controllo e raggiunse suo marito in Vermont solo una volta.
«Non avevo programmato di andare», sostiene, «avevo i figli piccoli ed era difficile partire. Ma i suoi amici mi chiamarono e mi dissero “Nancy, per favore vieni. John è così solo e non vuole dormire con nessun altro”».
«Era una festa delle vanità», ricorda lo scrittore Seymour Epstein, che incontrò Williams nel 1966, quando erano entrambi al Bread Loaf per la prima volta, «si beveva molto e si parlava molto».
Entrambi veterani della Seconda Guerra, Epstein e Williams si piacquero subito. Williams invitò Epstein (che aveva pubblicato l’acclamato romanzo Leah nel 1964 ma che non si era laureato), a insegnare per un anno a Denver. E successe che Epstein entrò a far parte della facoltà e ci rimase per venti anni. Sy e sua moglie, Miriam, divennero amici intimi di Williams e Nancy e ogni estate, i due uomini partivano insieme in macchina per Bread Loaf.
«Era un’avventura», Epstein ricorda i viaggi, «John non era un conversatore semplice. Parlavo quasi sempre io. Intorno alle tre o alle quattro era come se si accendesse la luce. John aveva bisogno di un drink e a quel punto avveniva il cambio di personalità».
Il bere, sottolinea Epstein, portava il suo amico fuori dal guscio. Ma a quel punto andava avanti troppo a lungo «di solito veniva da noi e rimaneva fino all’una, alle due, alle tre del mattino. Avevamo gli occhi di fuori dal tempo che passavamo ad ascoltarlo».
C’erano degli omissis nella conversazione. Williams non parlava mai della guerra con Epstein. E non amava parlare di lavoro, né del suo, né di quello degli altri.
«Pensava fosse inopportuno, una cosa da dilettanti parlare della scrittura degli altri», afferma Epstein, che oggi ha 92 anni e continua a scrivere. «Non mi avrebbe mai offerto il lavoro se non avesse letto il mio lavoro. Ma non ricordo che abbia mai detto niente sulla mia scrittura».
Epstein sapeva che il suo amico lo aveva invitato a far parte del programma della Denver University in parte per poter concedere a se stesso più tempo per scrivere. Ma Williams parlava di rado del testo a cui stava lavorando, un romanzo così profondamente diverso dai suoi precedenti, come lo era stato Stoner da Butcher’s Crossing. Parlava di un momento di svolta della storia antica, che era stato esplorato da tutti, da Shakespeare alla casa di produzione MGM: l’assassinio di Giulio Cesare e l’ascesa di suo nipote Ottaviano insieme agli intrighi che riguardavano Cleopatra, Bruto, Cicerone, Marco Antonio e tanti altri.
Williams non era interessato a scrivere un romanzo epico tipo quello di Cecil B. DeMille o a imitare Robert Graves. Era particolarmente intenzionato ad evitare un’interpretazione “moderna” dell’antica Roma. (Determinato nel non mettere in scena un Henry Kissinger in toga, si legge in un appunto). Ma era affascinato dalla sfida che rappresentava il lavoro a partire da un frammento storico per giungere a rappresentare un racconto immaginario ma plausibile di come Ottaviano divenne l’imperatore Augusto, a scapito delle sue amicizie, dei suoi ideali di gioventù, anche della sua stessa figlia, che arrivò ad esiliare per adulterio. Per lo più grazie a un’indicazione di Irving Howe, Williams ottenne un finanziamento dai Rockfeller che gli permise di visitare l’Italia e di andare in cerca dei luoghi dove si erano svolti i fatti storici. Trascorse molte ore setacciando testi antichi che fossero stati tradotti.
Scriveva lentamente e con grande attenzione, come sempre, lavorando in uno studio al piano superiore della sua casa, scrivendo a mano o su una macchina da scrivere Remington. «Iniziava alle otto, si portava su il caffè e scriveva per circa tre ore», ricorda Nancy. «Scrivere una pagina per lui voleva dire che era stata una buona giornata. Due o tre pagine erano un successo. Non accadeva spesso. Poi scendeva e pranzava. Poi se ne tornava su per pianificare il lavoro del giorno successivo, e passavano altre due o tre ore».
Il romanzo risultò come una serie di lettere e di pagine di diari di cortigiani e di spie, da Cicerone e Marc’Antonio alla figlia dell’imperatore Giulia e infine dallo stesso imperatore, Ottaviano. Il melange dei tanti personaggi e delle tante voci divenne una meditazione incredibile, polifonica, sull’evanescenza del potere e sulla volatilità dell’impero. Non c’è Kissinger in toga; nella sua veste tragica è più simile a Il Padrino in 3d, ma con un tocco di grazia salvifico.
Gli imperi non durano, così impariamo, ma le storie su di essi sì.
Articoli sullo stesso libro