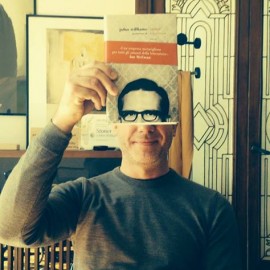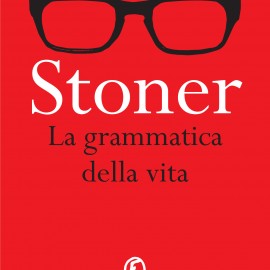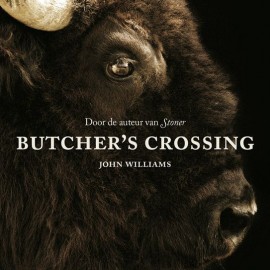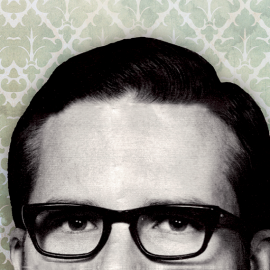Perché Stoner è un vero eroe
• Il blog di Fazi Editore - Recensioni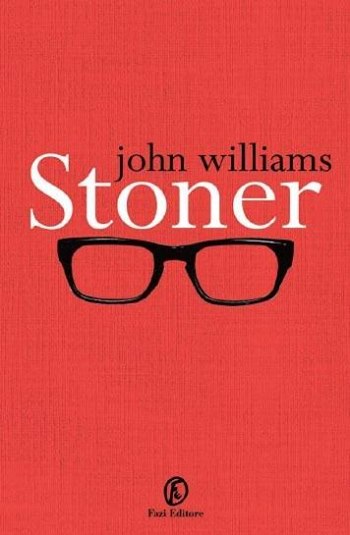
Pubblichiamo l’articolo pubblicato su La lettura di Bret Easton Ellis sul capolavoro di John Williams: Stoner.
Un romanzo è sempre un dischiudersi della coscienza, sia per i personaggi che popolano la finzione narrativa, sia per i lettori che la riproducono nella loro mente a mano a mano che esplorano il terreno creato dall’autore. Certi romanzi sono più diretti nel rivelarsi — talvolta brutalmente didascalici, nella loro ansia di assicurarsi che il lettore capisca tutto — mentre altri si muovono nella direzione opposta, in modi più tortuosi. Sono pochissimi gli scrittori capaci di dar vita a quel magico equilibrio, fatto di schietta semplicità che poi diventa raffinato lirismo. Lo scrittore americano John Williams (1922-1994) vi riesce mirabilmente in Stoner (1965). La vicenda della riscoperta di Stoner, a quarant’anni dalla sua pubblicazione, è una di quelle storie rincuoranti che danno speranza a ogni scrittore. Accolto da buone critiche ma da scarse vendite, Stoner, come la maggior parte dei romanzi, sparì nel nulla in breve tempo. Aveva tuttavia uno sparuto gruppo di ammiratori e, grazie alla ristampa di qualche anno fa, ha venduto quasi un milione di copie in trentacinque Paesi, soprattutto per merito del passaparola dei lettori. Il successo di Stoner ha fatto da traino alla ripubblicazione di altri due romanzi: Butcher’s Crossing (1960) e Augustus (1972).
Quando ho sentito parlare per la prima volta di Stoner, ho pensato che la gente me lo consigliasse solo perché il titolo sembrava rimandare al mondo della droga, per cui l’ho ignorato senza dargli troppa importanza. Ma continuavano a parlarmene e così alla fine l’ho comprato. Ho scoperto che Stoner parla in realtà di William Stoner, un ragazzo di campagna che riesce a entrare all’università del Missouri nel 1910 per poi diventare lì docente fino alla sua morte nel 1956. Con semplicità e grande forza espressiva, vengono passate in rassegna le delusioni che ne scandiscono la vita, e che la rendono deprimente solo in apparenza, perché siamo portati a identificarci con Stoner: i suoi fallimenti sono i nostri. Il romanzo è lucido nella sua compassione e, sebbene verso la fine ci si possa commuovere per il protagonista, risulta rassicurante perché l’idea di fondo è che non si è mai soli nella sofferenza: tutti soffriamo. Ma è lo stoicismo di Stoner di fronte al dolore e alla perdita a rendere così singolare questo romanzo. La sua portata drammatica sta tutta nell’atteggiamento di serena accettazione del protagonista verso ciò che gli accade. Questa passiva resistenza è ciò che lo rende un libro eccezionale, proprio perché diverso dalla maggior parte dei romanzi, dove il protagonista è sempre parte attiva nella catena di eventi drammatici che si dipana intorno a lui.
Butcher’s Crossing, pubblicato cinque anni prima di Stoner, presenta un impianto narrativo più convenzionale, nonostante il protagonista abbia qualche caratteristica in comune con Stoner: lo stoicismo di fronte alla futilità del tutto, la perdita dell’innocenza, la morte incombente, il senso di sconfitta.
Siamo nel 1873, e Butcher’s Crossing è una cittadina del Kansas — in realtà, un insediamento, un’idea non ancora realizzata — dove un giorno arriva William Andrews, un giovane sui vent’anni appena uscito dall’università di Harvard e partito dalla natìa Boston verso ovest, animato da vaghi propositi avventurosi. William è un sognatore, uno che ha ancora in testa le lezioni di Emerson e che dice frasi come «Voglio solo saperne di più su questo Paese», quando gli chiedono come sia finito a Butcher’s Crossing.
Un conoscente di suo padre, pastore della Chiesa Unitariana, lo indirizza a un uomo di nome Miller. Quando Miller gli racconta di quella volta in Colorado in cui, mentre piazzava trappole per castori, si è imbattuto in una gigantesca mandria di bufali in una valle dove secondo lui nessuno aveva ancora mai messo piede, una corda nascosta vibra nell’animo di William. Il giovane si offre di finanziare una spedizione: un carro, cavalli, provviste. Anche qui, le motivazioni sono vaghe, approssimative. «… Capì che la battuta di caccia che aveva concordato con Miller non era che uno stratagemma, un trucco per ingannare se stesso, per blandire le sue abitudini più radicate. Non erano certo gli affari a condurlo laggiù, dove ora stava guardando e dove stava per andare. Partiva in completa libertà». Miller gli promette di condurlo in una valle delle Montagne Rocciose dove i bufali pascolano a migliaia. Così William, attratto e sedotto dal richiamo della natura — tutto quell’Emerson assorbito all’università —, gli affida la metà di una somma ereditata in cambio della possibilità di partecipare alla sua «avventura».
Ed ecco formato il piccolo manipolo di eroi, ciascuno con il suo specifico ruolo: Miller è il cacciatore che spara al bufalo; il pragmatico Fred Schneider lo scuoia; l’assistente di Miller, Charley Hoge, un ubriacone mezzo matto che tiene con sé una Bibbia da due soldi macchiata di sangue di bufalo e che ha perso una mano in una precedente spedizione di caccia con Miller (due immagini che prefigurano l’orrore che seguirà), si occupa della cucina e del campo. William è il testimone.
C’è un’unica donna in questo mondo di uomini: una prostituta di nome Francine, fortemente attratta da William. William ricambia i suoi sentimenti, ma è combattuto perché si tratta di una puttana, anche se Francine si mostra perfettamente in pace con la vita che conduce a Butcher’s Crossing. «Dev’essere una vita terribile, la sua», le mormora William quando lei va a trovarlo, la sera prima che gli uomini partano per la caccia. Non ci sarà una storia d’amore. È il mondo di Miller quello in cui stanno entrando (lui è Achab), ed è qui che un western già insolito si trasforma in un romanzo spietato e refrattario a ogni romanticismo sull’illusione di poter controllare la natura.
Butcher’s Crossing in effetti è un western sotto tutti i punti di vista. E tuttavia, quando l’editore chiese a Williams di dichiararlo in copertina, vista la popolarità del genere a quei tempi, Williams disse di no. È forse tra i western più letterari che io abbia mai letto, ma non ci sono dubbi che sia un western, anticipando di molto l’operazione che Cormac McCarthy e Robert Altman hanno compiuto: il primo con il cruento e allucinato Meridiano di sangue, il secondo con quel capolavoro del cinema di frontiera che è I compari. Butcher’s Crossing distrugge il mito del West, dando vita a una storia dai toni cupi sulla lotta quotidiana per la sopravvivenza, che era poi al centro anche di Stoner. E tuttavia Butcher’s Crossing non è Stoner. Procede per eventi, per momenti d’azione sempre più concitati. La calma ma incontenibile follia di Miller prende quasi subito il sopravvento, mentre il lettore comincia a temere per la sorte degli uomini che nel suo delirio rimangono intrappolati. Se Stoner rappresenta lo stoicismo come scelta di vita, Butcher’s Crossing è lineare e tradizionale, pur contenendo lo stesso sobrio, potente lirismo. Ci sono scene meravigliose, che non ti aspetteresti mai: cavalli assetati che avvertono l’odore dell’acqua e si lanciano al galoppo trascinando con sé carri e uomini in una corsa mortale. Una bufera spaventosa, già annunciata all’inizio, che getta gli uomini nel panico a partire dal primo fiocco di neve, tutti ad eccezione di William, che non comprende subito il pericolo annunciato da quel fiocco e anzi se ne rallegra. Il titolo minaccioso del romanzo promette qualcosa di assai più cruento e spietato di quanto troviamo in Stoner, e ciò ci porta al cuore del romanzo: la carneficina dei bufali per mano di Miller.
La ripugnanza che in fondo William prova verso la caccia ha solo in parte a che fare con l’empatia nei confronti del bufalo ucciso; piuttosto si rivela legata al suo narcisismo giovanile e rispecchia la condiscendenza che riserva a Francine, nel modo in cui ad esempio fugge quando lei cerca di sedurlo: «Si era sentito male ed era fuggito perché l’aveva sconvolto vedere quella bestia, fino a un istante prima ancora orgogliosa, fiera e colma della dignità della vita, nuda e impotente, ridotta a un pezzo di carne inerte, spogliata di se stessa, o della nozione di se stessa, e costretta a penzolare in modo grottesco, beffardo. Quella bestia non era più se stessa; o almeno, non era più quella che aveva immaginato di essere. La sua identità era stata uccisa, e in quell’uccisione Andrews aveva avvertito anche la distruzione di qualcosa dentro di sé che non era riuscito ad affrontare. Ed era fuggito». È la massima concessione ai sentimenti che Williams fa in tutto Butcher’s Crossing, ma anche nei passaggi più lirici il romanzo non scade mai nel sentimentalismo, e il valore morale si ricava dalla precisione del linguaggio, da quella prosa ormai famosa per semplicità ed eleganza. Sono due romanzi che si collocano a pieno titolo nella letteratura americana di metà secolo: nessuna traccia di modernismo, poco o nulla a fare da ornamento.
E non si può leggere Williams attraverso il velo della correttezza politica, come fanno alcuni dei suoi detrattori che lo accusano di misoginia perché l’unico personaggio femminile di Butcher’s Crossing è una prostituta. È William ad avere un problema con Francine, non Francine stessa, né il libro a cui appartiene. È William che non riesce a elaborare il desiderio che prova per lei, e le sue paure sono dettate da una morale che non trova posto nelle lande selvagge di Butcher’s Crossing.
È fin troppo facile compatire Williams per la sorte che gli è toccata, considerarlo un fallito perché non ha venduto molti libri quand’era in vita. Eppure, se vogliamo paragonarlo ad altri scrittori, ha compiuto una parabola di tutto rispetto: ha pubblicato il primo romanzo a venticinque anni; ha vinto il dottorato all’università del Missouri; è stato direttore del programma di scrittura creativa a Denver; è stato il primo direttore ed editore della «Denver Quarterly Review »; si è sposato tre volte; ha avuto tre figli; ha vinto un National Book Award; ha vissuto 71 anni; beveva molto. E ha creato un capolavoro che oggi stanno riscoprendo legioni di lettori, oltre a un paio di ottimi romanzi attualmente in circolazione. Per essere un uomo venuto da una sgangherata fattoria battuta dalle famigerate tempeste di sabbia degli anni Trenta, Williams, nella sua maniera discreta, è una figura eroica quanto il suo personaggio più famoso.
(traduzione di Manuela Francescon)
Bret Easton Ellis
© 2014 BRET EASTON ELLIS
Articoli sullo stesso libro